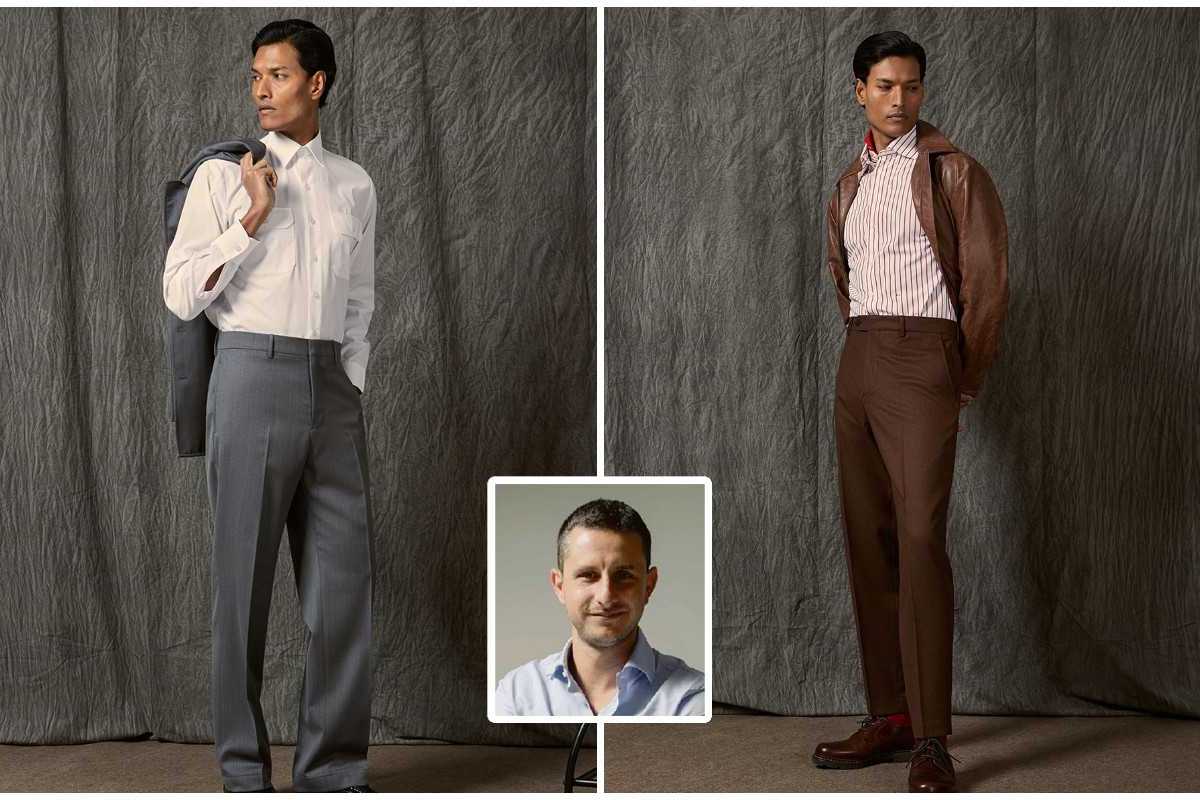«Ho imparato a leggere a cinque anni, nella classe di frate Justiniano, nel Collegio de la Salla, a Cochabamba, in Bolivia. È stata la cosa più importante che mi sia successa nella vita». Musica orale quando parlava nelle conferenze, musica scritta quando mitragliava sulla macchina per scrivere le sue pagine immortali. E 84 anni dopo quella rivelazione, Mario Vargas Llosa si è incamminato verso il paradiso degli scrittori con un premio Nobel sottobraccio (2010) e una granitica convinzione: il suo Aldilà non ha niente di sudamericano. Non è una Macondo di favole ed esoterismi, non è una striscia di polvere dove Che Guevara sgasa con la Norton, non è una landa popolata di gesuiti postmarxisti. Non è il continente immaginario, prodotto del conformismo europeo, dove abita, invecchia e imputridisce la révolucion.
Mario Vargas Llosa - solitario, liberale y final - detestava quegli stereotipi a tal punto da voltare le spalle, poco dopo l’università, alla congregazione degli scrittori omologati per intraprendere da solo, forte del genio e dell’originalità, la scalata verso l’Olimpo letterario. La fascinazione progressista e l’infatuazione per Fidel Castro durarono poco, giusto il tempo (1976) di rifilare un cazzotto sul volto a Città del Messico al più irriducibile dei castristi, Gabriel Garcia Marquez. C’è chi dice per un diverbio politico, chi invece attribuisce la rissa fra top player della letteratura a una storia di donne. Per anni non si parlarono più. Solo nel 2007, nonostante Vargas Llosa fosse rimasto sulle sue posizioni anticomuniste, avvenne una parziale riappacificazione: l’autore peruviano permise la pubblicazione di un suo saggio come introduzione a una nuova edizione di «Cent’anni di solitudine».
Nato ad Arequipa in Perù nel 1936 da una famiglia di latifondisti cotonieri (suo nonno era il console onorario in Bolivia), per una decina d’anni non conosce suo padre. Poiché ha abbandonato la madre, in famiglia fanno credere a Mario che papà Ernesto è morto. Un incipit da romanzo, risolto quando i genitori si rimettono insieme. Incerto se intraprendere la carriera militare o fare il giornalista, comincia a scrivere e a mostrare doti non comuni, affinate all’Università di Lima (dove studia diritto e letteratura) e in un viaggio a Parigi che diventa un mezzo incubo, perché la richiesta di borsa di studio viene respinta e lui è costretto a scrivere per mangiare. È già sposato con Julia Urquidi, di 10 anni piu grande di lui, e da quelle vicissitudini trarrà spunto per uno dei romanzi più felici: «La zia Julia e lo scribacchino».
Ha la seta nei polpastrelli e nessuna affinità con la narrazione terzomondista. Diventa uno dei massimi romanzieri contemporanei nonostante il suo anticonformismo. A ispirarlo è un canone letterario che parte da Gustave Flaubert («mi ha insegnato che il talento significa disciplina tenace e grande pazienza») e arriva a William Faulkner («da lui ho appreso che è la forma a esaltare o impoverire le trame»). Ama Victor Hugo, Miguel de Cervantes e ha un’autentica venerazione per Jorge Luis Borges. Soprattutto perché in lui vede «l’intellettuale che non solo si permetteva di ironizzare sui dogmi e sulle utopie della sinistra, ma che portava la sua iconoclastia sino al punto di affiliarsi al Partito Conservatore, con l’insolente argomento che i gentiluomini si affiliano di preferenza alle cause perse».
«La città e i cani», «Conversazione nella Cattedrale», «La guerra alla fine del mondo» sono capolavori di un grande sudamericano che non sopporta la raffigurazione di un’America Latina stereotipata, prigioniera dei luoghi comuni, «vittima del mito e dell’immaginazione, esattamente come la percepivano gli europei che per primi vi misero piede. Da quel momento l’Europa proietterà spesso sull’America le utopie e le frustrazioni artistiche e ideologiche (anche religiose) nate nel suo seno e condannate, nei paesi latinoamericani, a vivere confinate nei regni dell’illusione».
Da qui deriva la convinzione di una distorsione insopportabile, quella che trasformò in un’allegra «democrazia in cammino» (così la chiamava Jean Paul Sartre) la rivoluzione di Fidel Castro. Obiettava Vargas Llosa: «La sinistra europea continua a promuovere come esemplare una dittatura che si è guadagnata l’onore di essere la più duratura che l’America Latina abbia mai conosciuto e che nessuno accetterebbe nel proprio Paese». Non risparmiò neppure l’infatuazione radicale degli intellettuali europei per il clownesco Subcomandante Marcos: «Regis Debray e Günter Grass furono promotori entusiasti di Marcos e dei suoi zapatisti quando il rivoluzionario mascherato comparve nelle selve dello Yucatan. Avrebbero mantenuto lo stesso entusiasmo se lui avesse cercato di portare a termine la “rivoluzione postmoderna”, come venne chiamata da Carlos Fuentes, non nello Yucatan ma in Bretagna o in Alvernia?».
Formidabile polemista, ha trascorso la seconda parte dell’esistenza a dimostrare gli effetti di questa distorsione. «Molti latinoamericani hanno adottato quelle immagini di sé, alterate dalla fantasia o dall’alienazione religiosa o ideologica occidentale e, invece di incarnare la propria realtà, ne hanno creata un’altra in accordo con quei modelli e miti importati». Un’età dell’oro per la letteratura, un disastro per l’evoluzione politica e sociale di quei Paesi, ancora oggi impegnati (a costo di immani sacrifici) a uscire dall’equivoco dell’eterna Macondo con fabbriche del ghiaccio, fricchettonismo a cielo aperto e pioggia di farfalle.
Liberal-democratico nel profondo, nel 1990 lo scrittore scende in politica per candidarsi nella coalizione di centrodestra (il Frente Democratico) alle elezioni in Perù. Viene sconfitto da Alberto Fujimori, che instaura la dittatura rossa nel Pese compiendo gravi crimini contro l’umanità. Allora Vargas Llosa si trasferisce definitivamente in Spagna, dove lavorava da tempo. E nel 2011 re Juan Carlos lo nomina marchese. Si definisce «uno dei due scrittori al mondo che amano Margaret Thatcher e detestano Fidel Castro» (l’altro sarebbe il poeta inglese Philip Larkin). Partecipa attivamente alla vita politica spagnola, scende in campo contro i secessionisti catalani, bolla il referendum come «tentativo di colpo di stato di una minoranza» e denuncia l’atto eversivo contro la maggioranza della popolazione catalana, contraria alla separazione da Madrid.
Il Vargas Llosa liberale è spiegato benissimo in due saggi pubblicati da Liberilibri: «Sogno e realtà dell’America Latina» con prefazione del ministro Carlo Nordio e «Sciabole e Utopie». Nell’introduzione, Alberto Mingardi coglie il nocciolo di una vita: «L’idealità liberale di Vargas Llosa non è un sistema chiuso e nemmeno un programma politico. È un’attenzione costante alla libertà individuale e alle sfumature che essa può assumere. E un altrettanto costante rifiuto di affogare l’individuo in un “aggregato” variamente definito, di considerarlo un ingranaggio di una più potente macchina collettiva». A conferma del suo liberalismo cosmico e del suo amore per la tradizione, qualche anno fa Vargas Llosa si imbarca nella più perdente delle polemiche: la difesa della corrida. «Ecco le ragioni di una festa crudele: vietarla sarebbe un’enorme perdita per l’arte, la tradizione e la cultura nella quale sono nato». Durante la pandemia tuona: «Molti governi hanno utilizzato il Covid per limitare le libertà e questo è inaccettabile».
Ad annunciare la sua morte a 89 anni, sazio di giorni, sono stati i figli Alvaro, Gonzalo e Morgana. Coloro che gli hanno tenuto la mano. Non essendo degni di chiudere l’articolo lo lasciamo fare volentieri a lui, esattamente come lo ha cominciato parlando del giorno in cui imparò a leggere. «Tradurre le parole dei libri in immagini ha abbattuto le barriere del tempo e dello spazio. Mi ha permesso di viaggiare con il capitano Nemo a ventimila leghe sotto i mari, combattere fianco a fianco con d’Artagnan, Athos, Porthos e Aramis contro i complotti che minacciavano la regina. O spingermi nel ventre di Parigi, novello Jean Valjean, con il corpo inerte di Marius sulle spalle». Un gigante.