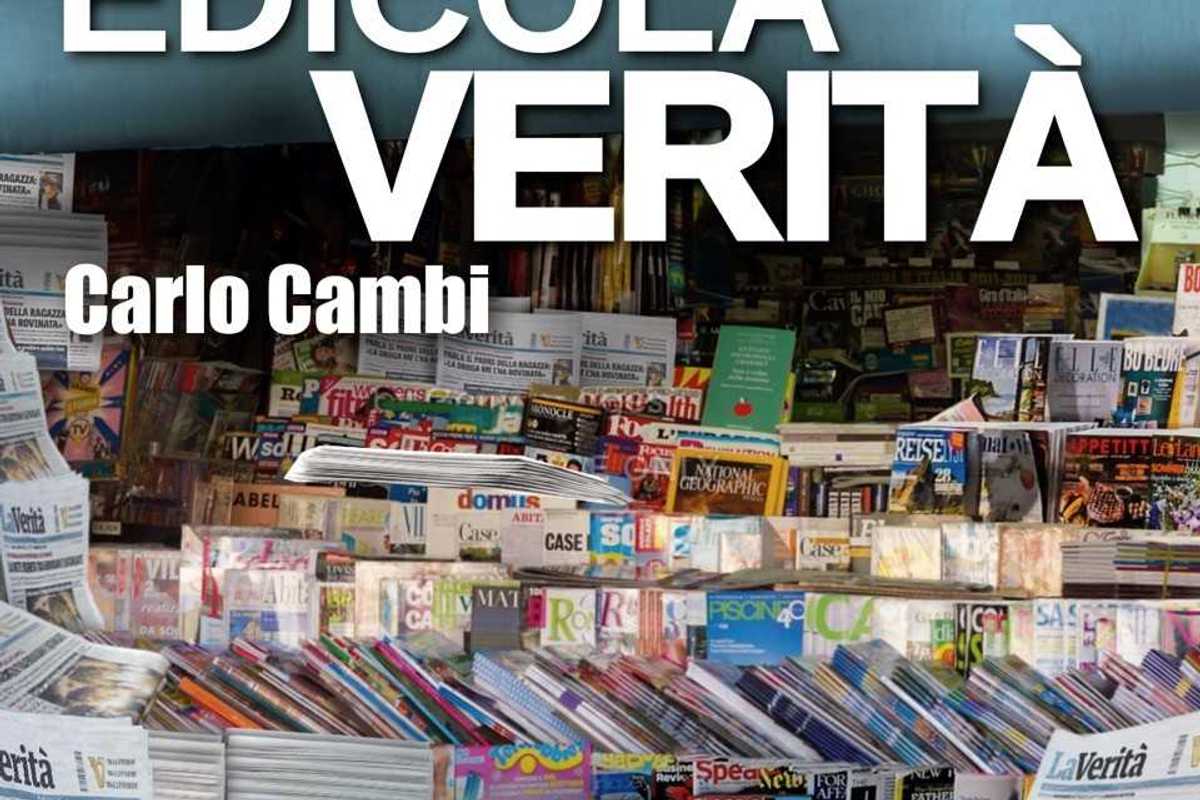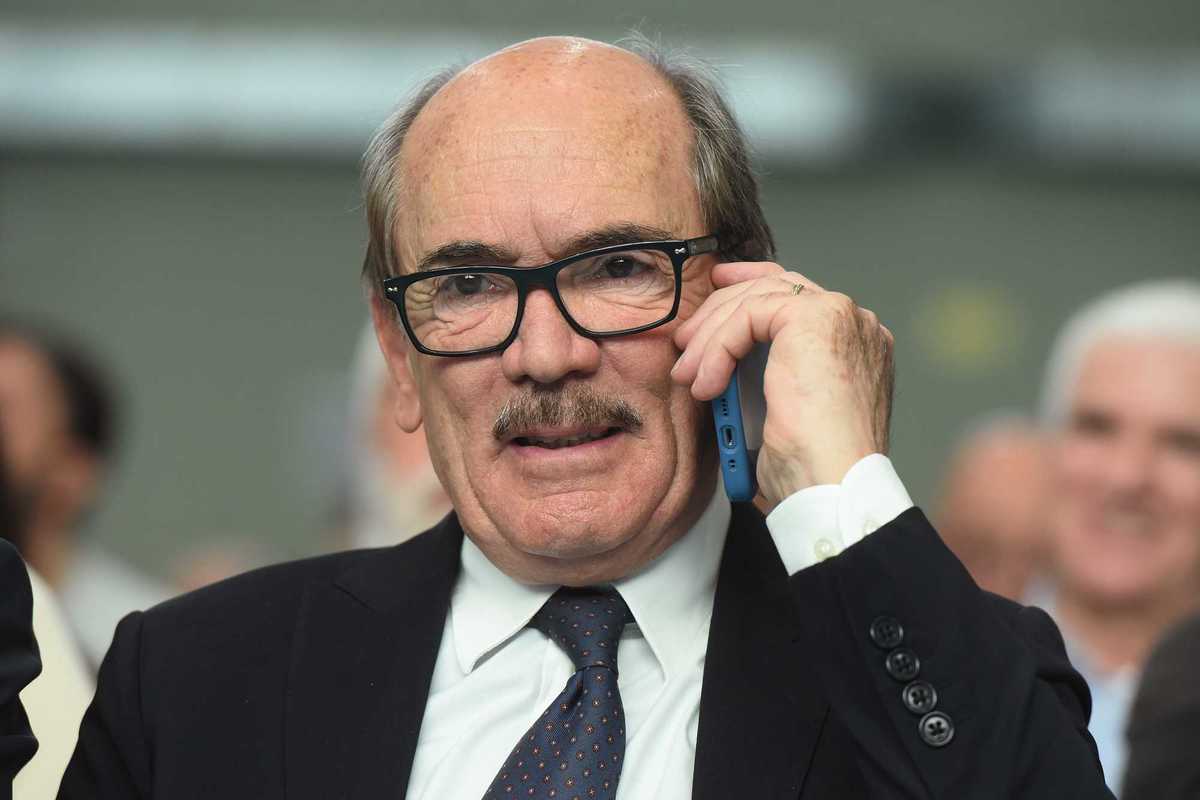Sente premere la domanda, capite? E non è mica una domanda da niente, macché: è una «domanda apocalittica» quella che il teologo Vito Mancuso «sente premere» e che esonda sulle colonne della Stampa. E pure una domanda «decisiva». Una di quelle domande «rispondendo alle quali si ha una rivelazione». Attraverso le quali si riesce a «chiarire quale debba essere il principio guida dell’esistenza». Una domanda «radicale», «esistenziale», una di quelle per cui «non si dorme» o «ci si veglia nel cuore della notte» (ma non importa: «non siamo nati per dormire»). E qual è questa domanda che preme irrefrenabile nel petto del pensatore che non dorme mai?
È la domanda che molti di noi si pongono regolarmente da due anni, cioè da quando è iniziato il Covid. Ma che Mancuso ha scoperto solo con la tragedia in Ucraina e con l’approvazione della proposta di legge sull’eutanasia. Ovvero la seguente: «Vale più la vita o la libertà?».
È bellissima la dissertazione di Mancuso, che scomoda Dante («libertà va cercando»), Virgilio, Pier Delle Vigne, Catone, il Purgatorio, l’Inferno, Bella Ciao, i partigiani, il Giudizio Universale, Cesare, Apollo, Socrate e la Storia (con la s maiuscola) per arrivare a dividere il mondo in due gruppi: chi pensa che sia giusto rinunciare alla vita per difendere la libertà e chi invece è disposto a sacrificare la libertà per difendere la vita. Entrambi, ci spiega, hanno la medesima autorevolezza morale: «La domanda giusta non è chi ha ragione, perché non lo sapremo mai. Qui e ora c’è solo il tribunale relativo della coscienza di ognuno di noi e quindi la domanda giusta è: tu da che parte stai?», chiosa. Mancuso per la cronaca sta dalla parte del primo gruppo, quello di chi è disposto a rinunciare alla vita per difendere la libertà. Lo dice apertamente: «Per un essere umano» non c’è «nulla di più importante del desiderio di libertà». Amen. Del resto, come non amare la libertà? Condividiamo a tal punto l’amore per la libertà che lo condividevamo anche prima che la Russia invadesse l’Ucraina, pensate un po’.
Lo condividevamo anche due anni fa. E un anno fa. E sei mesi fa. E tre mesi fa. Per quanto possa sembrare strano condividevamo l’amore per la libertà quando non c’erano i bombardamenti su Kiev e nemmeno la legge sull’eutanasia. Ma eravamo piuttosto soli. Mancuso, per dire, a differenza di oggi, non si faceva nessuna domanda decisiva né esistenziale. Nessuna domanda apocalittica. Noi sì, lui no. Lui, allora, nel petto non sentiva premere nulla. La domanda sull’alternativa fra vita e libertà si è «imposta» (usa proprio questo termine) con la guerra in Ucraina e con la «materia bioetica» (usa proprio questo termine). Quando invece, durante la pandemia, sono stati negati i più elementari diritti e sono state calpestate le libertà fondamentali, perché si diceva che era necessario a salvare le vite, la domanda non si imponeva. Che ci volete fare? Mancuso è fatto così. Ci sono certe cose che lo svegliano nel cuore della notte. Altre su cui continua beatamente a dormire.
Oggi, per dire, ci spiega che ci si può domandare «vale più la libertà o la vita». E che ognuno può dare la sua risposta. Ma fino a ieri no: fino a ieri se solo provavi, di fronte all’emergenza pandemica, a chiedere se vale di più la libertà o la vita (come ha provato anche a fare Massimo Cacciari sulla medesima Stampa) venivi colpito e affondato. Oggi questi sono interrogativi importanti «rispondendo ai quali si ha una rivelazione». Ieri con questi interrogativi non avevi nessuna rivelazione, al massimo dannazione. Oggi Mancuso scrive che «chi ha ragione non lo sapremo mai». Ieri invece, chi aveva ragione l’avevano già deciso. E non era ammesso dubitare. Oggi quella della scelta tra vita e libertà è diventata una «domanda esistenziale» . Ieri era una domanda criminale. Se la ponevi, passavi seduta stante per delinquente, assassino, sterminatore di vecchietti e nemico dell’umanità. Oggi s’invoca il tribunale delle coscienze. Ieri invece c’era solo la Santa Inquisizione del vaccino.
«Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione», ammoniva infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 6 settembre scorso all’università di Pavia. L’invocazione alla libertà, aggiungeva, «equivale a mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso anche la vita altrui». E quindi non è legittima.
Non è accettabile. Non si può mettere in pericolo non dico la vita altrui, ma nemmeno la salute, per invocare la libertà, diceva. Chissà se anche il capo dello Stato, passando dall’emergenza sanitaria all’emergenza bellica, ha cambiato idea. Chissà se anche per lui oggi l’invocazione della libertà viene prima di tutto il resto. Prima della vita, della salute, dei bimbi ammazzati sotto i bombardamenti, delle bollette alle stelle (copyright Paolo Mieli), delle imprese che chiudono. Se fosse così, noi che rivendichiamo da mesi il diritto a invocare la libertà, ne trarremmo motivo di conforto: vuol dire che, almeno, queste domande «decisive», «esistenziali», «apocalittiche», capaci di chiarire il «principio guida dell’esistenza», che fino a ieri erano scomunicate, oggi si possono finalmente porre. Poi ognuno risponda come vuole, ma almeno si possono porre. È già qualcosa. L’unico punto in cui ci permettiamo di dissentire fortemente dal dotto componimento di Mancuso, il teologo che sente premere le domande, è quando scrive papale papale: «Non siamo nati per dormire». Ecco, questo no. Non lo può dire. Se non fosse nato per dormire, si sarebbe svegliato un bel po’ prima.