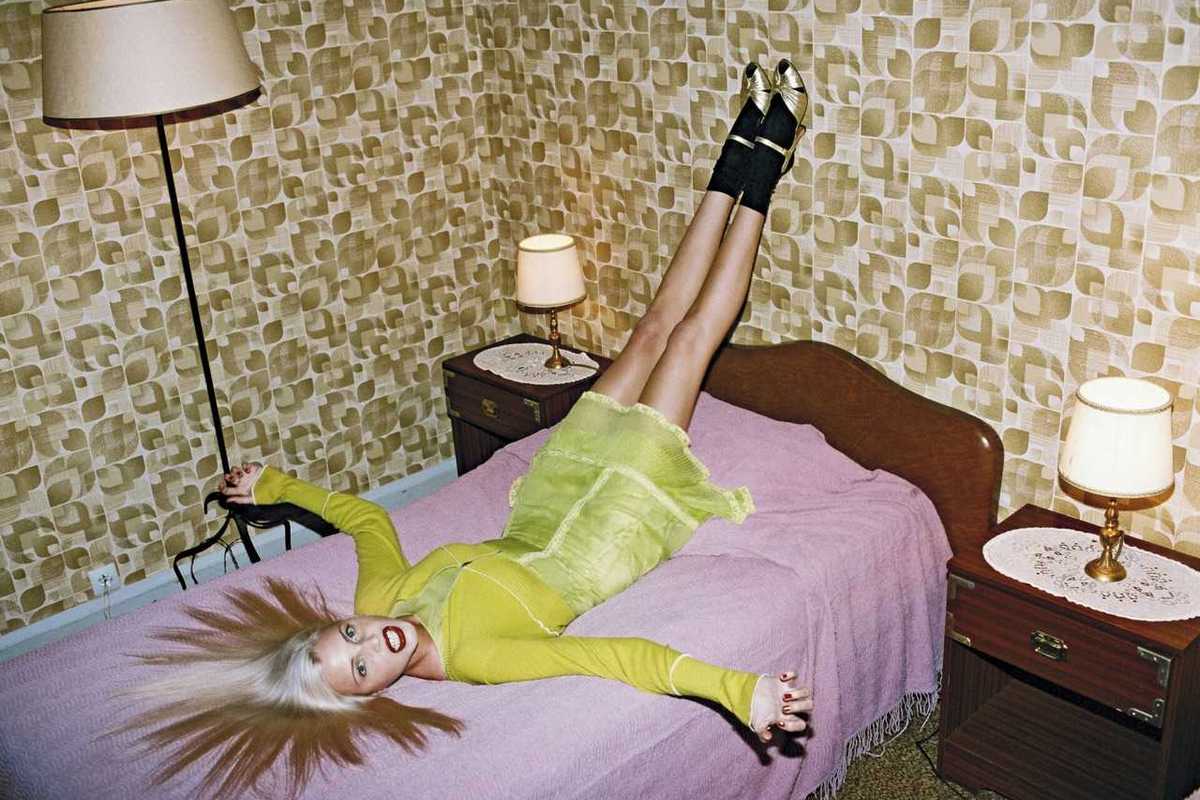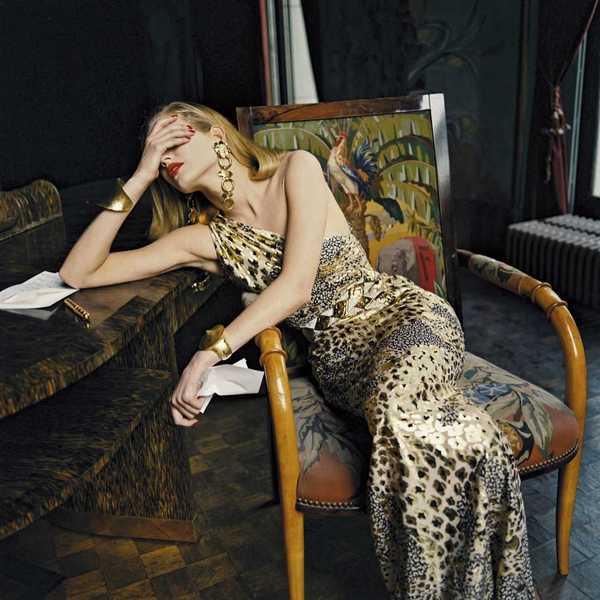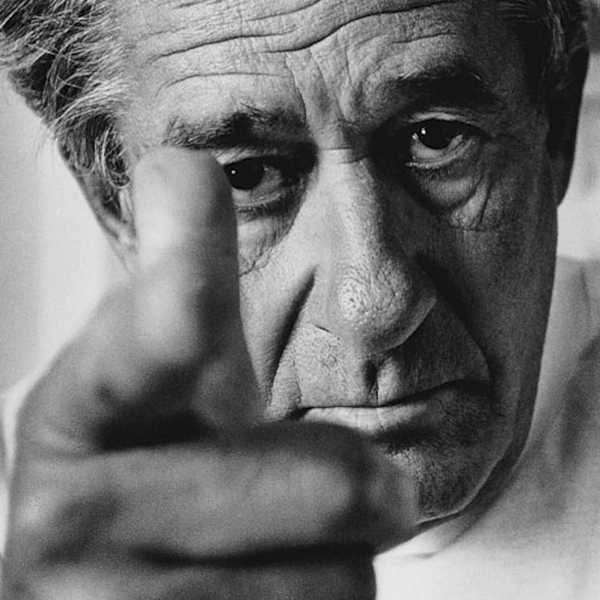Giovedì 2 dicembre si è tenuto il Consiglio europeo dei 27 ministri dell’Energia che ha affrontato ancora una volta il tema spinoso degli alti prezzi in tutto il continente. Il Consiglio ha esaminato il rapporto preliminare dell’Acer, che ha investigato su ipotetiche speculazioni avvenute nel mese di settembre. Nella relazione, chiesta a suo tempo dal commissario per l’energia, l’estone Kadri Simson, l’Acer (Agency for the cooperation of energy regulators) ha escluso che ci siano stati abusi sul mercato e ha anzi confermato che l’attuale quadro regolatorio è pienamente rispondente ai criteri di concorrenza e trasparenza. Di fatto, Acer ascrive le motivazioni dei forti rincari alle difficoltà da parte dell’offerta di gas nel soddisfare la domanda energetica continentale, evitando accuratamente di ingenerare il dubbio che tale difficoltà sia stata favorita proprio dal quadro regolatorio.
Tutto bene, quindi? Ovviamente no. Il Consiglio è stato teatro di uno scontro tra due fronti in merito alle regole del mercato energetico, non inedito nella sostanza ma certamente nuovo nell’intensità. Da una parte Francia e Italia, cui si aggiungono Spagna, Grecia e Romania, hanno proposto in un non paper (come nel gergo dell’Unione vengono chiamate le proposte informali da parte degli Stati membri) una revisione sostanziale della direttiva Elettricità in due punti. La prima modifica riguarda l’introduzione di un prezzo dell’elettricità che «rifletta il costo del mix di produzione utilizzato per soddisfare il fabbisogno dei consumatori». Tale modifica, si affrettano a precisare i Paesi mediterranei, non andrebbe a toccare l’attuale meccanismo del prezzo marginale di sistema. In pratica, si chiederebbe al produttore di riconoscere uno sconto, parametrato alla tecnologia di produzione, rispetto al prezzo marginale di sistema che incassa sul mercato spot.
La seconda modifica riguarderebbe l’introduzione di una «offerta di interesse economico generale» sulla base del costo delle sole fonti rinnovabili, in pratica una tariffa verde a disposizione di tutti i consumatori. Entrambe le modifiche, secondo i proponenti, avrebbero l’effetto di abbassare i prezzi per i clienti finali. Dall’altra parte, la Germania e altri otto Paesi (Austria, Danimarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia e Olanda), con una nota emessa addirittura il giorno prima della riunione, si oppongono nettamente a qualsiasi revisione dell’attuale cornice regolatoria e anzi spingono per una maggiore integrazione delle reti e dei mercati. I fondamenti del prezzo marginale di sistema non devono essere toccati e l’unica strada possibile per abbassare i prezzi è accelerare la transizione verso le energie rinnovabili.
Lo iato tra Francia e Germania, già evidente sul tema della tassonomia verde, si fa ancora più profondo sul tema della riforma del mercato. La consonanza tra Francia e Italia non finisce qui, però. Durante il suo intervento nel corso della sessione mattutina del Consiglio, il ministro italiano per la Transizione ecologica Roberto Cingolani ha affermato che non ci devono essere pregiudizi riguardo alle tecnologie di produzione di energia, per cui nella tassonomia degli investimenti cosiddetti sostenibili dovrebbe essere inclusa senza indugio anche la tecnologia nucleare di nuova generazione (Small modular reactors, Smr). Proprio la Francia fa dell’energia nucleare il punto chiave della propria strategia di emissioni zero, come annunciato da Emmanuel Macron un mese fa, e proprio con il lancio dei nuovi reattori a fissione Smr. Anche su questo la Germania è fortemente contraria e lo è a maggior ragione oggi, nel momento in cui sta per darsi un governo con il partito dei Verdi che occuperà posizioni importanti. Il 6 dicembre prossimo la Commissione europea dovrebbe finalmente rendere nota la propria decisione sull’atto delegato che contiene la tassonomia degli investimenti considerati utili alla transizione energetica. Scopriremo così finalmente se nucleare e gas saranno considerate dall’Unione europea tecnologie su cui sarà vantaggioso investire o se saranno invece penalizzate.
Il Consiglio si è chiuso con un sostanziale nulla di fatto sui temi energetici, esattamente come la riunione di fine ottobre. Resta però agli atti il plateale allineamento tra Francia e Italia sui temi energetici, che sembra essere uno dei primi e più evidenti effetti del Trattato del Quirinale appena siglato a Roma tra i due governi. La linea comune su riforma del mercato ed energia nucleare, che si contrappone radicalmente ai desideri della Germania, sembra ben studiata e non improvvisata. Vedremo nei prossimi mesi se e in quale misura questa unione di intenti proseguirà.
Nel frattempo, i futures sui permessi di emissione di CO2 sul mercato Ice hanno fatto segnare un nuovo record a 80,42 euro/tonnellata e il mese di novembre si è chiuso con un consolidamento dei prezzi spot dell’energia elettrica sui livelli massimi in tutta Europa. Si è anche verificato il caso atipico di prezzi italiani più bassi di quelli francesi, per cui in alcuni giorni l’Italia ha esportato energia verso la Francia. Il mercato europeo rimane in tensione per via dei fondamentali del gas. È infatti opinione condivisa che il mercato si trovi in una situazione di scarsità di gas fisico, con gli stoccaggi del Nord Europa che, partendo da una situazione già deficitaria rispetto agli anni precedenti, si stanno svuotando rapidamente. In Germania le riserve sono scese al 64% della capienza. Dalla Russia i flussi in export si sono stabilizzati ma non vanno oltre i valori minimi necessari a soddisfare i contratti di lungo termine esistenti.
In questo quadro, per quanto riguarda gli stoccaggi, l’Italia, pur con valori più bassi degli anni scorsi, è messa meglio di tutti, avendo le maggiori riserve di gas fisico tra i Paesi europei e un indice di riempimento dello stoccaggio attorno al 78%, tra i più alti. Sulle forniture di gas dalla Russia gravano sempre le incognite dei rapporti tesi con l’Ucraina, della crisi dei migranti tra Bielorussia e Polonia nonché la sospensione del processo di autorizzazione del gasdotto Nord stream 2. Tutti fattori che non lasciano intravedere sbocchi positivi a breve termine e che mantengono alta l’instabilità, mentre l’inverno è sempre più vicino.