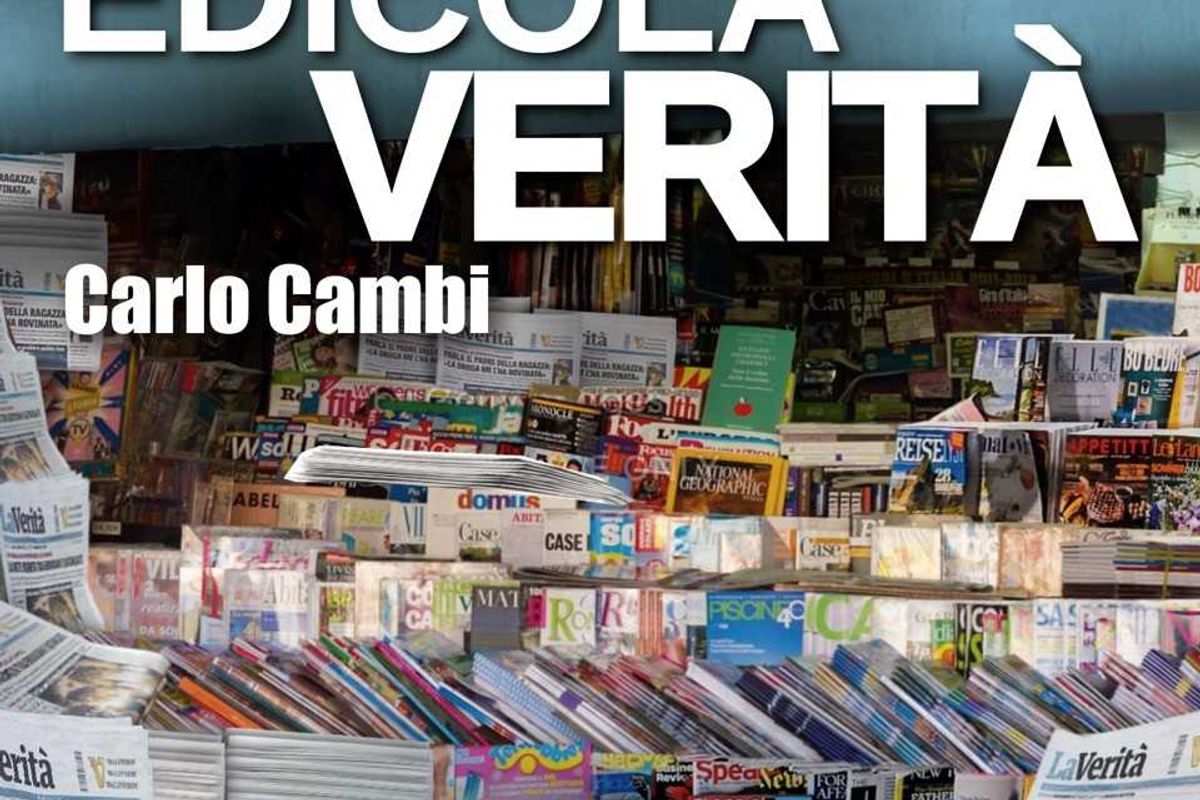L’addio arriva prima del previsto. Roberto Vannacci lascia la Lega e dice basta «ai linguaggi moderati». Lo spirito da funerale era nell’aria, ma si pensava fosse presto per la dipartita. E, invece, a meno di una settimana dal lancio di Futuro nazionale, l’ex generale se ne va. «Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra», il messaggio laconico a Matteo Salvini. «Chi mi ama, mi segua. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia», scrive su X, pubblicando il manifesto politico. «Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo», prosegue.
Un messaggio pubblicato proprio nel giorno del consiglio federale della Lega, indetto da Salvini nella storica sede milanese di via Bellerio. In quanto vicesegretario, ovviamente era stato invitato anche Vannacci, che però ha disertato l’incontro, rimanendo chiuso nel suo ufficio a Bruxelles, lanciando così un messaggio a Salvini, che risponde amareggiato. Lunedì sera, Salvini e Vannacci si erano incontrati a Roma e avevano discusso a lungo. Salvini avrebbe imposto a Vannacci un aut aut. O dentro o fuori. «Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità», giurano.
«Non sono arrabbiato, sono deluso. La Lega lo aveva accolto quando aveva tutti contro ed era rimasto solo», commenta su X. «Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle Europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito. Volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. In questi mesi, invece, abbiamo vissuto polemiche, problemi, tensioni, simboli di possibili nuovi partiti e associazioni, attacchi a chi la Lega la vive e la ama da anni. Peccato». Salvini prosegue: «Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa. Dispiace umanamente prima ancora che politicamente, ma andiamo avanti tranquilli per la nostra strada. Gli uomini passano, le idee restano». In serata, a Cinque minuti, ospite di Bruno Vespa su Rai 1 sgombra il campo da possibili alleanze in futuro e ribadisce: «Sono abituato a dare valore alla parola data, non mi abituo al fatto che la poltrona valga più della fiducia, della lealtà e dell’onore. C’è il dispiacere perché tanti italiani, compreso io, lo abbiano votato. E poi ci si domanda perché la gente non vada a votare, ma l’Italia andrà avanti lo stesso. Renzi dice che è felicissimo per cui lascio giudicare voi».
Ad ogni modo, nessuna espulsione. Ma una separazione «consensuale». «Dovrà però essere lui a formalizzare l’addio», aggiungono dalla Lega, postando su X «La storia si ripete», facendo riferimento a Futuro e libertà di Gianfranco Fini. Adesso i salviniani si aspettano che si dimetta anche da europarlamentare, dato che ci è diventato con i voti della Lega. Intanto, a Bruxelles, il gruppo dei Patrioti ha votato all’unanimità l’espulsione di Vannacci, rassicurando che «la Lega resta un partito partner a pieno titolo».
Anche Casapound ha preso le distanze dal nuovo soggetto politico, scrivendo in una nota che non farà parte di Futuro nazionale dove, invece, Vannacci imbarca Sylvie Lubamba, fondatrice del team Vannacci di Milano: «Decolleremo o affonderemo insieme, sono il suo fedelissimo araldo». E come lei il «barone nero» Roberto Jonghi Lavarini: «Ora la battaglia più importante è quella sacrosanta della remigrazione. La maggioranza del popolo italiano lo seguirà». Ad aiutare l’ex generale c’è un altro leghista, da tempo fuori dal Carroccio, Mario Borghezio, uno che a modo suo ha anticipato i tempi: rappresentava l’estrema destra dentro la Lega Nord, che formalmente si definiva «né di destra né di sinistra». Poi ci sono i fedelissimi, piazzati nei consigli regionali: Massimiliano Simoni in Toscana e Stefano Valdegamberi in Veneto, oltre a Cristiano Romani, a capo dell’associazione Mondo al contrario. In Parlamento lo appoggeranno Edoardo Ziello (Lega), probabilmente l’ex fratello d’Italia Emanuele Pozzolo (espulso perché nella notte di Capodanno del 2024 impugnava un revolver da cui partì un colpo che ferì una persona) e anche Domenico Furgiuele, il leghista che voleva fare la conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione. E poi Rossano Sasso, altro leghista che il 15 gennaio votò, insieme a Ziello e Furgiuele, contro le armi a Kiev, bocciando la risoluzione unitaria di maggioranza.
Nei giorni scorsi i malumori nei confronti di Vannacci erano aumentati. Il lancio del suo nuovo movimento aveva aperto spaccature ancor più profonde, specie nell’ala moderata del partito capeggiata da Luca Zaia che, insieme ad Attilio Fontana e a Massimiliano Fedriga, rispettivamente presidenti di Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, chiedeva da tempo l’espulsione, insofferenti.
Vannacci, candidato dalla Lega come indipendente alle Europee 2024, aveva poi ottenuto la tessera dalle mani di Salvini nell’aprile 2025 e nominato vicesegretario un mese dopo. Un matrimonio d’interessi che ha retto appena un anno e mezzo. Sulla possibile fuoriuscita dell’ex generale, Salvini diceva appena quattro giorni fa: «Non esiste problema. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto». Concludendo che nel Carroccio «c’è spazio per sensibilità diverse». Evidentemente, però, queste sensibilità si sono rivelate un po’ troppo diverse.
Il partito: «Traditore uguale a Fini». Zaia: «Corpo estraneo da sempre»
Un po’ di sano risentimento ma, tutto sommato, nulla di trascendentale. Alla «questione Vannacci», durante il consiglio federale della Lega che si è tenuto ieri pomeriggio a Milano, non sono stati dedicati che pochi minuti. L’incipit lapidario del segretario Matteo Salvini, che ha paragonato l’addio del generale a quello di Gianfranco Fini del 2010, ha spento sul nascere qualsiasi impulso a soffermarsi su una questione già nell’aria da tempo e, quasi, quasi digerita se non fosse per l’intolleranza conclamata ai tradimenti che affligge molti leghisti doc.
«Su chi tradisce e fugge non vale la pena perdere troppo tempo, come accadde con Fini in passato», ha esordito Salvini nell’aprire la seduta, per poi passare subito all’ordine del giorno: pacchetto sicurezza, referendum, manifestazione sull’immigrazione prevista per il prossimo 18 aprile a Milano.
Sul tema sicurezza, in attesa del passaggio in Consiglio dei ministri, Salvini ha confermato l’intenzione di stringere ancora un po’ i bulloni a un testo che tratta un «tema fondamentale in questo momento storico», anche integrando le posizioni già espresse con nuove richieste, in lavorazione proprio in queste ore.
Passaggi puramente organizzativi, invece, sono stati quelli dedicati al referendum sulla giustizia, per il quale il Carroccio ha ingaggiato le sue sedi territoriali per una «gazebata federale» prevista per il 14 e il 15 di marzo e alla manifestazione del 18 aprile, oggetto di aggiornamenti tecnici. In vista dell’appuntamento nelle piazze, l’intenzione è quella di coinvolgere oltre al gruppo parlamentare dei Patrioti europei anche figure di spicco internazionale e lo spunto, interno, è quello di trattare il tema «remigrazione», tanto caro al generale, «con serietà», soprattutto per rispetto a una base che, di questa materia, rivendica la paternità: «In fondo si tratta di rispedire a casa i clandestini, che è uno dei principi fondanti del nostro partito, da sempre».
Serenità, dunque, e pochi rimpianti sul generale perché, la storia insegna: «Chi ha lasciato, come Fini, si è visto, poi, che fine ha fatto». Unico tema ancora sul tavolo lo scranno da europarlamentare ottenuto da Vannacci nel 2024 con circa mezzo milione di voti portati dalla candidatura del Carroccio. «Se Vannacci è quello di oggi può ringraziare solo il mio partito, che ha investito su di lui alle Europee l’anno scorso e gli ha permesso di avere un seggio», ha commentato secco l’ex presidente del Veneto, Luca Zaia: «Ha capito di essere un corpo estraneo nella Lega. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere, e oggi decide di camminare sulle sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia solitaria». A fargli eco l’attuale presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha commentato: «A chi mi chiede se dovrebbe dimettersi rispondo che credo che chi ricopre una carica grazie a un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento». Per Claudio Borghi, infine, il gesto di Vannacci è «irrispettoso verso il nostro partito che gli ha aperto la strada» e «in questo modo si fa il gioco di Renzi e di chi divide le forze sovraniste, della Schlein e compagnia bella e che in questo momento si sta fregando le mani».
Anche sui social la decisione di Vannacci di lasciare la Lega non ha riscosso particolare gradimento: la parola chiave «Roberto Vannacci», negli ultimi due giorni, ha ottenuto nelle conversazioni digitali «37.420 menzioni» con un picco registrato, ieri pomeriggio alle 16.45, poco dopo l’inizio del consiglio leghista a Milano, ma con un sentiment complessivo che nelle ultime 24 ore è risultato «negativo all’85%». A dirlo è un report realizzato da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, con dati raccolti attraverso Human, la piattaforma digitale che registra le tendenze social in interazione con i sistemi di Intelligenza artificiale. Secondo i dati, solo il 21,4% degli utenti ha espresso «opinioni positive rispetto alla decisione» perché, a oggi, il generale non viene percepito dalla Rete «come leader». Meglio la performance social di Salvini che registra un trend positivo pari al 30,2%, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al periodo precedente.
A livello di peso elettorale, una prima rilevazione di Youtrend per Sky Tg24, la lista si collocherebbe poco al di sopra della soglia di sbarramento del 3%.
«Ora dovrebbe essere chiaro a tutti perché misi in guardia il mio ex segretario su Vannacci. Lo criticai, forse alla mia maniera diretta, ma i fatti dimostrano che avevo visto giusto. Mi fu subito evidente che i miei valori non potevano essere accostati ai suoi, né a quelli di una Lega che non riconoscevo più, nonostante oltre 40 anni di militanza. Era chiaro a tutti che l’obiettivo fosse usare la Lega per altri fini politici», ha concluso con una nota amara Toni Da Re, già europarlamentare della Lega ed ex segretario regionale veneto della Liga veneta, espulso dalla Lega per forti contrasti con Salvini dovuti proprio alla salita del generale a bordo del Carroccio.