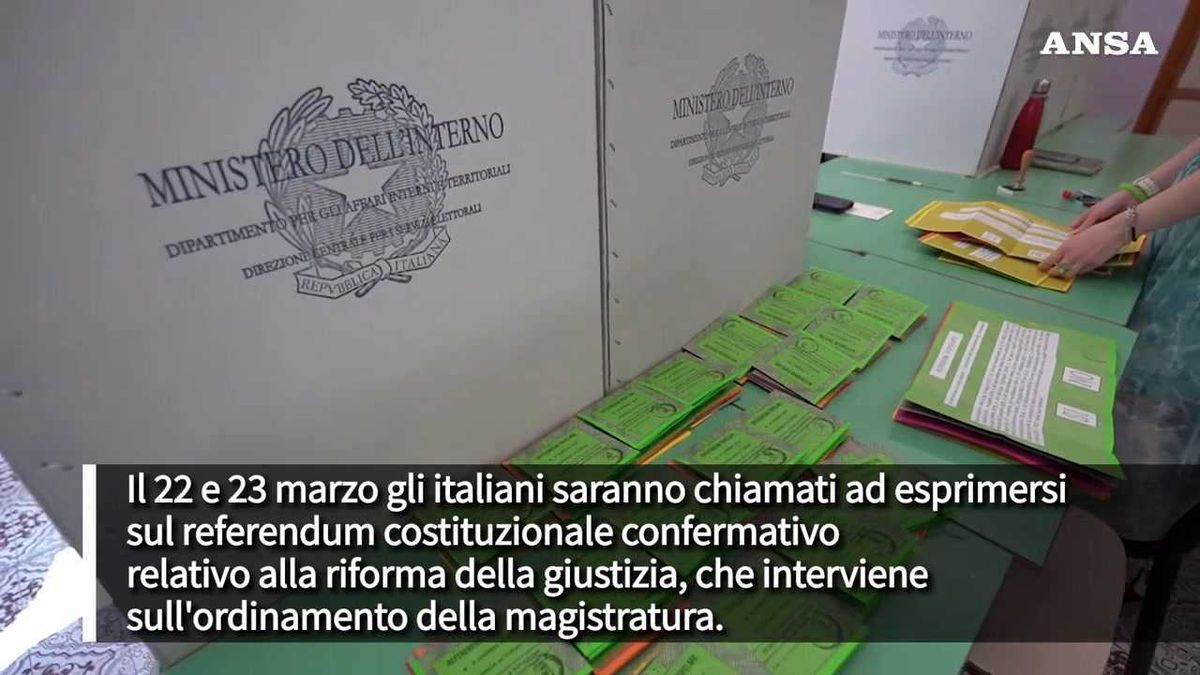Dogmi green, liberismo e deflazione. Bussola per capire il dopo pandemia

Siamo tuttora immersi in un passaggio da un'epoca caratterizzata da relazioni complesse ma, in definitiva, ancora stabili e prevedibili tra il nucleo di Paesi consumatori appartenenti al blocco delle poliarchie democratiche occidentali, rappresentati dall'Ocse, e il gruppo relativamente ristretto di produttori riuniti attorno all'Opec (più la Russia), a un nuovo mondo caratterizzato, invece, da nuove aree di produzione e consumo - specialmente in Asia - in rapida espansione. Di qui un livello di frammentazione delle relazioni energetiche a livello transnazionale quale mai avevamo avuto in passato.
I modelli di governance poliarchici, sia tra imprese, sia tra Stati, devono essere sottoposti a profonde trasformazioni e saranno difficili da gestire attraverso i modelli precedenti. Si sono rese manifeste simultaneamente, a riprova di quanto avevo previsto anni orsono, quelle profonde faglie che stanno sempre più aprendosi nel sistema capitalistico mondiale tra Stati e cluster di imprese, tra il nuovo complesso interstatale di relazioni spongiformi e ciò che rimane degli Stati, da un lato, e le nuove forme di relazioni oligarchiche tecnocratiche, dall'altro. Appare un nuovo volto dello Stato senza più «ragion di Stato» e sempre più poroso e ibridato da soggetti che sfuggono alle regole della democrazia liberale, quale quella che ci era stata consegnata dalla tradizione del grande costituzionalismo francese à la Constant e à la Madame de Staël. Gli accordi internazionali sulla decarbonizzazione, su cui qui si richiama solo l'attenzione per un bisogno cognitivo tanto sono noti ormai all'«universo mondo», quegli accordi dovrebbero addirittura sostituirsi sia al mercato sia agli Stati, in questo tempo di liberismo dispiegato e di deflazione secolare, con una singolare contraddizione che apre problemi economici e filosofici rilevanti.
[...] Da un lato, quindi, aumentano gli accordi interstatali di cooperazione multilaterale su questioni proprie un tempo della «ragion di Stato» e della libertà d'impresa (si pensi, appunto, agli impegni assunti da rappresentanti delle diversificate tecnocrazie interstatali sulla transizione energetica, decarbonizzazione in primis) e, dall'altro lato, si rendono vieppiù manifesti diversificati rifiuti dei modelli di cooperazione multilaterale. Sempre più difficile, però, è rendere compulsivo qualsivoglia modello e processo implementativo di linee guida, di regole e di comportamenti inclusivi e stabili.
La radice di ciò risiede nel mondo a frattali che si sta delineando in primo luogo nelle relazioni internazionali. Dopo il crollo dell'Urss si è creato un vuoto di regolazione dei rapporti di potenza non ancora colmato, perché nessun accordo generale ha sostituito il complesso architetturale costruitosi durante la guerra fredda. Ciò è accaduto per l'assenza di un trattato che potesse ricostruire, dopo il crollo dell'Urss, il sistema delle relazioni internazionali mondiali.
[...] Tutto ciò mentre si affaccia una nuova potenza marittima dittatoriale nell'agone mondiale (la demografia grazie alla tecnologia si trasforma infatti in un possibile profilo statuale di potenza sino a oggi inaudito nel caso cinese), sconvolgendo le relazioni tra gli Stati che dopo il crollo dell'Urss non avevano trovato nessun assestamento, come dimostrarono le guerre europeo-balcaniche e le guerre mesopotamiche, con il Mediterraneo di nuovo contendibile per il ritorno della Russia nei mari caldi. Non solo le guerre per procura nelle aree che sono alle pendici dell'Eurasia e nei laghi (il Mediterraneo appunto) che sono dominanti per il controllo delle terre, ma guerre che servono per alternare iniziative diplomatiche cruciali per la stabilizzazione del conflitto e la vittoria bilanciata. L'esempio che è venuto dalle guerre libiche (come da quelle balcaniche) è proprio questo. Infatti non si è giunti a uno scontro totale tra Turchia e Russia, ma è successo quello che si è verificato in Bosnia: un'alternanza tra azione militare e trattative diplomatiche. [...] Siamo dinanzi a una chiara testimonianza dell'inadeguatezza delle attuali architetture istituzionali internazionali in ambito energetico. Ciò che conta è sottolineare che si è affermata, nella costruzione simbolica imposta dalle agenzie della globalizzazione finanziaria, la costruzione narrativa fondata sull'assunto che sia la decarbonizzazione la via maestra attraverso cui si può giungere a una riduzione della CO2 che viene emessa nell'atmosfera terrestre, ignorando che è il complesso delle fonti energetiche tutte (sempre migliorabili ambientalmente) che, invece, consente la riproduzione dei sistemi economici e sociali mondiali.
[...] Si tratta quindi della necessità di una trasformazione profonda dell'intero modo di produrre su scala mondiale multifattoriale. È impensabile che questo processo possa essere affidato all'eteroregolazione interstatuale. [...] Questo implica una trasformazione della prassi e del concetto stesso di «ragion di Stato». [...] La radice distintiva di queste forme politiche è il fatto che tutte si muovono al confine tra Stato e mercato, preformando tanto con la procedura tecnica quanto con l'ideologia (nel caso nostro «climatica» e «naturistica») ora l'uno ora l'altro degli elementi della relazione Stato-mercato, grazie al peso possente che esercitano le relazioni interstatuali che si sono sedimentate in questo intreccio simbolico e sociale del nuovo potere transnazionale.