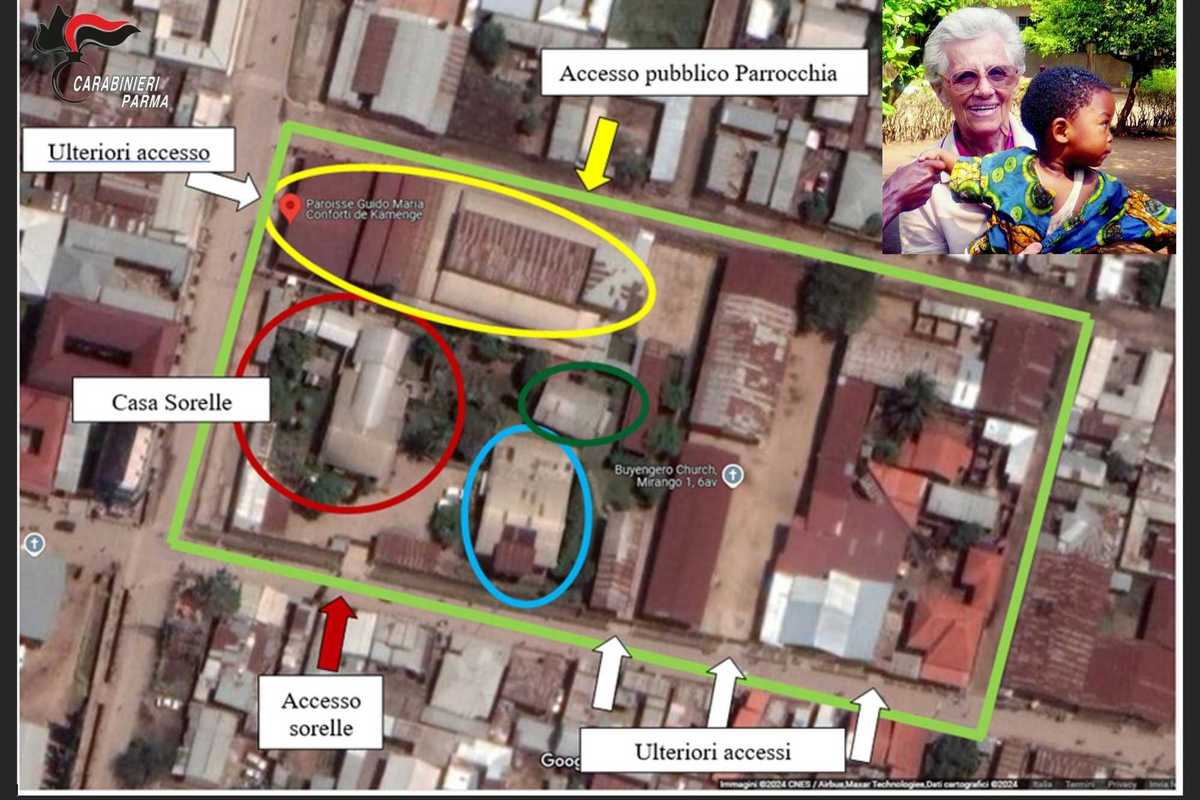È il 17 gennaio del 2020. Da qualche tempo si discute, a livello internazionale, dei casi di polmonite legati a un nuovo coronavirus emerso a Wuhan, in Cina. L'Health security committee dell'Unione europea ha fissato un «audio meeting» per affrontare la faccenda. La riunione si svolge fra le 15 e le 16, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri dell'Ue. Questo, in fondo, è l'esatto compito del comitato europeo per la sicurezza sanitaria: al suo interno, si legge sul sito ufficiale, «gli Stati membri si consultano al fine di coordinare le risposte nazionali alle gravi minacce per la salute transfrontaliere, compresi gli eventi dichiarati un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, in conformità con i regolamenti sanitari internazionali».
Tra gli invitati alla riunione, ovviamente, c'è anche il ministero della Salute italiano. All'«audio meeting» dovrebbe partecipare Francesco Maraglino, responsabile prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del ministero.
Piccolo problema: all'incontro Maraglino non si presenta. Non c'è. Per quale motivo? A chi nei mesi scorsi ha chiesto spiegazioni riguardo la clamorosa assenza, è arrivata una sorprendente risposta ufficiale: il dirigente del ministero non ha letto l'email di convocazione. Capite bene che saltare le riunioni quando all'orizzonte si profila un'emergenza sanitaria internazionale non è una grandissima idea. Nel caso specifico, poi, l'assenza è ancora più grave. La riunione, infatti, ha come scopo la «valutazione del rischio» legata al Covid: gli Stati europei devono decidere quali misure di protezione mettere in campo per evitare che il virus si diffonda oltre i confini cinesi. Ad esempio, devono capire come evitare che persone contagiate arrivino dalla Cina in Europa a bordo di un aereo. Il 17 gennaio, in sostanza, si discute di controllo dei confini esterni dell'Ue. Va detto che Maraglino non è l'unico assente ingiustificato. Su 27 Stati membri convocati, solo 12 hanno risposto alla chiamata. Le nazioni di peso, tuttavia, ci sono. Al meeting si collegano tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi, norvegesi, ungheresi, persino inglesi. L'Italia, unica fra le nazioni leader, non si fa vedere.
Come facciamo a sapere di che cosa hanno parlato i rappresentanti degli Stati europei durante la riunione? Nel luglio del 2020, il quotidiano britannico Guardian ha fornito una ricostruzione dell'incontro basandosi sulle rivelazioni di alcune fonti.
«La preoccupazione iniziale», ha scritto il giornale, «riguardava come mantenere la malattia al di fuori dei confini dell'Ue. […] Wolfgang Philipp, capo di un piccolo team all'interno del dipartimento della salute della commissione a Lussemburgo, ha presieduto l'incontro. Ha detto ai presenti che alcune dozzine di persone a Wuhan erano state infettate da un nuovo ceppo di coronavirus. Con 300.000 persone che avrebbero dovuto volare in Europa dalla Cina quel mese […] la domanda era cosa fare con i voli diretti da Wuhan a Londra, Parigi e Roma».
La Verità è in grado di fornire ora alcune informazioni aggiuntive. Della riunione del 17 gennaio, infatti, esistono anche dei verbali ufficiali. Li ha ottenuti Robert Lingard, consulente dell'associazione delle vittime del Covid di Bergamo. Lingard, alla fine di agosto, si è rivolto al ministero della Salute britannico chiedendo di poter vedere le trascrizioni dell'incontro di gennaio. Qualche giorno fa le autorità inglesi gli hanno risposto, e gli hanno inviato un documento molto dettagliato.
Leggendo il verbale, si nota subito un passaggio interessante. A un certo punto della riunione, prendono la parola i portavoce dell'Ecdc, cioè il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che è «un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei Paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive». L'Ecdc fornisce ai partecipanti alcune importanti indicazioni riguardanti appunto la gestione del rischio. Tra i vari temi toccati dagli esperti ce n'è uno centrale. L'Ecdc «raccomanda che gli operatori sanitari siano informati della situazione e del rischio rappresentato dai viaggiatori di ritorno da Wuhan». Non solo. Il Centro europeo di controllo delle malattie fa un'altra cosa molto rilevante: richiede «test tempestivi e consiglia isolamento appropriato e misure di controllo delle infezioni».
Ecco il punto nodale: i «test tempestivi» («prompt testing» nel documento originale). Quali sono questi test? I tamponi, ovviamente: gli stessi che si facevano già in varie nazioni asiatiche, a partire proprio dalla Cina. Insomma, l'Ecdc suggerisce che ci si concentri sui passeggeri in arrivo da Wuhan con un «approccio mirato»: chi proviene dalla Cina ed entra in Europa dovrebbe essere testato e, se contagiato, messo in isolamento e sottoposto a misure di controllo delle infezioni.
Gli esperti dell'Ecdc, infatti, sono consapevoli che non basta misurare la temperatura a chi scende dagli aerei: servono test più efficaci. Sentite che cosa ha scritto il Guardian a riguardo, sempre parlando della riunione del 17 gennaio 2020: «Si ritiene che lo screening di tutti gli arrivi in aeroporto con controlli dei sintomi e termometri sia in gran parte inefficace nel fermare la diffusione del virus, ha detto al comitato un funzionario dell'Ecdc. È stato invece raccomandato di concentrarsi sui passeggeri dei 12 voli settimanali in arrivo in Europa da Wuhan. Il Regno Unito e la Francia hanno condiviso informazioni su ciò che stavano facendo negli aeroporti. Ma non c'è stato alcun aggiornamento dal governo italiano, uno dei tanti assenti».
Riepiloghiamo: l'Ecdc sa che la misurazione della temperatura non serve, mentre servono altri test tempestivi, cioè i tamponi. Tutto ciò viene detto nel corso della riunione, ma l'Italia non è presente.
Che cosa succeda dopo il 17 gennaio lo apprendiamo da altri verbali, cioè quelli della famosa «task force anti Covid» creata da Roberto Speranza. Il 22 gennaio, l'Italia decide di controllare soltanto i voli in arrivo da Wuhan (nessun controllo per «quelli provenienti da scali intermedi tra Cina e Italia»). Come vengono controllati i passeggeri? «Mediante l'impiego di scanner termici». Gli articoli di cronaca usciti sui quotidiani italiani dal 23 gennaio 2020 in poi raccontano esattamente questo: i passeggeri in arrivo da Wuhan vengono fatti passare sotto il termoscanner oppure avvicinati da personale munito di termometri. Chi ha una temperatura corporea nella norma può andare.
Tutto chiaro? Gli esperti europei avevano detto chiaramente di testare le persone in arrivo da Wuhan, e avevano fatto presente l'inutilità degli scanner termici. Eppure non solo l'Italia ha controllato soltanto i voli diretti (perdendosi così altri passeggeri che avevano fatto scalo altrove prima di giungere qui), ma ha anche evitato di sottoporre a tampone i viaggiatori. Viene allora spontaneo domandarsi: quanti asintomatici sono stati fatti entrare in questo modo? Quante persone che stavano incubando la malattia abbiamo ammesso in Italia? Quante infezioni avremmo potuto evitare effettuando controlli più adeguati nei primi giorni di gennaio del 2020? Chissà se qualcuno al ministero della Salute è in grado di rispondere.