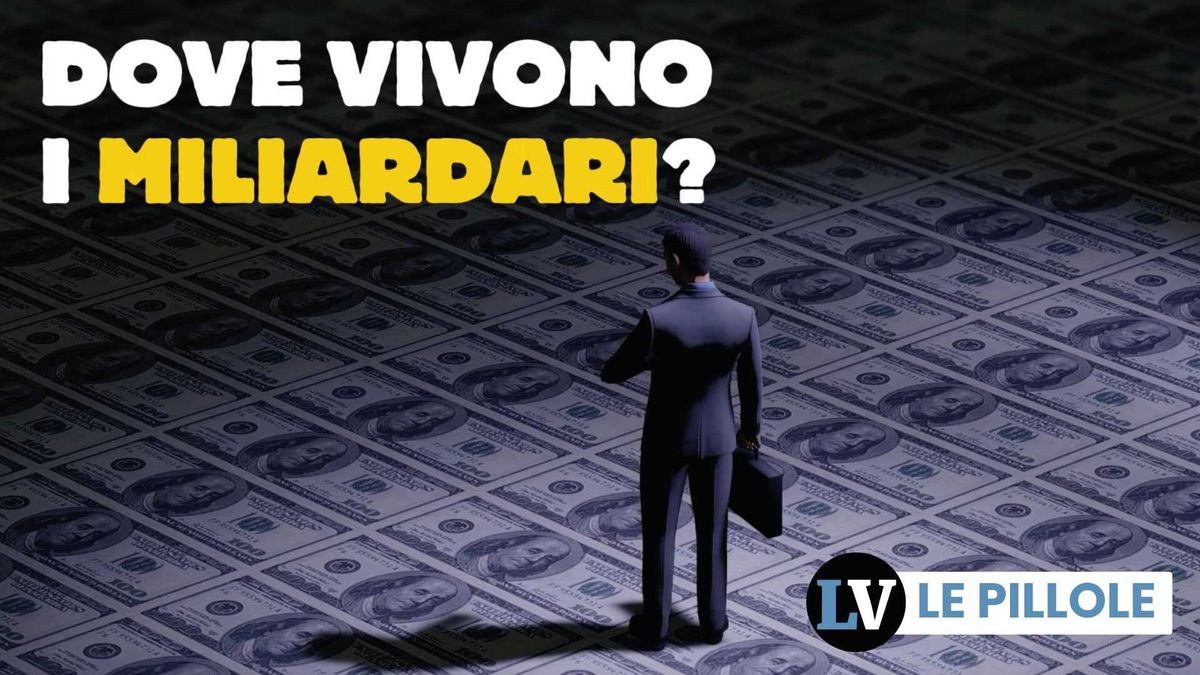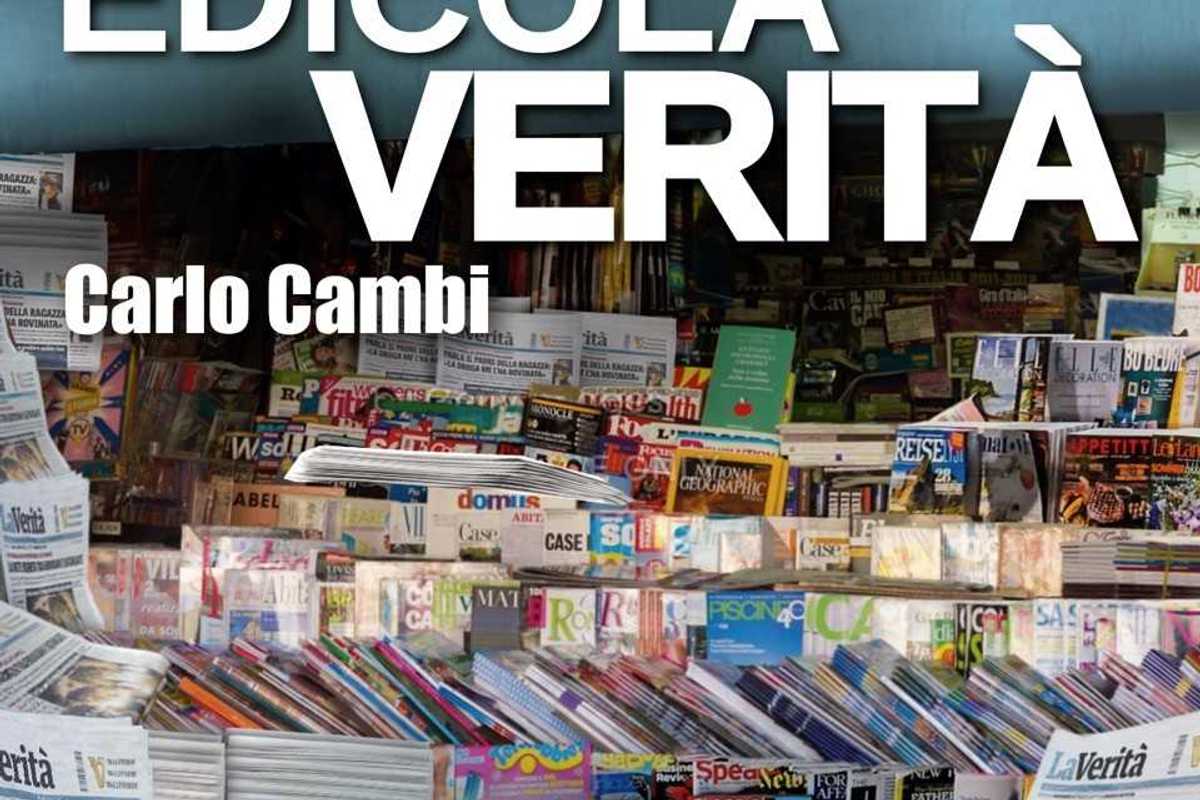In questo nostro viaggio fra i grandi alberi d'Italia non abbiamo ancora toccato i boschi. Abbiamo cercato la compagnia di esemplari singoli, straordinari, spesso di città. Abbiamo avvicinato i platani vulcano dei giardini che circondano Villa Litta a Milano, ad esempio, il grande cedro di Villa Mirabello nel cuore verde di Varese, ad esempio, il platano re di Villa Sartirana, a Torino, ad esempio, la splendida magnolia di Villa Grismondi Finardi nella mia città natale, Bergamo o la quercia rossa di Monza, ammirata a ritratta su china, un quarto di secolo fa, da Federica Galli. Alberi umanizzati, addomesticati, che conoscono spesso la lingua mista della terra e del cemento, esemplari recentemente sondati e con quale magnificenza dallo scrittore mantovano Antonio Moresco, nel suo romanzo Canto degli alberi (Aboca), alberi-messaggeri parlano un canto muto ma denso.
Ogni provincia custodisce - talvolta con saggezza, talvolta a malincuore, talora con cura, talora passivamente - boschi e lembi di foresta. Meno in pianura, poiché il territorio viene sfruttato al meglio: i boschi residui costeggiano spesso i corsi dei fiumi, se le ruspe delle cave non li hanno estirpati, o le inondazioni non li hanno travolti e sradicati. Le formazioni arboree regolari sono più che altro finti boschi di pioppi, coltivati per la qualità del legno, con tempi di maturazione che procedono fra i quindici e i vent'anni anni; ai nostri occhi paiono formazioni boschive, in realtà sono illusioni temporanee che saranno presto sostituite da altro.
Bisogna dunque risalire le colline, affrontare le Prealpi o l'Appennino o giungere in territori di confine, laddove il bosco ricomincia a parlare. Certo, abbiamo ancora grandi foreste di faggio e di abete, pinete antiche e leccete forse primarie, ma sono francobolli, eccezioni ad un lento ma inesorabile occupare, conquistare, modificare e sfruttare. Abbarbicati sulle rocce alpine abbiamo in Piemonte il Gran Bosco del Salbertrand e la Serva o Selva di Chambons, mentre in Valle d'Aosta i lariceti monumentali decisi dalle comunità umane come paravalanghe naturali, all'interno della geografia del Parco Nazionale del Gran Paradiso, o ancora la straordinaria pineta del Mont Avic. In Lombardia abbiamo le selve castanili del Canto Alto in Val Brembana, i boschi dell'Adamello in Val Saviore, il bosco di Santa Maria a Livigno. Nelle regioni del nord-est la sella di Lerosa sopra Cortina d'Ampezzo, la foresta del Cansiglio, le fiamme primigenee sulla cima dell'Alpe di Tramin in Valsarentino, la foresta di Tarvisio, i lariceti del Cadore o la celebra Scalinata dei Larici Monumentali in Val di Saènt. E questi non sono che piccoli segnali di un popolo arboreo ben più ampio, purtroppo colpito duramente dalla tempesta Vaia, a fine ottobre di due anni fa che, ricordiamo, ha abbattuto circa quattordici milioni di alberi, con venti che hanno toccato i duecento chilometri orari. Per noi i boschi sono ovviamente ben più che semplici giacimenti di carbonio, come dicono i tecnici, o metri cubi di legna che possono essere raccolti e venduti, sebbene resti una delle finalità stesse della loro conservazione, se guardiamo il mondo dal nostro punto di vista.
Allungando lo sguardo al resto d'Italia abbiamo ci inoltreremo nelle faggete immense dell'aretino, nel territorio delle Foreste Casentinesi, il Parco Nazionale della Majella e l'Abruzzo, Molise e Lazio; le tre grandi macchie scure che costituiscono una sorta di esoscheletro legnoso nelle Calabrie, ovvero il Pollino, Le Serre e la Sila. I boschi siciliani - messi spesso a dura prova da vasti incendi dolori - e le foreste interne sarde. Ufficialmente un terzo del Paese è ricoperto di boschi e aree boscate, con le querce a farla da padrone, e una stima di circa un miliardo di faggi. Numeri di tutto rispetto anche se può impressionare fare un paragone con un paese come il Giappone, che su una superficie di poco superiore alla nostra presenta una copertura boscosa che raggiunge il 67%, e una popolazione che doppia l'italiana.
Abbandonarci nel ventre foliare di un bosco ci riporta ad un respiro elementare, mai come in questo nostro magistero del disordine quotidiano, compressi e compromessi come siamo dalla paura da covid, povertà, economia indebolita, guerre che si minacciano in tanti luoghi del pianeta, un futuro sempre meno roseo, estinzione di massa, crisi climatica, innalzamento dei mari, scioglimento dei ghiacciai, aver l'opportunità di sanare mente e cuore non è poi cosa da poco. Camminare nel bosco, corrervi, passeggiarvi, meditarvi, non risolverà le grandi tragedie del mondo ma almeno può donarci qualcosa di sano, e non avendo mai riposto particolare fiducia nelle rivoluzioni inattese, una maturazione lenta ma costante può rappresentare un toccasana per molti di noi.
Quando chiediamo il permesso di entrare in un bosco ci accorgiamo di non essere niente. Siamo convinti che la ragione ultima di questo grande teatro di istinti e ragione che è l'esistenza sia un progresso, un miglioramento, delle condizioni nostre, individuali, quanto di quelle sociali, generali. Eppure bastano due passi nel bosco più ridotto e prossimo alla nostra comoda abitazione per intendere tutto quel che c'è da intendere nella vita che ci circonda. Cos'è dunque tutto questo disordine al qual continuamente tentiamo di porre un freno, un limite, una regola? Perché tutto nasce e poi muore? La morte è il compimento della vita o ne è parte? Domande a cui l'uomo tenta di dare una risposta da quando il suo cervello ha iniziato a operare.
Scelta musicale: compositore minimalista e dalle atmosfere drammatiche e sentimentali, Max Richter ci ha regalato colonne sonore per molti film. Fra i suoi album segnalo Three Worlds: Music from Woolfs Works (2017), con componimenti tratti da tre film ispirati all'opera letteraria di Virginia Woolf, quali Mrs Dalloway, Orlando e Le onde. E The Blue Notebooks, recentemente rieditato, il quale abbraccia due «notebooks» usciti nel 2003 e nel 2014, ospitando diversi brani divenuti celebri e amati, come On the Nature of Daylight, colonna sonora dello straordinario fantascientifico film di Denis Villeneuve, Arrival, Written on the sky e il travolgente e malinconico The Trees, a noi cara di default. Ed è proprio fra i nostri amati alberi, e su questa natura della luce del giorno che ci lasciamo vivere, trapassare, respirare. La musica di Richter è perfetta per farci compagnia nel bosco, come accompagnamento ma anche come suggello, magari assaporandola nella fioca luce di una lampada, prima di addormentarci, la sera, nella nostra tenda, in un sacco a pelo, sotto le stelle scintillanti, avvolti dal buio sospettoso, immaginando denti che digrignano e insetti che banchettano senza pubblico.