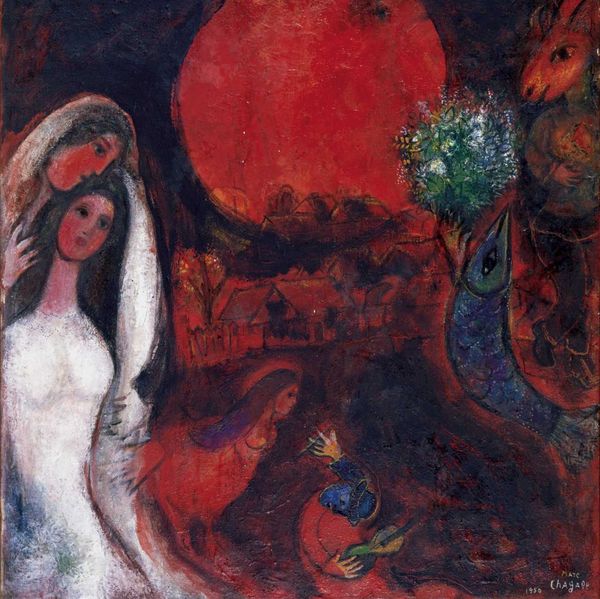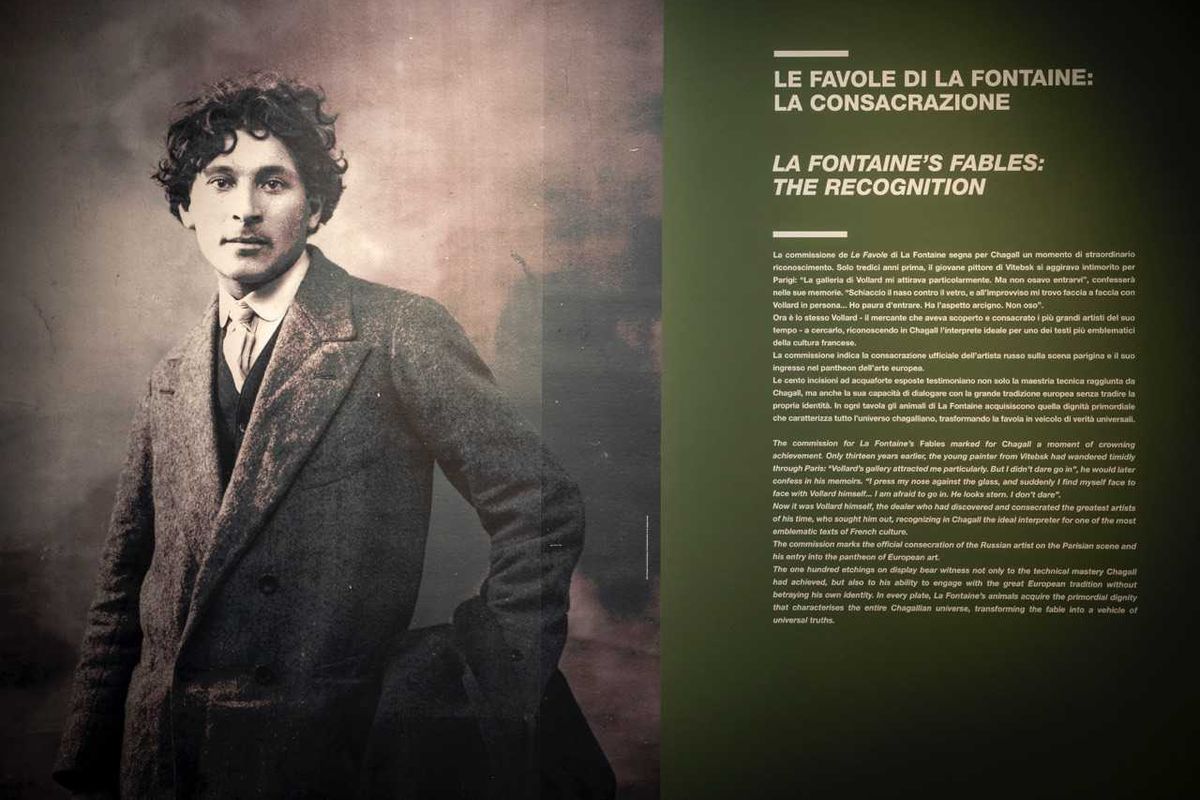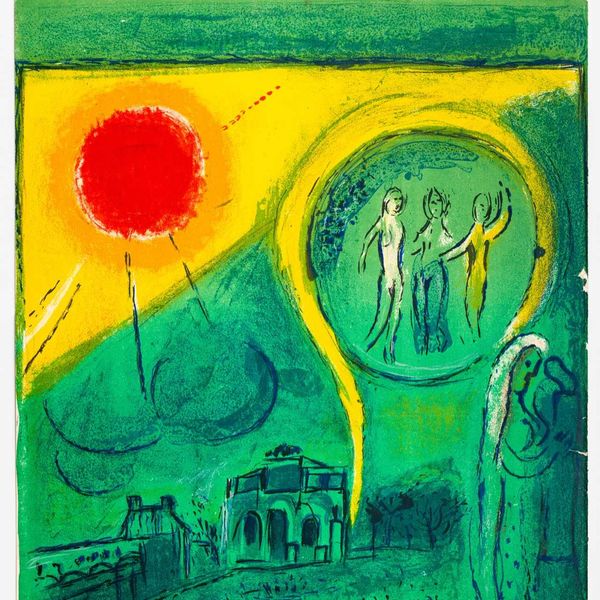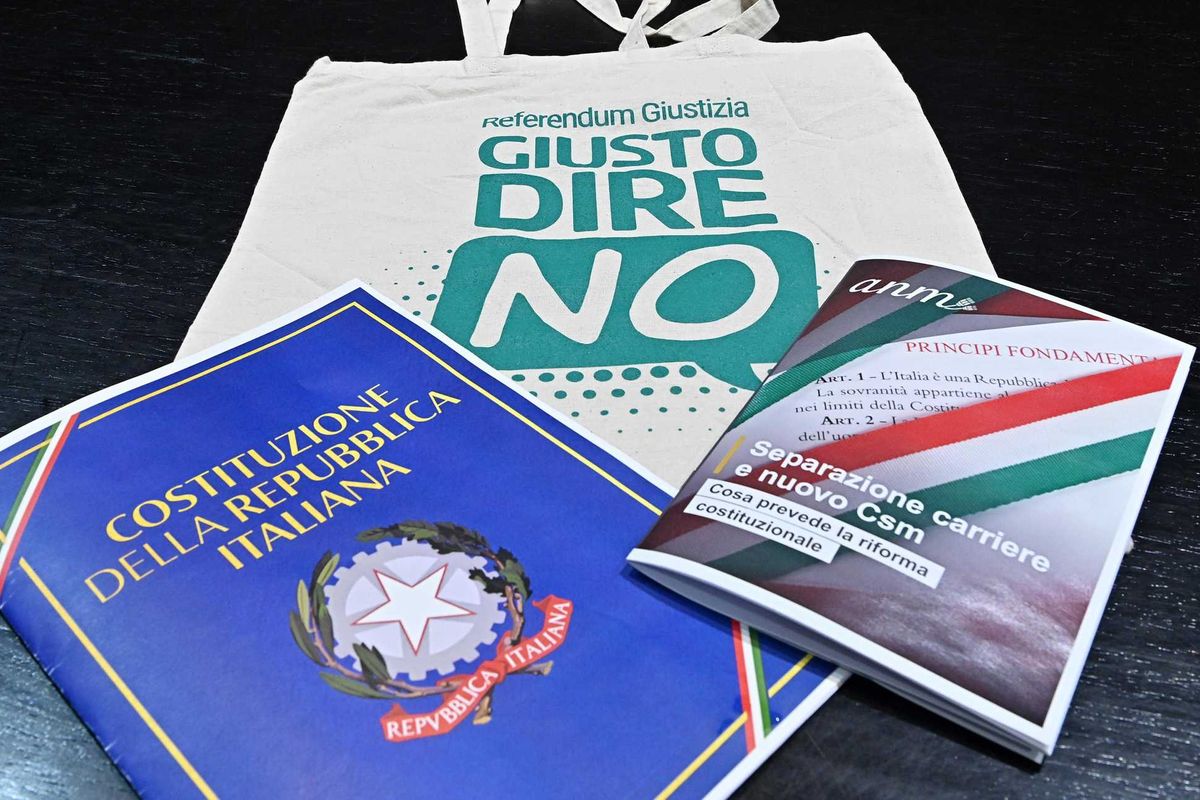È una storia che parte da lontano quella dei canederli, piatto simbolo di una cultura di montagna che ha fatto della semplicità quotidiana una tradizione che sta esplorando sempre nuovi confini. Il filone dei segugi di storie golose parte da una piccola cappella del castello d'Appiano, in Alto Adige, a pochi chilometri da Bolzano. Una delle più belle fortezze medioevali giunte sino a noi. Qui vi è un ciclo di affreschi di stile bizantino, stimato del 1180, che riprende varie tematiche, dall'annunciazione alla natività, nella quale, accanto a una Madonna con San Giuseppe e il Bambino, è ritratta un'ancella mentre sorveglia il bollore di una pentola da cui affiorano cinque sfere e ne porta alla bocca una sesta per testarne evidentemente la cottura. È per tutti, da sempre, la knodelesserin.
Vi è un'altra storia di veloce divulgazione a uso turistico che si racconta invece nei masi estivi, quando l'oste intrattiene i moderni mangiatori di canederli assetati di identità locale. Saltando qualche secolo è datata tra il Quattro e Cinquecento. Si narra di una scorreria di lanzichenecchi che, incrociando un maso isolato, affamati sotto il sole cocente, si rivolsero ai proprietari minacciando un rogo devastante se non veniva sedata la loro voracità predatoria. Mamma e figlie fecero di necessità virtù e racimolarono quanto era rimasto nella dispensa. Un po' di pane raffermo, cipolla, latte, uova, qualche brandello di carne. Il risultato andò oltre le previsioni. Non solo i barbari spazzolarono i piatti, ma trovarono pure il tempo per un riposante sonnellino.
Tuttavia, all'orgoglio identitario, non c'è limite, e spunta una terza traccia canederlesca che risale addirittura al neolitico. Tra i resti delle palafitte del lago di Mondsee, nel Tirolo austriaco, c'è chi sostiene di aver trovato le prove inconfutabili che i primi canederli siano nati lì. Come diceva il sommo maestro Indro Montanelli, «non è importante che una storia sia vera, ma verosimile». Che poi sia anche buona è puro valore aggiunto. Il debutto nella buona società avviene qualche anno dopo la degustazione barbara tra i masi d'alpeggio, con i canederli a far bella vista in un banchetto di nozze sotto la regia di Ippolito Guarinoni, tra le personalità più in vista delle corti tirolesi. Nella civiltà contadina di montagna la forza dei lavoranti agricoli veniva giudicata a seconda del numero di canederli che riuscivano a mangiare anche perché, fatti quattro conti, cosa meglio dei canederli per riciclare tutto quanto avanzava nella dispensa. Secondo l'etimo il loro nome deriva dal tedesco knot, ovvero nodi, palle di pane, assemblate in vario modo. Aiuta a fare il punto traccia scritta nella Guida gastronomica d'Italia del Touring club d'Italia, uscita nel 1931. In Alto Adige troviamo gnocchi neri (con farina di grano saraceno), oppure bianchi (con solo latte, uova, farina e lardo), così come verdi (con spinaci), soprattutto in val d'Isarco. Poi vi sono quelli di magro (con cipolle e prezzemolo). Infine quelli con il turbo di frattaglia, grazie al fegato macinato.
Al tempo valeva per tutti il prefisso knodl, preceduto secondo l'uso tedesco dall'ingrediente principale. Si usava servirli con pezzatura generosa, tanto che ne bastava uno posto al centro del piatto, servito in brodo, ma anche in declinazione asciutta, condito con burro, formaggio e una corona di cavoli acidi. A Meltina, poco sopra Bolzano, se ne servivano due identici, uno di grasso, uno di magro. Più a Sud, nelle valli trentine, le pezzature erano più piccole, simili alle attuali, della circonferenza tra i 4 e i 6 centimetri. Il termine canederlo appare solo più avanti, nel 1942. Loro tracce si trovano un po' in tutte le terre dell'ex impero austro ungarico. Dal Tirolo al bellunese, Friuli Venezia Giulia, ma anche sino alla Baviera, Polonia, repubblica Ceca e Slovacchia. Così come cambiano i nomi. Ecco le balotes delle valli ladine, i chinegli in Friuli come gnochi de pan a Trieste.
In tutte queste realtà la consolidata tradizione si è trasmessa di generazione in generazione come mirabile esempio di riciclo degli avanzi, una variante alpina di quanto si è fatto, da sempre, in tutta la penisola, basta pensare in Toscana alla ribollita oppure al pancotto veneto. Alla base vi è l'abilità nel confezionare l'impasto, che non deve essere né troppo molle, sfaldandosi poi nell'acqua bollente e salata, ma nemmeno troppo compatto anche perché la buona creanza ha regole precise. Con i canederli si usa il cucchiaio, per scomporli se serviti in brodo, oppure la forchetta nella versione asciutta. Mai il coltello perché sarebbe segno di poca creanza verso la cuoca. Canederli che, con il mutare dei costumi, sono diventati eclettici. Se tradizione prescriveva che venissero preparati solo il martedì e giovedì, la domenica in versione ricca (con speck e pancetta), e come piatto unico, adesso possono essere ambivalenti, dal primo al secondo, dove fanno contorno al goulash o a verdure di varia fatta, dai crauti alla cicoria selvatica.
Progressivamente ha preso piede la versione dolce, dove cambia completamente la lavorazione in quanto, al posto del pane raffermo, si usano patate e farina a fare una sfoglia che va poi a racchiudere, generalmente, prugne o albicocche, ma anche mele, aromatizzate in vario modo. Cotti nel burro e spolverati con zucchero a velo e chiodi di garofano. Una tradizione, quella del canederlo, che è diventata valore aggiunto alla promozione (e fidelizzazione) turistica nelle diverse vallate. A Vipiteno si svolge da oltre 20 anni la sagra del canederlo, con tanto di tavolata lunga 400 metri e un'offerta golosa che può passare per una settantina di varianti. In Valle d'Isarco, in autunno, si festeggia il Torggelen (il torchio per la vendemmia) con canederli, castagne e vino nuovo. In val Casies, a gennaio, si svolge la maratona dei canederli, un percorso (necessariamente) non competitivo in quanto i partecipanti si spostano da un maso all'altro, armati di sci da fondo, per scoprire le mille tentazioni offerte da canederli di varia fatta.
Canederli palestrati a Mezzano, nella valle di Primiero, dove si sono aggiudicati il guinnes di categoria, con una singola pezzatura di oltre 77 chili. Quantità e bellezza, con abbinata l'elezione di miss e mister canederlo, che vede in pista la migliore gioventù locale. Canederli consegnati a futura memoria quale Piatto del buon ricordo nello storico Beppe Sello di Cortina.
Ne è passato di tempo dall'assaggiatrice dipinta dall'anonimo artista medioevale. Adesso i canederli stanno esplorando nuovi percorsi golosi. Se, per secoli, è valsa la regola che il pane non si butta, ma si riutilizza, i canederli stanno assumendo una notevole elasticità di interpretazione. Ad esempio con abbinamenti marini che mai nessuno, fino a poco tempo fa, avrebbe immaginato. Ecco allora i canederli al baccalà, come pure salmone e spinaci. Fantasia mia fatti capanna con i canederli e le cozze in versione una e trina: nell'impasto, come nel brodo e poi a decorazione nella versione impepata.
Non poteva mancare, infine, la sfida tirolese al momento del dessert, ed ecco nascere i canederli di Mozart, che fanno il verso sornione a tradizione consolidata, farciti al cioccolato e guarniti con pistacchi, lamponi, menta e miele.