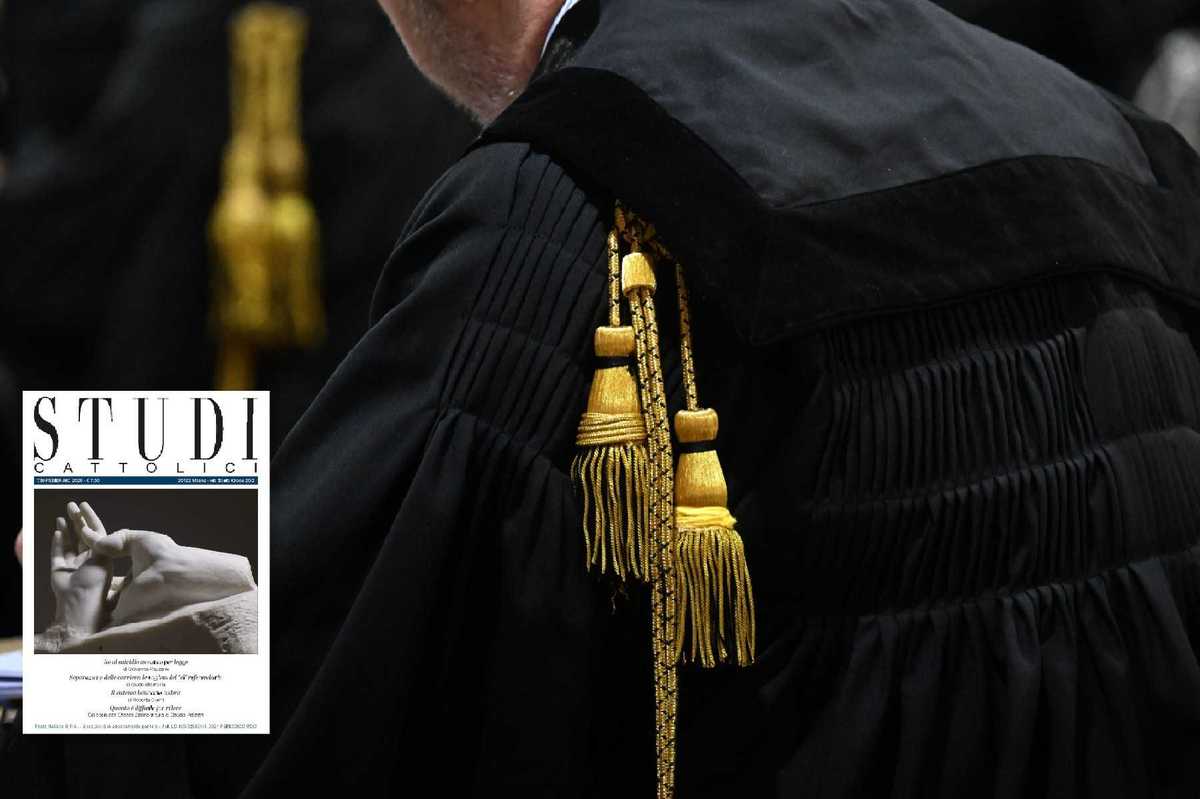C'era una casa tanto carina. L'Italia dei palazzi che cadono a pezzi
- La Penisola si sgretola: si contano 2 milioni di edifici abbandonati. Dei 200.000 immobili di valore architettonico oltre 6.000 presentano uno stato di degrado; ci sono 428 teatri chiusi e 450 tra chiese in rovina e castelli diroccati.
- Il Garante per i beni culturali di Napoli: «Più di duecento edifici ecclesiastici desolati».
- Il Sovrintendente al Teatro dell’Opera di Roma: «Dall’inizio del secolo l’offerta intellettuale nazionale ha perso 54 arene».
Lo speciale contiene tre articoli.
Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, striglia gli industriali sollecitandoli ad investire di più in cultura ma il ministero che dirige non può certo ergersi ad arbitro e dispensare bocciature. Gran parte del patrimonio storico artistico è in stato di totale abbandono e soffre un degrado quasi irreversibile. A questo si aggiunge il patrimonio immobiliare lasciato deperire per incuria o perché non più funzionale. È uno scenario fatiscente ed è difficile risalire la filiera delle responsabilità.
La Carta del Rischio della Direzione generale Sicurezza del Patrimonio culturale presso il ministero dei Beni Culturali, ha schedato oltre 200.000 beni immobili di valore architettonico e archeologico e in base agli esami finora effettuati, è stato rilevato che il 3% è in una condizione accertata di vulnerabilità e di degrado.
Una ricerca del Cescat-Centro Studi Casa Ambiente e Territorio di Assoedilizia, indica che ci sono oltre 2 milioni di edifici abbandonati e diroccati, prevalentemente ubicati nelle campagne, molti in posizioni panoramiche privilegiate, come casolari, baite, ville rustiche, antiche magioni, rocche, case cantoniere ma anche ex aree industriali.
La lista dei siti Unesco dichiarati Patrimonio mondiale dell’umanità, conta oltre 1.000 luoghi d’interesse distribuiti in tutti i continenti, e l’Italia è il Paese più rappresentato con 53 eccellenze (alle quali vanno aggiunte le 39 che hanno chiesto il riconoscimento senza riuscire, per ora, a ottenerlo).
Il patrimonio culturale appartiene a diversi soggetti giuridici, come lo Stato, le Regioni, i comuni, i privati, gli enti ecclesiastici, le fondazioni. Facile quindi fare lo scarica barile delle responsabilità.
Secondo i dati Eurostat, l’Italia è penultima in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura (peggio di noi fa solo la Grecia): 1,4% a fronte di una media Ue superiore al 2%. Quella che viene definita la «Penisola dei tesori» investe nella cura di queste ricchezze, meno di quanto fanno altri.
Numerosi siti archeologici, musei, chiese, palazzi e persino interi centri storici cadono a pezzi.
Italia Nostra ha elaborato una Lista Rossa, una mappa molto accurata del patrimonio abbandonato, in stato di degrado, su segnalazioni di privati. La lista comprende attualmente 450 beni tra castelli diroccati, chiese chiuse, piazze, borghi perfino grotte ed è in continuo aggiornamento. La finalità è di segnalare questo patrimonio a rischio al ministero dei Beni Culturali e alle Soprintendenze.
Tra i gioielli che compaiono nella Lista Rossa, c’è l’Abbazia di Santa Maria di Calena a Peschici, in provincia di Foggia, un insediamento monastico che risale all’XI secolo passato al Demanio e poi a privati che ne hanno fatto un’azienda agricola, ora un rudere. Eppure continua ad essere un punto di riferimento per la comunità locale. In totale abbandono e senza un piano di recupero, è l’acquedotto Pontificio di Loreto, unica opera idraulica con arcate ancora integre nelle Marche. In questa Regione, Italia Nostra segnala anche il Castello di Monte Varmine, in provincia di Ascoli che risale all’epoca longobarda, diroccato. A Reggio Calabria c’è il Convento dei Cappuccini del XVI secolo che contiene altari intarsiati in avorio e madreperla. È crollato in più parti, compreso il tetto. Al momento non si conoscono piani di recupero. Segnalato sempre da Italia Nostra il Canale Navile di Bologna, opera del Vignola del XVI secolo che rappresentava una delle più importanti vie di comunicazioni dell’Italia Settentrionale per lo scambio delle merci. Le strutture lungo il canale sono molto danneggiate con tetti crollati e azioni di vandalismo.
Un altro volto dell’Italia che cade a pezzi tra incuria, disattenzione e abbandono, è quello dei teatri. La patria di Goldoni e di Pirandello non riesce a tutelare i gioielli architettonici tramandati da una storia illustre. Il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Francesco Giambrone, ha guidato la realizzazione di un censimento ad opera di TeatriAperti, sui teatri dimenticati. La ricerca risale al 2008, ma da allora nulla è cambiato. Nel nostro Paese ci sono ben 428 teatri chiusi. Della maggior parte di essi, però, nessuno parla. Se è vero che in Italia ci sono circa 2.000 teatri, il censimento rivela che per ogni tre aperti ve ne è uno chiuso. Il 50% dei sipari abbassati sono in edifici storici di un qualche pregio architettonico. Sono concentrati soprattutto in Sicilia e Lombardia (rispettivamente 59 e 57). Oltre il 50% ha cessato la propria attività a partire dal 1980 e solo 12 (ossia poco meno del 3% circa) sono stati chiusi prima del 1940.
Tra le cause di chiusura, l’inagibilità è quella più ricorrente: il 31,7% dei teatri è stato infatti bloccato perché dichiarato inagibile mentre solo 47 (pari all’11% circa del totale) si sono fermati per lavori di restauro che usualmente si protraggono anche per decenni. Alcune strutture, dopo la chiusura, sono state destinate ad altri usi.
Report nell’inchiesta «Gli incompiuti» andata in onda ad aprile scorso, ha acceso i riflettori su alcune realtà di Venezia. Nel centro storico un gioiello architettonico di inizio Novecento, il Cinema Teatro Italia, oggi è un supermercato Despar.
Quanto costa alla comunità il degrado del Paese, culturale e artistico? Una domanda a cui nessuno si preoccupa di dare una risposta.
Giulio Pane: «La situazione del centro di Napoli è grave»
A Napoli è stata creata due mesi fa, la figura del Garante per i beni culturali ed il paesaggio, per la conservazione e valorizzazione di quello che è il centro storico più grande e importante d’Europa. Giulio Pane, già ordinario di Storia dell’Architettura all’Università Federico II, avrà il compito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini sulle eventuali criticità e sollecitare le amministrazioni competenti per una soluzione «in tempi ragionevoli». Questo è quanto sta scritto ma come stanno realmente le cose? «In ballo ci sono fondi europei per 100 milioni stanziati per il Progetto Unesco di valorizzazione del Centro storico di cui sono stati spesi al momento solo circa 20 milioni» afferma Pane. Non avrà vita facile. Sulla sua nomina è già scoppiata la polemica di chi lo accusa di «essere un doppione». Ma per Pane si profila anche la nomina a Garante per i Beni Culturali a livello nazionale. «La situazione del centro storico di Napoli è di estremo degrado. Sono più di duecento le chiese chiuse, abbandonate e spesso depredate delle loro opere d’arte. Alcune in rovina e pericolanti».
Ci fa qualche esempio?
«La Chiesa della Scorziata, una volta splendida e ricca di capolavori, ora è un cumulo di immondizia. Fu depredata dai ladri nel 1993 quando era chiusa già da molti anni a causa dei danni subiti con il sisma del 1980. Sparirono opere preziose. Molte chiese sono state riadattate, altre occupate trasformate in depositi di detersivi, fabbriche di infissi, abitazioni con tanto di citofoni o adibite a negozi e autofficine. A Marina di Ascea, un ex immobile religioso è stato trasformato in un residence di lusso contravvenendo alle norme paesaggistiche. Fabbricati religiosi sono stati trasformati in ristoranti e le aule delle chiese in luoghi di eventi e ricevimenti. Lo Sferisterio di Fuorigrotta è un simbolo del degrado della città. Nato nel 1950 come mega centro sportivo e poi per eventi, spettacoli e concerti, fu distrutto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 1986 da uno spaventoso incendio. Da allora numerosi i progetti di recupero mai andati in porto. C’è la situazione dei padiglioni dell’antica mostra di oltremare che stanno andando in malora. La cupola del Padiglione della Civiltà cristiana in Africa è crollata. Il Monastero delle Trentatré è in abbandono totale. Palazzo D’Avalos stava andando in malora perché il nuovo proprietario voleva suddividerlo in mini appartamenti. Poi è intervenuto il vincolo per il restauro».
C’è una mappatura del patrimonio degradato?
«Ci sono oltre 200 chiese inutilizzate in abbandono, oggetto di furti e vandalismi. Innumerevoli edifici privati di pregio storico che non riescono ad attingere i contributi pubblici per incapienza finanziaria dei proprietari».
Incapacità di spendere i fondi europei?
«Alcuni progetti presentati sono privi della rispondenza alle norme dei lavori pubblici. Talvolta manca la relazione geologica, e quando vanno a gara si bloccano».
Come può accadere una cosa del genere?
«Accade per superficialità, perché non c’è una formazione adeguata; e perché l’attuale normativa è complessa e onerosa. Talvolta però, anche se la documentazione non è accurata - e se le fosse evidenzierebbe un danno artistico o ambientale - passa lo stesso. È il caso dell’ascensore di monte Echia. L’altura di Pizzofalcone è stata l’antica sede di Partenope, e lì Lucio Lucullo aveva costruito una lussuosa villa in vista del mare, di cui sopravvivono alcuni ruderi. Bene, davanti ad essi sorge ora il volume tecnico di un ascensore pubblico che toglie la vista del paesaggio per una lunghezza di undici metri e un’altezza di quattro. La relazione paesaggistica del progetto se la sbrigava così: “L’ascensore sorge nel centro storico di Napoli”».
Francesco Giambrone: «Le politiche culturali per troppi anni sono state marginali»
«La causa principale in molti casi è diventata un alibi. Molti teatri chiudono quando vengono inasprite le norme sulla sicurezza, perché la cosa più facile è chiudere. Ed è quello che è accaduto al Teatro Massimo di Palermo. La realizzazione di una scala di uscita per il pubblico si doveva concludere in sei mesi ma il sipario del maggiore teatro in Europa, rimase calato per 23 anni». Perché, è una domanda ingenua e la risposta scontata. «Le politiche culturali nel nostro Paese sono state per troppi anni marginali e l’investimento nella cultura mai considerato pagante». C’è una nota di commozione nella voce del Sovrintendente al Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone, che ha lasciato il cuore nella sua Palermo dove, come Sovrintendente del Massimo, ne seguì le vicende della chiusura, poi della mobilitazione cittadina e della riapertura. «In Italia negli ultimi trent’anni, è stato costruito un solo teatro, a Firenze, il Teatro del Maggio Musicale fiorentino alle Cascine, mentre in Grecia e Spagna ne sono stati inaugurati a decine. Lasciamo andare in rovina i gioielli del passato e con essi distruggiamo gli unici luoghi di aggregazione laica. Il nostro Paese nella seconda metà dell’Ottocento aveva costruito l’Italia unita anche attraverso un investimento forte nella infastrutturazione culturale del territorio costruendo luoghi di spettacolo. Non c’era borgo in cui non ci fosse un teatro. Siamo andati verso un grande impoverimento».
Quali casi l’hanno più colpita in questa ricerca?
«Il censimento dei teatri chiusi realizzato nel 2008 con l’associazione TeatriAperti e Arcus, andrebbe aggiornato ma non penso che ci troveremmo di fronte a sorprese positive. Abbiamo individuato 428 teatri chiusi e il 25,5% è all’interno di edifici di valore storico e architettonico, sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali. Circa il 40% risalgono a prima del 1900. Tra questi c’è il Teatro Laluna del 1600 nel comune di Mineo a Catanzaro chiuso nel 1983 dopo essere stato trasformato in cine-teatro. La causa più frequente per il fermo dell’attività, nel 31,7% dei casi, è l’inagibilità, ma solo l’11% è stato chiuso per i lavori di restauro. Ci siamo trovati davanti realtà di pregio trasformate in palestre, magazzini, autorimesse. A Palermo la proprietà del teatro Bellini uno dei più antichi della città, voleva trasformalo in una pizzeria, ma la sovrintendenza bloccò il progetto. A Sciacca l’incredibile storia del teatro Samonà. Nato sulle macerie dello storico Teatro Politeama Mariano Rossi, i lavori iniziarono nel 1979 ma rimasero incompiuti per diversi anni. Nel 2015 è stato inaugurato ancora incompleto, poi di nuovo chiuso e adesso ancora si discute del suo futuro. Il Teatro Ernesto Rossi di Pisa, della seconda metà del Settecento, ha avuto una vita travagliata; nel 1977 è stato anche utilizzato come magazzino di oggetti smarriti. Quando dopo alcuni interventi di recupero, nel settembre 2004, sembrava che si potesse riavviare l’attività, la polizia giudiziaria bloccò tutto per notificare un sequestro conservativo. Pare ci fosse un cavillo burocratico legato alla sicurezza. Il sipario cala definitivamente, nonostante i successivi restauri della Soprintendenza. Un altro caso è il teatrino all’interno di Villa Raggio di Pontenure, in provincia di Piacenza, della seconda metà dell’Ottocento. Il parco è stato recuperato dopo anni di abbandono ma la villa e il teatrino, per gli alti costi di restauro, sono in degrado».
Quali sono le Regioni con il più alto numero di teatri chiusi?
«Le chiusure sono concentrate in Sicilia (59) e Lombardia (57). Dall’inizio del nuovo secolo l’offerta culturale nazionale ha perso 54 strutture tra teatri e cine-teatri di cui 17 solo nel 2006. Solo il 12% dei teatri chiusi censiti, nel 2008 era in possesso di un regolare certificato di agibilità e tra questi poco più del 40% è in fase di restauro. Nonostante la chiusura, alcune strutture, circa il 16% hanno continuato ad ospitare eventi culturali».
C’è speranza che i teatri chiusi vengano riaperti?
«È un obiettivo che dovrebbe rappresentare la priorità per qualsiasi politica culturale. Ma le riaperture devono essere vere, i lavori devono rispettare le scadenze programmate».