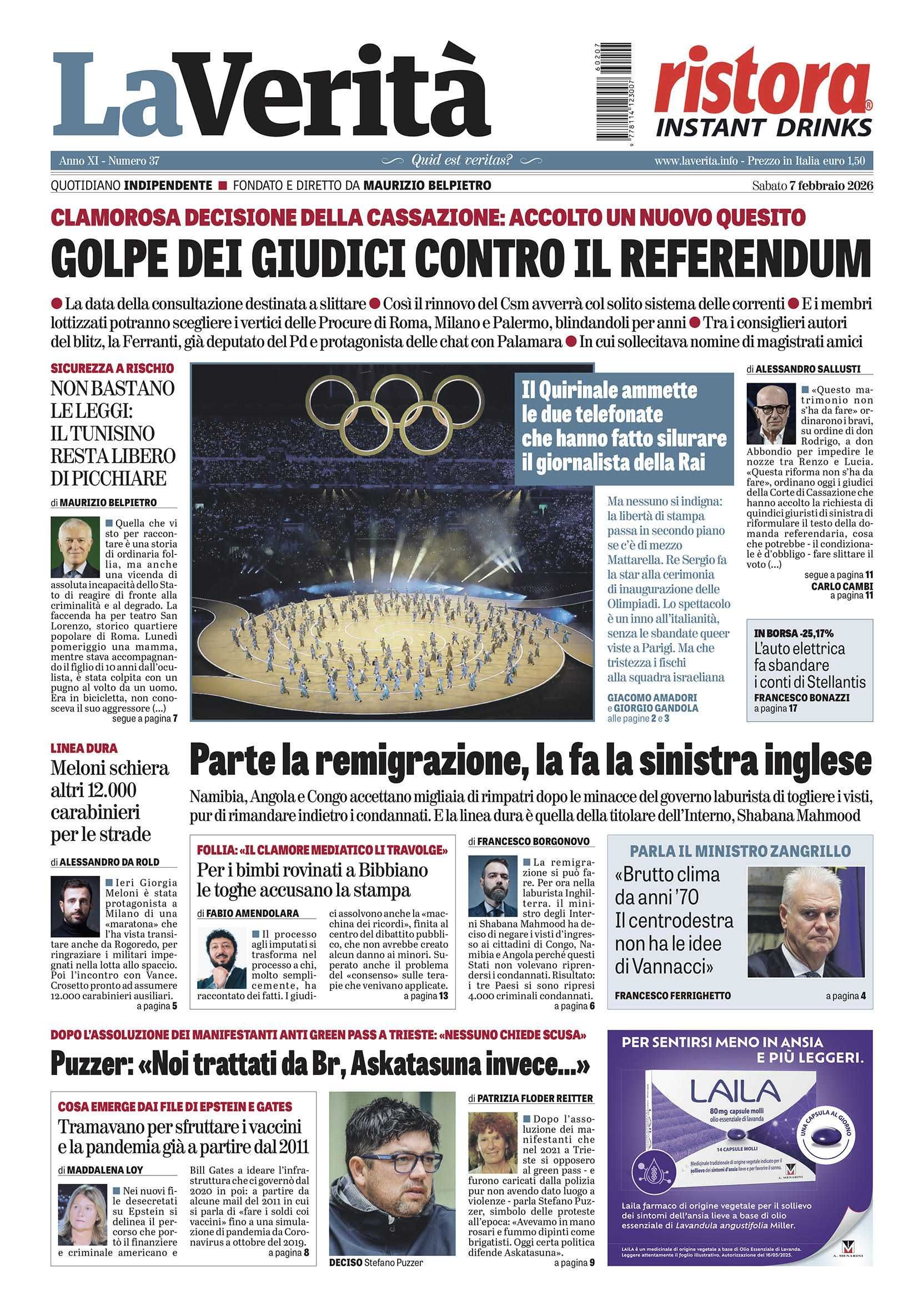«Atto dovuto» indagare i poliziotti. Falso: i pm lo fanno per «interesse»

Presidente di sezione emerito
della Corte di Cassazione
Ancora una volta sono stati iscritti nel registro degli indagati, come «atto dovuto», alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno cagionato la morte di una persona. Questa volta, com’è noto, l’ «atto dovuto» è stato posto in essere nei confronti degli agenti di polizia coinvolti nel conflitto a fuoco all’esito del quale è rimasto ucciso Michele Mastropietro, ricercato per essersi reso responsabile, poche ore prima, della morte, conseguita ad altro conflitto a fuoco, del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie. Chi scrive ha già avuto occasione di illustrare, con articoli comparsi sulla Verità del 25 luglio 2023 e del 4 gennaio 2025, le ragioni per le quali, stando a una rigorosa lettura delle vigenti disposizioni processuali, l’«atto dovuto» non sarebbe, in realtà, da ritenere tale. Ma poiché - come c’era da attendersi - quelle ragioni continuano ad essere nella prassi corrente del tutto ignorate, vale forse la pena, contando sulla pazienza dei lettori oltre che (con minor fiducia) sui possibili effetti del vecchio detto secondo cui «repetita juvant», tornare ancora ad illustrarle cercando di essere, se possibile, più chiari di quanto si sia stati in precedenza.
Cominciamo quindi col dire che, all’origine della ritenuta doverosità dell’iscrizione degli agenti nel registro degli indagati vi è il disposto dell’art. 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che «se per la morte di una persona sorge sospetto di reato», il procuratore della Repubblica debba accertarne la causa e, a tal fine, «se lo ravvisa necessario», debba ordinare «l’autopsia secondo le modalità previste dall’art. 360 del codice», cioè quelle dettate per l’effettuazione degli «accertamenti tecnici non ripetibili». E fra tali modalità vi è quella che dell’atto da compiere debba essere preventivamente avvisata, a pena di nullità, «la persona sottoposta alle indagini». Di qui la ritenuta necessità che, dovendosi effettuare l’autopsia e volendosi evitare il rischio della nullità, per il caso che da essa emergano elementi tali da rendere concretamente configurabili ipotesi di responsabilità penali a carico degli appartenenti alla polizia giudiziaria dalla cui azione è derivata la morte, costoro vengano previamente iscritti nel registro degli indagati, giacché altrimenti, mancherebbe la condizione per darsi luogo all’avviso.
L’apparente granitica saldezza di tale costruzione giuridica si sfalda, tuttavia, ove si consideri che non può automaticamente ritenersi che vi sia «sospetto di reato» per il solo fatto che la morte di taluno sia la conseguenza di una condotta posta in essere, nell’adempimento dei compiti d’istituto, da soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria. L’operato di questi ultimi, infatti, dev’essere puntualmente e dettagliatamente descritto e riferito nei verbali che essi sono tenuti a redigere e trasmettere, con la massima possibile sollecitudine, all’autorità giudiziaria; verbali cui è, pacificamente, attribuita la natura di «atti pubblici» facenti fede, come tali, per espressa disposizione di legge, «fino a querela di falso», dell’assoluta veridicità di quanto in essi attestato. Ne consegue che, qualora dalla descrizione dei fatti contenuta in tali verbali emerga con indiscutibile chiarezza che la polizia giudiziaria abbia agito in presenza (o nella legittimamente ritenuta presenza) di una o più delle cause di giustificazione previste dal codice penale - quali, in particolare, l’adempimento di un dovere, l’esercizio di un diritto, l’uso legittimo delle armi, la legittima difesa o lo stato di necessità - non può sorgere, a rigore, alcun «sospetto di reato», salvo che sussistano (e vengano esplicitate) specifiche ragioni sulla base delle quali possa ritenersi che quella descrizione non sia soltanto, in ipotesi, lacunosa o imprecisa (nel qual caso nulla impedirebbe al pubblico ministero di chiedere immediatamente ai verbalizzanti gli opportuni chiarimenti) ma sia, in tutto o in parte, volutamente mendace e finalizzata allo scopo di nascondere le responsabilità eventualmente configurabili a carico degli agenti operanti. Solo a tale condizione, quindi, l’iscrizione di costoro nel registro degli indagati può essere considerata come «atto dovuto», in vista della eventualmente ritenuta necessità dell’autopsia, con obbligo dei relativi avvisi. E, d’altra parte, a rafforzare la validità di quanto finora affermato, sta anche il fatto che, qualora nei verbali della polizia giudiziaria fosse scientemente taciuta o alterata, a scopo difensivo o per qualsiasi altra ragione, la verità dei fatti, ciò renderebbe configurabile, a carico di coloro che li avessero redatti e sottoscritti, il grave reato di falso ideologico in atto pubblico di «fede privilegiata», punibile con la reclusione da tre a dieci anni; reato che andrebbe, naturalmente, ad aggiungersi a quello di omicidio colposo, preterintenzionale o, addirittura, volontario che, a seconda dei casi, potrebbe pure configurarsi in conseguenza dell’esclusione della causa di giustificazione fittiziamente fatta apparire nei verbali come sussistente.
Se, dunque, da parte degli uffici del pubblico ministero, si continua comunque a parlare dell’iscrizione degli agenti operanti nel registro degli indagati come «atto dovuto» anche nei casi - tra i quali sembrerebbe rientrare quello della morte di Mastropietro - caratterizzati dalla conclamata esistenza, immediatamente percepibile, di cause di giustificazione tali da escludere ogni e qualsiasi ragionevole «sospetto» di reato, la spiegazione che, inevitabilmente, viene a presentarsi come la più plausibile è una soltanto: quella, cioè, che l’atto sia inteso come «dovuto» non a garanzia - come si vuole sostenere - del diritto degli agenti operanti di difendersi da accuse che, in realtà, non risultano neppure formulate, ma piuttosto a tutela degli stessi uffici del pubblico ministero dal pericolo di quelle che, altrimenti, potrebbero essere le facili accuse, di varia possibile provenienza e motivazione, di essersi passivamente appiattiti sulla versione dei fatti fornita dalla polizia giudiziaria senza verificare autonomamente l’ipotesi, anche se del tutto astratta, gratuita e generica, di una sua qualsivoglia divergenza dalla verità. Ribattere tali accuse richiederebbe, ovviamente, una buona dose di fatica e di grintosa determinazione, per cui la tentazione di optare piuttosto per il «quieto vivere» diventa quasi irresistibile. E pazienza per chi, solo per aver fatto il proprio dovere e aver avuto la fortuna di non lasciarci la pelle, è chiamato a pagarne le spese. Si tratta, in fin dei conti, per chi la vede dall’altra parte, di incerti del mestiere.