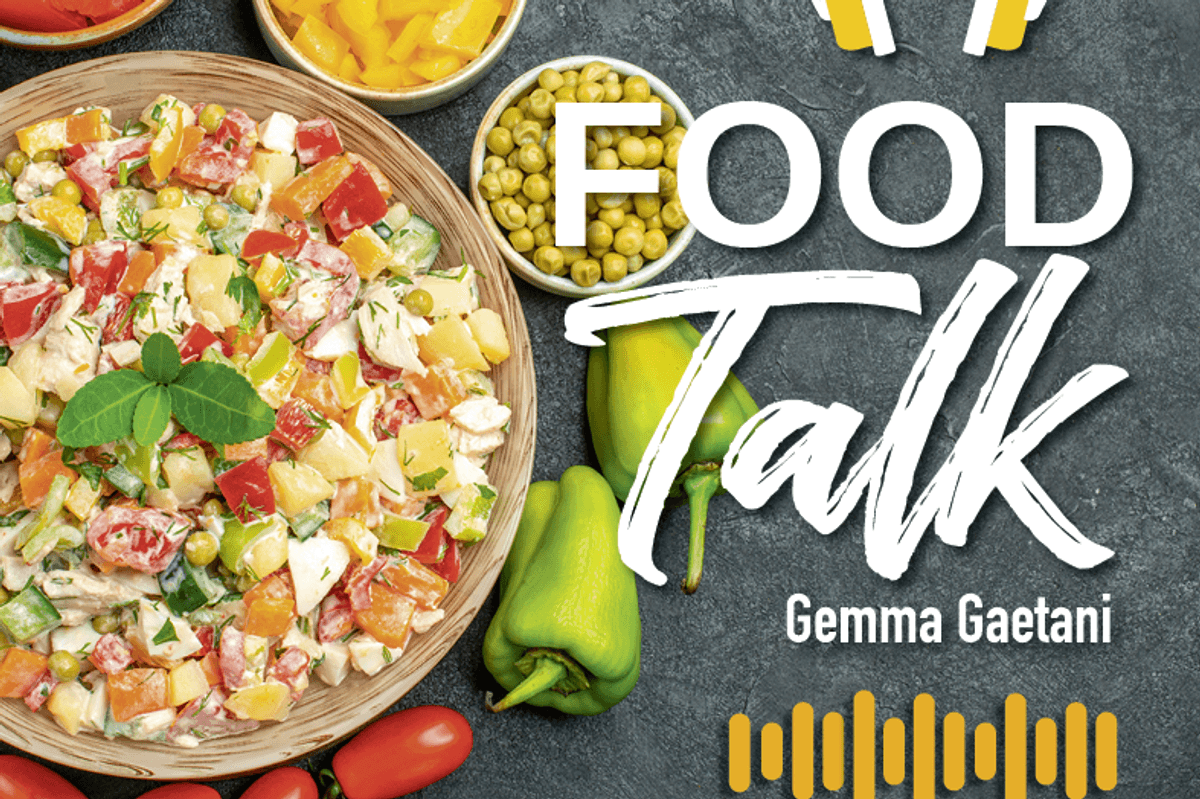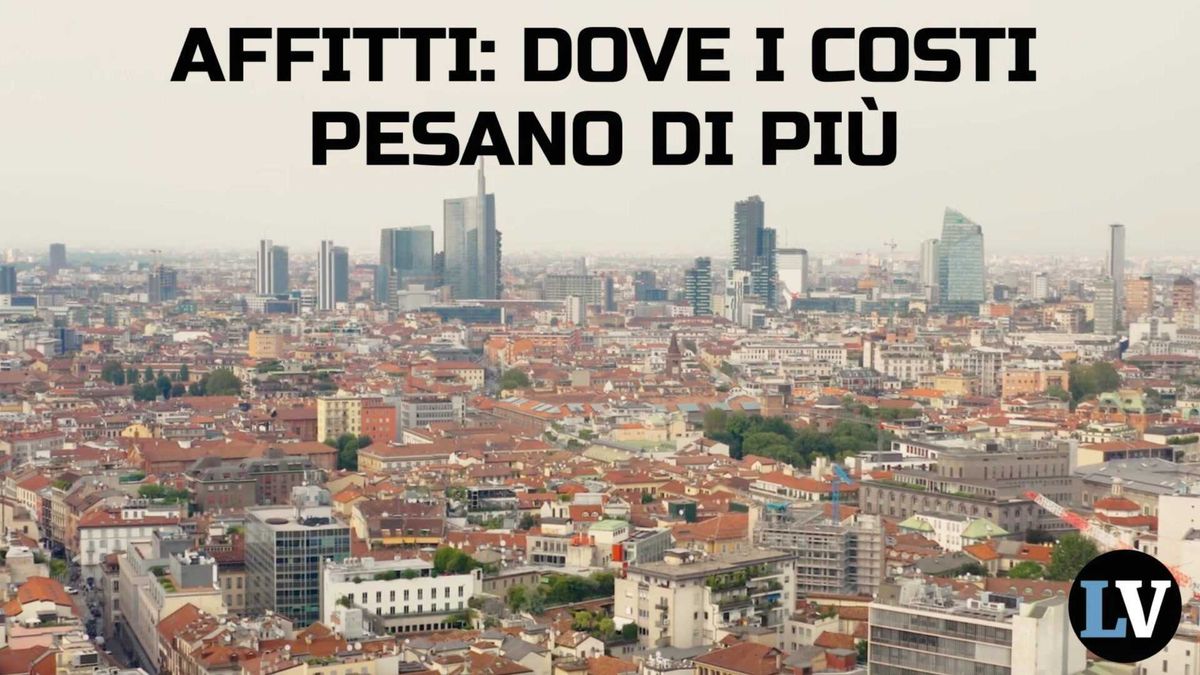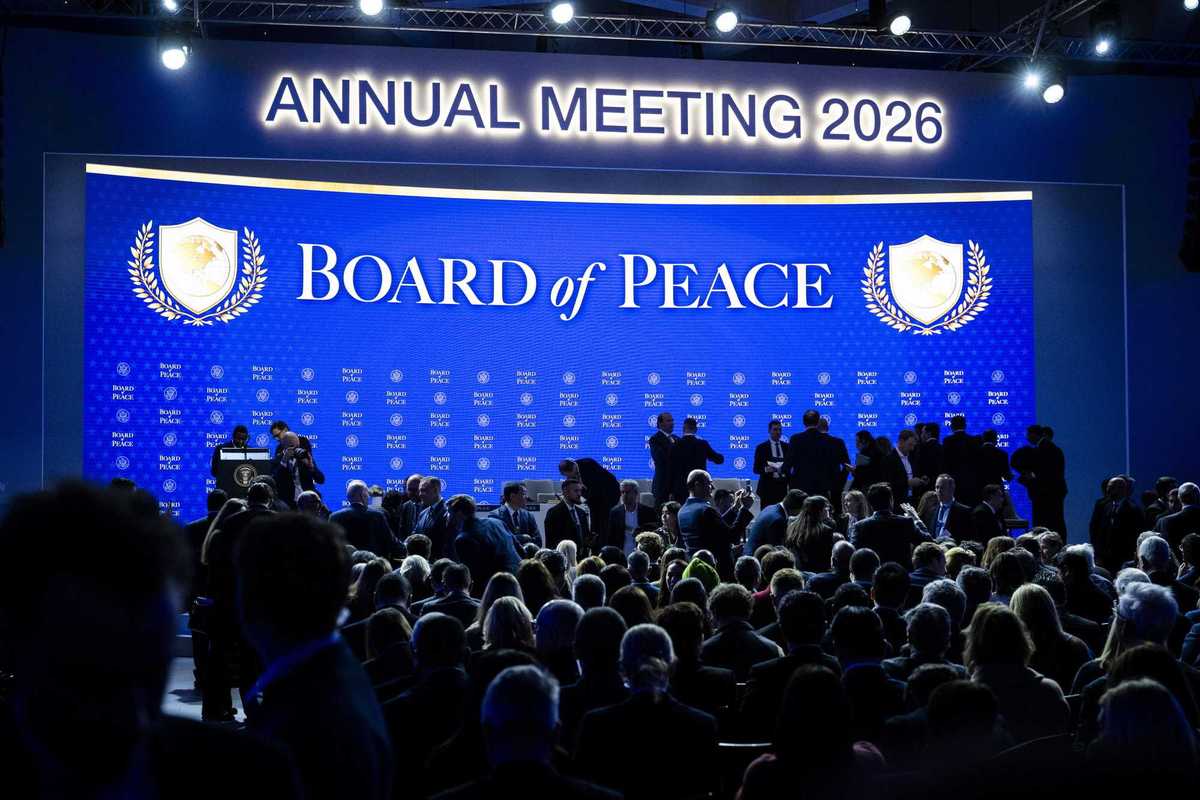Andrea De Carlo: «Oggi i maschi hanno paura a esprimere la loro natura»

Andrea De Carlo è stato il cantore di almeno una generazione. In alcuni dei suoi romanzi più celebri, ad esempio Due di due, ha messo in scena le speranze e i tormenti degli uomini e delle donne che avevano attraversato il Sessantotto, i loro sogni di cambiamento del sistema, la loro ricerca di libertà che - almeno in alcuni casi - riusciva ad andare oltre l’ideologia per farsi avventura esistenziale, tentativo di costruire un nuovo modo di vivere. In quei libri si respirava anche il tentativo di sottrarsi a un ambiente sociale e culturale giudicato opprimente, e persino una sorta di sfida alla modernità soffocante. Era, quella, la generazione che più di tutte aveva cercato di sfidare il Padre (simbolicamente e nella pratica), sottraendosi alla organizzazione tradizionale della famiglia per escogitare nuove soluzioni, non sempre finite bene. Insomma, tanti romanzi di De Carlo hanno colto, intuito, raccontato evoluzioni fondamentali, quelle che sarebbero esplose negli anni successivi e che hanno dato forma al mondo di oggi.
Ora lo scrittore sembra quasi risalire la corrente. Il suo nuovo libro di pubblicato dalla Nave di Teseo, La geografia del danno, è un viaggio nella tradizione e nella genealogia. Risale il fiume della storia raccontando genitori e nonni, e in fondo rimarca quanto sia importante il retaggio, quanto la famiglia e le sue ramificazioni influiscano sulla esistenza di ciascuno di noi persino quando sono sconosciute. Il libro inizia con leggerezza, con un racconto semplice e scorrevole, molto diretto e tutto sommato tranquillo. Ma ecco che, pagina dopo pagina, compaiono le increspature e il buco nero si allarga: in famiglia c’è un grande non detto, un mistero, una storia cruenta che nessuno voleva indagare, ma che l’autore porta fino all’estremo. Quello che possiamo dire di questo romanzo senza svelarne i colpi di scenda è che racconta tensioni potenti che si sono sviluppate dentro un famiglia. Tensioni che esplodono anche nella coppia, nei rapporti fra maschi e femmine. Di queste tensioni abbiamo parlato tanto nel corso della settimana, nei pressi della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Intorno a quella data e ad alcuni drammatici episodi violenti si è sviluppato un dibattito sul patriarcato e la sua eventuale persistenza in questa epoca.
De Carlo, esiste ancora il patriarcato o invece da qualche decennio, come dice qualcuno, siamo in una fase diversa? Lei ha raccontato nel romanzo varie generazioni: che cosa è cambiato nel tempo da questo punto di vista?
«Beh sì, il mio libro va indietro di tre generazioni, quindi fino agli ultimi decenni dell’Ottocento, all’epoca dei miei bisnonni che erano stati protagonisti di emigrazioni avventurose. I genitori di mia nonna erano piemontesi andati in Cile, all’altro lato del mondo, affrontando il viaggio più avventuroso e rischioso che si potesse fare. I genitori di mio nonno invece erano andati dalla Sicilia in Tunisia, come moltissimi loro conterranei alla ricerca di una nuova vita. Certo allora il patriarca era la figura di riferimento, per la sua famiglia e nella società. Aveva tutti i connotati del ruolo, l’aspetto, i vestiti, l’atteggiamento, i rapporti con gli altri membri della famiglia. Era lui che dettava le regole, una figura autoritaria che intimoriva, suscitava soggezione ma anche provvedeva alla famiglia e dirigeva le sue scelte, offriva organizzazione e protezione. Quel tipo di figura oggi non esiste esiste più nel nostro mondo occidentale, non la si trova. Quindi se si vuole usare il termine patriarcato lo si fa in senso metaforico, per parlare di come la società continui, almeno in molti campi, a discriminare le donne dal punto di vista sociale e culturale. Ma come sempre ogni slogan implica una semplificazione, la creazione di un bianco e nero che non riproduce tutte le sfumature della realtà» .
Lei ha raccontato nei suoi romanzi il momento della storia italiana, dal Sessantotto in avanti, in cui i giovani si sono ribellati a quel sistema che ha appena descritto, e hanno tentato tramite la ricerca di un modo di vivere alternativo di sfuggire a quel padre simbolico che identificavano con una autorità che mal sopportavano. Che cosa è rimasto di quella stagione? Che cosa ha prodotto quella fuga dall’autorità?
«Ha prodotto da un lato la rottura di una crosta che imprigionava la società, le impediva di crescere, ostacolava la trasformazione che ogni tempo deve avere per dare spazio alle nuove generazioni, alle loro esigenze e ai loro sogni Però questo ha comportato anche altre conseguenze, per esempio la fuga dai ruoli. E questo ha avuto effetti contrastanti: per esempio è difficile oggi trovare un uomo che almeno manifestamente pretenda di avere un rapporto di dominanza nei confronti delle donne. Però è anche vero che gli uomini hanno in gran parte rinunciato a essere rassicuranti e protettivi, e questo è certamente uno svantaggio per le donne. Poi si è creata una grande confusione generazionale. Oggi è molto facile vedere genitori che cercano di assomigliare disperatamente ai loro figli. Nella rottura alla fine degli anni Sessanta di cui parlavamo prima c’era stata una fortissima contrapposizione culturale fra generazioni, dal modo di vestirsi alla musica che si ascoltava, ai rapporti tra i sessi. Oggi le generazioni sono sfumate al punto che nonni, genitori e figli spesso si vestono nello stesso modo, usano lo stesso linguaggio, mangiano gli stessi cibi, ascoltano le stesse canzoni. E questo non è necessariamente un bene per le nuove generazioni, che faticano a definirsi».
Insomma abbiamo buttato il padre con l’acqua sporca: l’autorità non c’è più e questo significa che se da un lato c’è meno rischio di autoritarismo, dall’altro si è creato - soprattutto nei maschi - un notevole spaesamento.
«Credo che lo spaesamento sia evidente. Un po’ si manifesta in forma di paura di esprimere certi caratteri che sono tipici del maschio, che fanno parte della sua natura. E c’è un’infantilizzazione del maschio, che spesso tende a pensare e a comportarsi come un bambino. All’inizio si parlava della sindrome di Peter Pan, che suggerisce immagini anche poetiche, fantasiose, evoca voli verso isole esotiche e affascinanti. Però l’infantilizzazione può avere aspetti estremamente sgradevoli e negativi. Si può creare una figura di bambino che non vuole crescere, si rifiuta di farlo perché non vuole assumersi responsabilità né rispetto al mondo né rispetto a sé stesso».
Un bambino che a volte è anche capriccioso, rabbioso e violento. Del resto i bambini sanno anche essere molto crudeli e non hanno remore nell’attaccare gli altri, talvolta nel bullizzarli. In effetti l’eterno bambino può essere molto pericoloso.
«Sì, c’è sempre l’equivoco che quella del bambino sia una dimensione meravigliosa dell’essere umano, perché è così sincero, così spontaneo, così fantasioso. Ma il bambino concentra spesso in sé anche tutti i lati più negativi dell’essere umano. Per esempio è di un egocentrismo assoluto, vuole far ruotare intorno a sé il mondo dei suoi genitori, pretende senza sosta attenzione e affetto, impone le sue regole. Tant’è che il bambino è diventato anche un arbitro dei consumi. Basta guardare le pubblicità alla televisione e si vede come non solo i fabbricanti di biscotti e merendine, ma anche le case automobilistiche e le agenzie immobiliari siano ben consapevoli del ruolo dei bambini nelle scelte dei loro genitori. Sono sempre più spesso loro a spingere verso una decisione, e padri e madri li assecondano con sempre meno resistenza. Anche questa è una trasformazione curiosa della società».