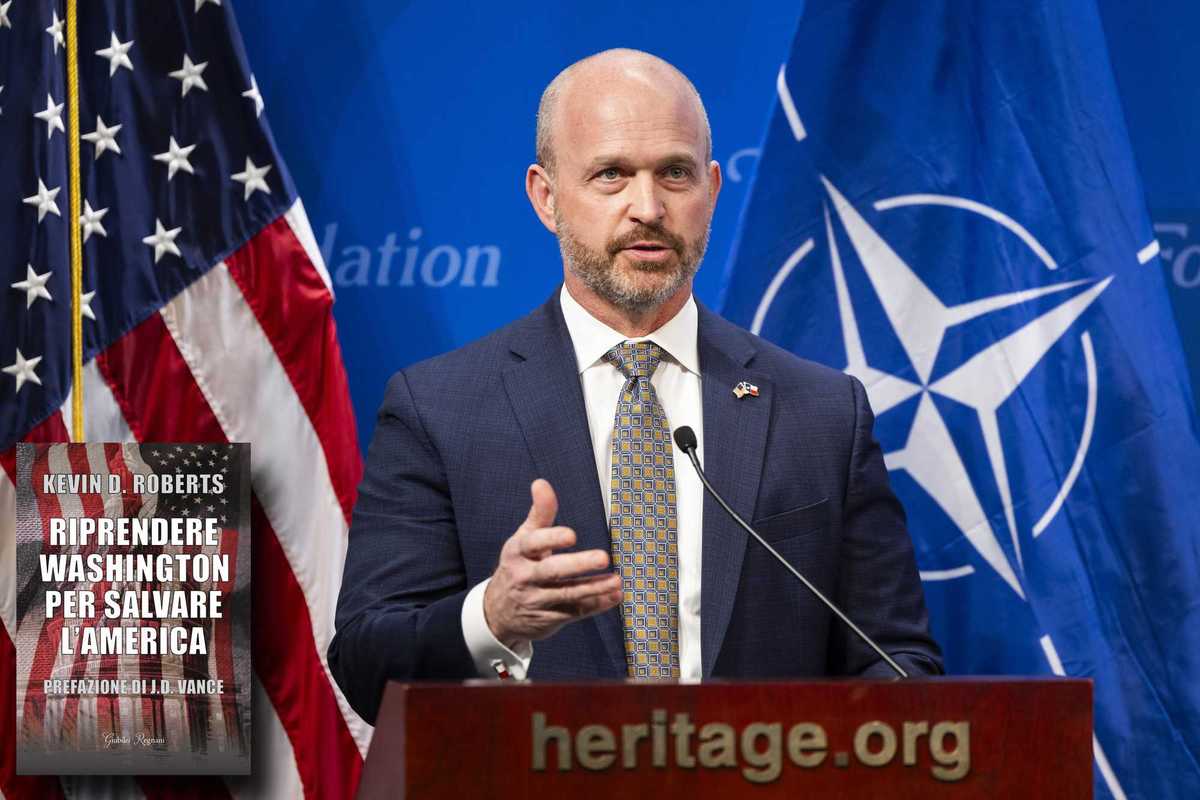True
2024-02-19
Ventennio social
Ansa
Bei tempi quando il diciannovenne Mark Zuckerberg, programmatore e studente di psicologia, animava la community dell’università di Harvard inventando dal suo dormitorio il giochino online del «libro dei volti». Lanciato il 4 febbraio 2004 (si festeggiano in questi giorni i suoi primi vent’anni di attività), «Thefacebook» - diventato oggi la più importante piattaforma social del mondo - contava all’epoca una media di poco più di 300 iscritti ed era una sorta di trombinoscopio digitale: consentiva di mantenere i legami con famiglia e parenti e ritrovare vecchie conoscenze. Passano due anni e nel settembre 2006 Facebook, che nel frattempo ha perso il «the», si fa conoscere al grande pubblico: in tutto il mondo, i giovani iniziano febbrilmente a mandarsi inviti e a diventare «amici», che lo siano o meno nella vita reale, per ciabattare sulla «bacheca» virtuale dei loro corrispondenti, indagare sugli stati d’animo e curiosare su foto e liste di amici.
Per tutta la generazione di chi oggi ha fra i 30 e i 40 anni, il numero di amici su Facebook ha messo a dura prova l’ego e rappresentato la misura della propria «popolarità», istituzionalizzata nel 2009 con l’introduzione del «mi piace». È in questo preciso momento che Facebook, nato come diario intimo condiviso, diventa modello di business, usato da privati, aziende e politici per commercializzare prodotti, consenso elettorale e sentimenti. È con l’istituzione del pollice blu del «gradimento», funzione iconica e preziosa informazione fornita spontaneamente dall’utente alla piattaforma, consentendole di intercettare i suoi gusti e tenerlo connesso il più a lungo possibile (e fargli vedere più pubblicità possibili), che Facebook perde la sua anima e diventa l’infernale macchina che, pochi giorni fa, ha trascinato il suo ideatore davanti al Senato Usa per rispondere di «danni inflitti online». Zuckerberg e il ceo di Snapchat, Evan Spiegel, hanno partecipato a un’audizione convocata per indagare sullo sfruttamento sessuale minorile online e si sono trovati di fronte genitori che hanno addebitato le tragiche morti dei propri figli all’uso dei social. Erano presenti anche altri amministratori delegati, tra cui Linda Yaccarino di X (ex Twitter) e Shou Zi Chew di TikTok. La dichiarazione introduttiva di Zuckerberg - «gli studi non mostrano un nesso causale tra l’uso dei social e il disagio mentale dei giovani» - ha irritato gli astanti. «Hai le mani sporche di sangue», gli hanno detto, e alla fine si è scusato: «Mi dispiace per tutto ciò che avete passato». C’è da dire che a qualcuno potrebbe apparire una forzatura scambiare le tragedie con i contenitori che le hanno veicolate, fatto sta che - dal vecchio libro dei volti che riduceva i famosi sei gradi di separazione, a strumento di morte - soltanto il patrimonio su cui siede Zuckerberg, stimato da Forbes in 104,3 miliardi di dollari, può motivare l’impassibilità con la quale l’ex studente di psicologia continua a dissociarsi dalle proprie responsabilità, dando così il colpo di grazia alla sua creatura.
Dopo il debutto pubblico e per tutto il decennio successivo Facebook continua ad evolversi offrendo nuovi tipi di interfaccia grafica, le news e l’implementazione di nuove funzioni come i sei pulsanti di reazione. Il passo verso l’ingresso in Borsa, il 17 maggio del 2012, è breve: la piattaforma lancia quindi Messenger, acquista Instagram e, nel 2014, Whatsapp, poi nel 2015 cominciano gli streaming video.
È nel marzo 2018 che scoppia il primo grande scandalo che colpisce duramente la reputazione della piattaforma. La società Cambridge Analytica, creata dall’ideologo di Donald Trump, Steve Bannon, raccoglie i dati di 87 milioni di utenti, soprattutto americani, per attività di marketing politico. Né più né meno di quanto già fatto nel 2012 da Barak Obama che, grazie a un’applicazione Facebook scaricata da oltre un milione di persone, accede ai loro dati. L’anno dopo la Federal Trade Commission commina una sanzione civile di 5 miliardi di dollari, cui si aggiunge quella di 100 milioni della Sec. A fine 2019 Facebook perde nel dark web i dati di 267 milioni di suoi utenti, lo stesso anno Bloomberg rivela che la piattaforma trascrive le chat Messenger degli utenti, mentre Zuckerberg lancia la sua criptovaluta «libra». Nel 2020 un’altra tegola: il Dipartimento di Giustizia Usa accusa Facebook di aver intenzionalmente creato un sistema di assunzioni che impedisce agli americani qualificati di candidarsi a determinate posizioni; a ottobre 2021 il gruppo patteggia per 14,25 milioni di dollari. A settembre del 2021 il caso dell’ex dipendente Frances Haugen, che rivela che il social ha volontariamente chiuso gli occhi sulle conseguenze dannose sulla salute mentale degli utenti. A gennaio 2022, la Cnil francese infligge a Facebook una multa di 60 milioni di euro per non aver permesso agli utenti di rifiutare i cookies (che consentono di indirizzare agli utenti pubblicità personalizzata, molto più remunerativa degli annunci generici). Nel marzo 2022, la Commissione Ue apre un'inchiesta contro Meta (casa madre di Facebook) per violazione della concorrenza sulla pubblicità online. Infine, i Facebook Files, attraverso i quali emerge il volto autoritario di Zuckerberg. Il filo diretto tra la piattaforma e le autorità politiche e mediche americane in pandemia conduce alla censura di qualsiasi contenuto critico della gestione pandemica. Scatta la mannaia dei fact-checkers: «Come distinguete i fatti dalle opinioni?», gli chiede il giornalista Lex Fridman. «Siamo pratici, ci limitiamo a domandarci se quell’informazione causa danni alle persone o no», risponde Zuck. La famosa «violazione degli standard della community»: stabiliti in nome di quale legge?
Privacy, profilazione, censura, fact-checking fazioso: addebiti non indifferenti per un giochino nato per mettere in relazione le persone. È vero che i giovani ci si avvicinano di meno, preferendogli TikTok, Instagram e Snapchat, ma oggi (dati 2023) più di tre miliardi di utenti aprono Facebook almeno una volta al mese, il 3% in più rispetto al 2022; la piattaforma di Zuckerberg è diventata una potenza politica mondiale, le sue azioni valgono 475 dollari. Risultati record, dunque, ma la reputazione è compromessa: il quotidiano francese Le Figaro ha commentato il ventesimo anniversario di Facebook lanciando un sondaggio dal titolo «I social network hanno fatto progredire la società?». L’86% ha risposto «no». Come dargli torto?
Tutti «condividiamo» un po’ di meno ma a disconnetterci non riusciamo
Bei tempi quando postavamo la torta di compleanno del pargolo con una candelina e il viaggio in Messico di nonna Clotilde sulle orme di Montezuma. Adesso il pargolo si sta laureando in Digital Marketing e la parente ha concluso anche l’ultimo, di viaggio. Vent’anni di vita, 20 anni di Facebook, ma sembrano molti di più. Allora un piatto di risotto al radicchio, un weekend a Foppolo, perfino un’avventura sexy avevano senso non «nel durante fisico e metafisico», ma quando venivano messi online. Delirio collettivo, voglia di libertà, eccesso di stupidità. Gli intellettuali, che detestano i fenomeni pop, catalogarono così quel periodo: «Facebook è un oceano di banalità condiviso da persone con vite così vuote che si sente l’eco». In questo caso l’eco era quella di Umberto Eco.
Quando arrivò il social network (2004) immediatamente lo accomunammo all’Ufficio Facce allestito da Diego Abatantuono e Beppe Viola alla pasticceria Gattullo di Milano negli anni Settanta. I clienti entravano e loro lì a catalogarli: «Tu hai la faccia da milanista, siediti qui. Tu hai il naso da interista, vai di là». Al banco servivano il famigerato panino «Triplo Special» che, come diceva Enzo Jannacci, «era davvero unico. Il materiale impiegato per la confezione avrebbe potuto risolvere i più gravi problemi di alcuni Paesi del terzo mondo». Niente di nuovo, facce e cibarie; ha cominciato così anche Mark Zuckerberg. Ed è invecchiato fra una convocazione e l’altra al Congresso degli Stati Uniti a giustificare 20 anni di privacy violata, di bug nel sistema di sicurezza, di condizionamenti politici nel nome del globalismo progressista, di fake news e di censure «per garantire la libertà di pensiero». Strano approccio. Il mito della rete campione di democrazia è durato qualche anno facendo abboccare i più ingenui. Ora quel meraviglioso mondo interconnesso sembra entrato in crisi.
I giovani lo snobbano. I millennials fuggono da Facebook dopo averlo bollato con una parola, «boring», che per loro significa molto più di noioso. Si tengono alla larga perché lo ritengono sorpassato, troppo di scrittura (il post del tornitore Brambilla con la pretesa di copiare Alessandro Baricco è patetico). Loro sono «visual», quindi si tuffano su Instagram e su Tik Tok, anche se ammettono che Facebook resta una fabbrica di click. Gli amici si tengono in contatto su Whatsapp, l’onanismo intellettuale si esprime meglio su X. Così, nell’età adulta, la effe è diventata un contenitore di community. Gruppi di quartiere, gruppi per gite in montagna, gruppi di italiani all’estero, gruppi di studenti che cercano un monolocale (o una tenda) a Milano. Una piattaforma di collegamento.
Chi pensa che abbia ancora appeal per veicolare opinioni è fuori strada. Al massimo si postano pensierini della sera, articoli di giornalisti in pensione con ricordi stupendi, consigli di pseudo-esperti. Al terzo commento tutti svaccano e si passa direttamente al vaffa. Siamo più nervosi. Il caso di Chiara Ferragni dimostra che anche per gli influencer non è più la stagione del bengodi: Facebook ha inventato i venditori di fuffa, ha dato loro il benessere, poi li ha trasferiti su Instagram (dove le foto vengono meglio) e infine li fa a fette travolgendoli di scandali e di shitstorm, che sarebbero gli insulti nel ventilatore.
Secondo l’analisi Radar per Swg, l’uso che facciamo di Facebook (o Meta che dir si voglia) è molto diverso dagli esordi: chi è ancora iscritto naviga meno e lo fa con studiata passività. Siamo diventati voyeur delle vite degli altri ma condividiamo il nostro privato con prudenza. Dopo avere regalato ogni dato sensibile postando le foto delle vacanze, stringendo amicizie di sconosciuti, mettendo in bella mostra i figli, facendo sapere a tutti (anche ai ladri) quando andavamo in ferie, forse abbiamo riscoperto la sobrietà.
Però siamo ancora in tanti. Tre miliardi di persone, il 60% di chi naviga in Internet. Facebook rimane il più grande contenitore di pubblicità al mondo dopo Google. Grazie a noi il signor Zuck, solo nel terzo trimestre del 2023, ha incassato 34 miliardi di dollari. Lui è riuscito nel delitto perfetto: trasformare l’infrastruttura digitale da qualcosa che possediamo a qualcosa che ci possiede. Come diceva quel baro: «Se dopo due giri di poker non hai ancora capito chi è il pollo, significa che il pollo sei tu». Oggi per un italiano su tre il bilancio è severo: «Facebook ha portato danni alla società e ci ha reso prede facili di notizie false e dipendenti dalle sue dinamiche». Il social più vecchio ha fomentato opachi movimenti sociali, dal #MeToo e #BlackLivesMatter alle Primavere arabe, alla rivolta di Capitol Hill; ha scatenato il peggio nel lessico polemico con gli haters, ha contribuito a una polarizzazione politica senza precedenti.
In Italia gli effetti sociali sul cambiamento dei costumi sono evidenti. Di fatto i social hanno azzoppato l’informazione di carta infischiandosene dei diritti d’autore, hanno messo in crisi la professione del giornalista cancellando l’intermediazione culturale. Lo abbiamo toccato con mano durante il Covid, quando Rocco Casalino organizzava le famose dirette online per il premier Giuseppe Conte bypassando i cronisti. Oggi i politici istruiscono le loro greggi a colpi di post senza il fastidio delle domande scomode. Tutto vero, ma continuiamo a connetterci. Centrosinistra o centrodestra? Come dice Roberto D’Agostino, anche 20 anni dopo «prevale il centrotavola».
Miliardario per caso «Zuck» ora studia il jiu-jitsu e la politica
Un fenomeno nato per caso ma che si è trasformato nel giro di soli vent’anni in una macchina che genera miliardi ma soprattutto in uno degli strumenti di potere più persuasivi al mondo. Facebook nasce come Facemash, in un notte di ottobre del 2003. Mark Zuckerberg, studente di Harvard, è reduce da un appuntamento andato male e forse spinto da un sentimento di rivalsa nei confronti del genere femminile, si siede al computer e partorisce l’idea del secolo: creare un sito dove caricare tutte le foto degli studenti del college e dove si può votare la preferita tra due foto che il sistema seleziona casualmente. Mark è un genietto dell’informatica e riesce ad hackerare i database degli studentati di Harvard e ad estrarre foto e nomi degli studenti. Nel giro di quattro ore Facemash attira 450 visitatori e 22.000 click sulle foto. I server dell’università vanno in crash e i vertici di Harvard intervengono. Il sistema viene bloccato e Zuckerberg è punito con sei mesi di sospensione. Per l’università era una «ragazzata» che doveva finire lì, ma Mark intuisce che ha nelle mani qualcosa di grosso. A gennaio 2004 registra il dominio thefacebook.com, ha inizio la storia del social network più visitato al mondo, che ora conta oltre due miliardi di iscritti.
Usualmente Facebook viene associato a Zuckerberg ma la storia dimentica i suoi colleghi universitari che contribuirono a creare il social: Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Una vera squadra, nella quale ognuno ha il suo compito: c’è chi sviluppa l’algoritmo, chi si occupa degli aspetti aziendali e di marketing. A metà del 2004 Zuckerberg e i soci fondatori aprono la società Facebook, Inc. La voce del successo si sparge nel mondo finanziario e cominciano a bussare gli investitori. Nel 2005, Zuckerberg riceve 12,7 milioni dalla società Accel Partners. In molti gli chiedono di vendere, ma Mark rifiuta le offerte di Yahoo! e Mtv Network e si concentra sull’espansione del sito. Così quando Microsoft intuisce che in giro c’è una gallina dalle uova d’oro è già troppo tardi. A ottobre 2007, per rilevare solo l’1,6%, deve tirar fuori 240 milioni di dollari.
Poi arriva la grande finanza. Il 3 gennaio 2011 Goldman Sachs chiede di poter entrare nel capitale di Facebook. La banca d’affari è disposta a investire 450 milioni di dollari. Mark capisce che è il momento di fare il grande salto: il 18 maggio 2012 sbarca a Wall Street con una delle Ipo (un’offerta pubblica di vendita) più grandi della storia degli Usa. Nella prima giornata di contrattazioni Facebook vende azioni per 16 miliardi di dollari, facendo salire il suo valore a 104 miliardi di dollari. È il valore più alto mai registrato per una new entry a Wall Street. Non c’è che dire per un ragazzo di appena 27 anni che all’informatica alternava la passione per i poemi epici. Pare che spesso nelle riunioni degli albori di Facebook amasse stupire citando versi dell’Eneide.
La passione per le arti marziali e in particolare per il jiu-jitsu brasiliano, invece è più recente, risale alla pandemia. Uno sport nel quale Mark si è gettato a capofitto riuscendo a ottenere una medaglia d’oro e una d’argento durante un torneo ma che ha tenuto gli investitori col fiato sospeso quando ha pubblicato una foto su Facebook in cui era sdraiato su un letto di ospedale, con il volto sorridente ma stanco di chi ha appena subìto un’operazione (il crociato anteriore rotto mentre si allenava).
Torniamo alla sua vita. Nel giro di pochi anni Mark si trova catapultato dalla piccola città di Dobbs Ferry, a circa 10 miglia a nord di New York, dove era cresciuto insieme alle tre sorelle, con un padre dentista e una madre psichiatra, nel regno della finanza e un patrimonio di svariati miliardi di dollari. Dal debutto a Wall Street sono traguardi su traguardi.
Nel 2010 l’acquisto di Snaptu e Beluga che consentono di ottimizzare Facebook Messenger App, la piattaforma di messaggistica e nello stesso anno arriva il tasto «Mi piace». Sempre nel 2010 il Time inserisce Zuckerberg tra le 100 persone più ricche e influenti del mondo. Anche il cinema si interessa alla sua storia con il film The Social Network. Nel maggio 2013, a 28 anni è il più giovane Ceo della lista Fortune 500 e l’anno dopo la rivista Forbes, lo incorona 5° uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 72,3 miliardi di dollari. Nel 2012 il grande colpo con l’acquisto di Instagram per circa 1 miliardo e di Glancee, la piattaforma che unisce utenti per vicinanza geografica e stessi interessi. Due anni dopo arriva WhatsApp, acquisita per 16 miliardi di dollari.
I media si sono sempre interrogati sul Zuck politico. Lui si è sempre trincerato dietro la frase «non sono né di destra né di sinistra» ma dopo l’elezione di Trump si è schierato contro le misure protezionistiche e di restrizione dei flussi migratori tanto che si parlò di una sua discesa in campo. Secondo il Center for responsive politics, Zuckerberg ha speso almeno 600.000 dollari in attività di lobbying nel 2013 per favorire la riforma dell’immigrazione dell’allora governo Obama. Ma risulta che abbia finanziato politici sia democratici che repubblicani a titolo individuale o attraverso Facebook Pac inc. Secondo una stima del portale ThoughtCo, nel 2016 il comitato ha investito 517.000 dollari nella campagna elettorale e il 56% è andato a candidati repubblicani anche se Trump non ha mai nascosto antipatia verso alcune posizioni pro immigrazione del patron di Facebook.
Zuck al pari di Warren Buffett e di Bill Gates si è buttato nella corporate philantropy, la filantropia aziendale orientando i fondi verso programmi di educazione digitale dei bambini ma anche per l’immigrazione. Nel 2015 dona 5 milioni di dollari a The Dream, un fondo scolastico per giovani immigrati.
Alle scorse elezioni americane del 2020, secondo il New York Post, Zuck ha speso 419 milioni di dollari a favore di organizzazioni che hanno assistito gli uffici elettorali favorendo il voto di Biden in alcuni Stati chiave. Eppure Biden parlando con il New York Times nel 2020 diceva di «non essere mai stato un fan di Facebook e di Zuckerberg».
Soldi e potere hanno bisogno gli uni dell’altro, non è una novità. Vedremo cosa farà alle prossime elezioni.
Continua a leggereRiduci
Nel febbraio 2004 nasceva Facebook. Inizialmente strumento per fare amicizie, oggi è la piattaforma più influente del mondo. E le sue ombre sono aumentate: dalla privacy degli utenti violata alla censura delle opinioni «non corrette»I giovani preferiscono Instagram o TikTok, eppure la «effe» rimane fabbrica di click.La fortuna del fondatore comincia quando da studente hackera i computer di Harvard. La passione per l’Eneide e per i migranti.Lo speciale contiene tre articoliBei tempi quando il diciannovenne Mark Zuckerberg, programmatore e studente di psicologia, animava la community dell’università di Harvard inventando dal suo dormitorio il giochino online del «libro dei volti». Lanciato il 4 febbraio 2004 (si festeggiano in questi giorni i suoi primi vent’anni di attività), «Thefacebook» - diventato oggi la più importante piattaforma social del mondo - contava all’epoca una media di poco più di 300 iscritti ed era una sorta di trombinoscopio digitale: consentiva di mantenere i legami con famiglia e parenti e ritrovare vecchie conoscenze. Passano due anni e nel settembre 2006 Facebook, che nel frattempo ha perso il «the», si fa conoscere al grande pubblico: in tutto il mondo, i giovani iniziano febbrilmente a mandarsi inviti e a diventare «amici», che lo siano o meno nella vita reale, per ciabattare sulla «bacheca» virtuale dei loro corrispondenti, indagare sugli stati d’animo e curiosare su foto e liste di amici. Per tutta la generazione di chi oggi ha fra i 30 e i 40 anni, il numero di amici su Facebook ha messo a dura prova l’ego e rappresentato la misura della propria «popolarità», istituzionalizzata nel 2009 con l’introduzione del «mi piace». È in questo preciso momento che Facebook, nato come diario intimo condiviso, diventa modello di business, usato da privati, aziende e politici per commercializzare prodotti, consenso elettorale e sentimenti. È con l’istituzione del pollice blu del «gradimento», funzione iconica e preziosa informazione fornita spontaneamente dall’utente alla piattaforma, consentendole di intercettare i suoi gusti e tenerlo connesso il più a lungo possibile (e fargli vedere più pubblicità possibili), che Facebook perde la sua anima e diventa l’infernale macchina che, pochi giorni fa, ha trascinato il suo ideatore davanti al Senato Usa per rispondere di «danni inflitti online». Zuckerberg e il ceo di Snapchat, Evan Spiegel, hanno partecipato a un’audizione convocata per indagare sullo sfruttamento sessuale minorile online e si sono trovati di fronte genitori che hanno addebitato le tragiche morti dei propri figli all’uso dei social. Erano presenti anche altri amministratori delegati, tra cui Linda Yaccarino di X (ex Twitter) e Shou Zi Chew di TikTok. La dichiarazione introduttiva di Zuckerberg - «gli studi non mostrano un nesso causale tra l’uso dei social e il disagio mentale dei giovani» - ha irritato gli astanti. «Hai le mani sporche di sangue», gli hanno detto, e alla fine si è scusato: «Mi dispiace per tutto ciò che avete passato». C’è da dire che a qualcuno potrebbe apparire una forzatura scambiare le tragedie con i contenitori che le hanno veicolate, fatto sta che - dal vecchio libro dei volti che riduceva i famosi sei gradi di separazione, a strumento di morte - soltanto il patrimonio su cui siede Zuckerberg, stimato da Forbes in 104,3 miliardi di dollari, può motivare l’impassibilità con la quale l’ex studente di psicologia continua a dissociarsi dalle proprie responsabilità, dando così il colpo di grazia alla sua creatura. Dopo il debutto pubblico e per tutto il decennio successivo Facebook continua ad evolversi offrendo nuovi tipi di interfaccia grafica, le news e l’implementazione di nuove funzioni come i sei pulsanti di reazione. Il passo verso l’ingresso in Borsa, il 17 maggio del 2012, è breve: la piattaforma lancia quindi Messenger, acquista Instagram e, nel 2014, Whatsapp, poi nel 2015 cominciano gli streaming video. È nel marzo 2018 che scoppia il primo grande scandalo che colpisce duramente la reputazione della piattaforma. La società Cambridge Analytica, creata dall’ideologo di Donald Trump, Steve Bannon, raccoglie i dati di 87 milioni di utenti, soprattutto americani, per attività di marketing politico. Né più né meno di quanto già fatto nel 2012 da Barak Obama che, grazie a un’applicazione Facebook scaricata da oltre un milione di persone, accede ai loro dati. L’anno dopo la Federal Trade Commission commina una sanzione civile di 5 miliardi di dollari, cui si aggiunge quella di 100 milioni della Sec. A fine 2019 Facebook perde nel dark web i dati di 267 milioni di suoi utenti, lo stesso anno Bloomberg rivela che la piattaforma trascrive le chat Messenger degli utenti, mentre Zuckerberg lancia la sua criptovaluta «libra». Nel 2020 un’altra tegola: il Dipartimento di Giustizia Usa accusa Facebook di aver intenzionalmente creato un sistema di assunzioni che impedisce agli americani qualificati di candidarsi a determinate posizioni; a ottobre 2021 il gruppo patteggia per 14,25 milioni di dollari. A settembre del 2021 il caso dell’ex dipendente Frances Haugen, che rivela che il social ha volontariamente chiuso gli occhi sulle conseguenze dannose sulla salute mentale degli utenti. A gennaio 2022, la Cnil francese infligge a Facebook una multa di 60 milioni di euro per non aver permesso agli utenti di rifiutare i cookies (che consentono di indirizzare agli utenti pubblicità personalizzata, molto più remunerativa degli annunci generici). Nel marzo 2022, la Commissione Ue apre un'inchiesta contro Meta (casa madre di Facebook) per violazione della concorrenza sulla pubblicità online. Infine, i Facebook Files, attraverso i quali emerge il volto autoritario di Zuckerberg. Il filo diretto tra la piattaforma e le autorità politiche e mediche americane in pandemia conduce alla censura di qualsiasi contenuto critico della gestione pandemica. Scatta la mannaia dei fact-checkers: «Come distinguete i fatti dalle opinioni?», gli chiede il giornalista Lex Fridman. «Siamo pratici, ci limitiamo a domandarci se quell’informazione causa danni alle persone o no», risponde Zuck. La famosa «violazione degli standard della community»: stabiliti in nome di quale legge?Privacy, profilazione, censura, fact-checking fazioso: addebiti non indifferenti per un giochino nato per mettere in relazione le persone. È vero che i giovani ci si avvicinano di meno, preferendogli TikTok, Instagram e Snapchat, ma oggi (dati 2023) più di tre miliardi di utenti aprono Facebook almeno una volta al mese, il 3% in più rispetto al 2022; la piattaforma di Zuckerberg è diventata una potenza politica mondiale, le sue azioni valgono 475 dollari. Risultati record, dunque, ma la reputazione è compromessa: il quotidiano francese Le Figaro ha commentato il ventesimo anniversario di Facebook lanciando un sondaggio dal titolo «I social network hanno fatto progredire la società?». L’86% ha risposto «no». Come dargli torto?<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ventennio-social-2667307775.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="tutti-condividiamo-un-po-di-meno-ma-a-disconnetterci-non-riusciamo" data-post-id="2667307775" data-published-at="1708245057" data-use-pagination="False"> Tutti «condividiamo» un po’ di meno ma a disconnetterci non riusciamo Bei tempi quando postavamo la torta di compleanno del pargolo con una candelina e il viaggio in Messico di nonna Clotilde sulle orme di Montezuma. Adesso il pargolo si sta laureando in Digital Marketing e la parente ha concluso anche l’ultimo, di viaggio. Vent’anni di vita, 20 anni di Facebook, ma sembrano molti di più. Allora un piatto di risotto al radicchio, un weekend a Foppolo, perfino un’avventura sexy avevano senso non «nel durante fisico e metafisico», ma quando venivano messi online. Delirio collettivo, voglia di libertà, eccesso di stupidità. Gli intellettuali, che detestano i fenomeni pop, catalogarono così quel periodo: «Facebook è un oceano di banalità condiviso da persone con vite così vuote che si sente l’eco». In questo caso l’eco era quella di Umberto Eco. Quando arrivò il social network (2004) immediatamente lo accomunammo all’Ufficio Facce allestito da Diego Abatantuono e Beppe Viola alla pasticceria Gattullo di Milano negli anni Settanta. I clienti entravano e loro lì a catalogarli: «Tu hai la faccia da milanista, siediti qui. Tu hai il naso da interista, vai di là». Al banco servivano il famigerato panino «Triplo Special» che, come diceva Enzo Jannacci, «era davvero unico. Il materiale impiegato per la confezione avrebbe potuto risolvere i più gravi problemi di alcuni Paesi del terzo mondo». Niente di nuovo, facce e cibarie; ha cominciato così anche Mark Zuckerberg. Ed è invecchiato fra una convocazione e l’altra al Congresso degli Stati Uniti a giustificare 20 anni di privacy violata, di bug nel sistema di sicurezza, di condizionamenti politici nel nome del globalismo progressista, di fake news e di censure «per garantire la libertà di pensiero». Strano approccio. Il mito della rete campione di democrazia è durato qualche anno facendo abboccare i più ingenui. Ora quel meraviglioso mondo interconnesso sembra entrato in crisi. I giovani lo snobbano. I millennials fuggono da Facebook dopo averlo bollato con una parola, «boring», che per loro significa molto più di noioso. Si tengono alla larga perché lo ritengono sorpassato, troppo di scrittura (il post del tornitore Brambilla con la pretesa di copiare Alessandro Baricco è patetico). Loro sono «visual», quindi si tuffano su Instagram e su Tik Tok, anche se ammettono che Facebook resta una fabbrica di click. Gli amici si tengono in contatto su Whatsapp, l’onanismo intellettuale si esprime meglio su X. Così, nell’età adulta, la effe è diventata un contenitore di community. Gruppi di quartiere, gruppi per gite in montagna, gruppi di italiani all’estero, gruppi di studenti che cercano un monolocale (o una tenda) a Milano. Una piattaforma di collegamento. Chi pensa che abbia ancora appeal per veicolare opinioni è fuori strada. Al massimo si postano pensierini della sera, articoli di giornalisti in pensione con ricordi stupendi, consigli di pseudo-esperti. Al terzo commento tutti svaccano e si passa direttamente al vaffa. Siamo più nervosi. Il caso di Chiara Ferragni dimostra che anche per gli influencer non è più la stagione del bengodi: Facebook ha inventato i venditori di fuffa, ha dato loro il benessere, poi li ha trasferiti su Instagram (dove le foto vengono meglio) e infine li fa a fette travolgendoli di scandali e di shitstorm, che sarebbero gli insulti nel ventilatore. Secondo l’analisi Radar per Swg, l’uso che facciamo di Facebook (o Meta che dir si voglia) è molto diverso dagli esordi: chi è ancora iscritto naviga meno e lo fa con studiata passività. Siamo diventati voyeur delle vite degli altri ma condividiamo il nostro privato con prudenza. Dopo avere regalato ogni dato sensibile postando le foto delle vacanze, stringendo amicizie di sconosciuti, mettendo in bella mostra i figli, facendo sapere a tutti (anche ai ladri) quando andavamo in ferie, forse abbiamo riscoperto la sobrietà. Però siamo ancora in tanti. Tre miliardi di persone, il 60% di chi naviga in Internet. Facebook rimane il più grande contenitore di pubblicità al mondo dopo Google. Grazie a noi il signor Zuck, solo nel terzo trimestre del 2023, ha incassato 34 miliardi di dollari. Lui è riuscito nel delitto perfetto: trasformare l’infrastruttura digitale da qualcosa che possediamo a qualcosa che ci possiede. Come diceva quel baro: «Se dopo due giri di poker non hai ancora capito chi è il pollo, significa che il pollo sei tu». Oggi per un italiano su tre il bilancio è severo: «Facebook ha portato danni alla società e ci ha reso prede facili di notizie false e dipendenti dalle sue dinamiche». Il social più vecchio ha fomentato opachi movimenti sociali, dal #MeToo e #BlackLivesMatter alle Primavere arabe, alla rivolta di Capitol Hill; ha scatenato il peggio nel lessico polemico con gli haters, ha contribuito a una polarizzazione politica senza precedenti. In Italia gli effetti sociali sul cambiamento dei costumi sono evidenti. Di fatto i social hanno azzoppato l’informazione di carta infischiandosene dei diritti d’autore, hanno messo in crisi la professione del giornalista cancellando l’intermediazione culturale. Lo abbiamo toccato con mano durante il Covid, quando Rocco Casalino organizzava le famose dirette online per il premier Giuseppe Conte bypassando i cronisti. Oggi i politici istruiscono le loro greggi a colpi di post senza il fastidio delle domande scomode. Tutto vero, ma continuiamo a connetterci. Centrosinistra o centrodestra? Come dice Roberto D’Agostino, anche 20 anni dopo «prevale il centrotavola». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ventennio-social-2667307775.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="miliardario-per-caso-zuck-ora-studia-il-jiu-jitsu-e-la-politica" data-post-id="2667307775" data-published-at="1708281056" data-use-pagination="False"> Miliardario per caso «Zuck» ora studia il jiu-jitsu e la politica Un fenomeno nato per caso ma che si è trasformato nel giro di soli vent’anni in una macchina che genera miliardi ma soprattutto in uno degli strumenti di potere più persuasivi al mondo. Facebook nasce come Facemash, in un notte di ottobre del 2003. Mark Zuckerberg, studente di Harvard, è reduce da un appuntamento andato male e forse spinto da un sentimento di rivalsa nei confronti del genere femminile, si siede al computer e partorisce l’idea del secolo: creare un sito dove caricare tutte le foto degli studenti del college e dove si può votare la preferita tra due foto che il sistema seleziona casualmente. Mark è un genietto dell’informatica e riesce ad hackerare i database degli studentati di Harvard e ad estrarre foto e nomi degli studenti. Nel giro di quattro ore Facemash attira 450 visitatori e 22.000 click sulle foto. I server dell’università vanno in crash e i vertici di Harvard intervengono. Il sistema viene bloccato e Zuckerberg è punito con sei mesi di sospensione. Per l’università era una «ragazzata» che doveva finire lì, ma Mark intuisce che ha nelle mani qualcosa di grosso. A gennaio 2004 registra il dominio thefacebook.com, ha inizio la storia del social network più visitato al mondo, che ora conta oltre due miliardi di iscritti. Usualmente Facebook viene associato a Zuckerberg ma la storia dimentica i suoi colleghi universitari che contribuirono a creare il social: Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Una vera squadra, nella quale ognuno ha il suo compito: c’è chi sviluppa l’algoritmo, chi si occupa degli aspetti aziendali e di marketing. A metà del 2004 Zuckerberg e i soci fondatori aprono la società Facebook, Inc. La voce del successo si sparge nel mondo finanziario e cominciano a bussare gli investitori. Nel 2005, Zuckerberg riceve 12,7 milioni dalla società Accel Partners. In molti gli chiedono di vendere, ma Mark rifiuta le offerte di Yahoo! e Mtv Network e si concentra sull’espansione del sito. Così quando Microsoft intuisce che in giro c’è una gallina dalle uova d’oro è già troppo tardi. A ottobre 2007, per rilevare solo l’1,6%, deve tirar fuori 240 milioni di dollari. Poi arriva la grande finanza. Il 3 gennaio 2011 Goldman Sachs chiede di poter entrare nel capitale di Facebook. La banca d’affari è disposta a investire 450 milioni di dollari. Mark capisce che è il momento di fare il grande salto: il 18 maggio 2012 sbarca a Wall Street con una delle Ipo (un’offerta pubblica di vendita) più grandi della storia degli Usa. Nella prima giornata di contrattazioni Facebook vende azioni per 16 miliardi di dollari, facendo salire il suo valore a 104 miliardi di dollari. È il valore più alto mai registrato per una new entry a Wall Street. Non c’è che dire per un ragazzo di appena 27 anni che all’informatica alternava la passione per i poemi epici. Pare che spesso nelle riunioni degli albori di Facebook amasse stupire citando versi dell’Eneide. La passione per le arti marziali e in particolare per il jiu-jitsu brasiliano, invece è più recente, risale alla pandemia. Uno sport nel quale Mark si è gettato a capofitto riuscendo a ottenere una medaglia d’oro e una d’argento durante un torneo ma che ha tenuto gli investitori col fiato sospeso quando ha pubblicato una foto su Facebook in cui era sdraiato su un letto di ospedale, con il volto sorridente ma stanco di chi ha appena subìto un’operazione (il crociato anteriore rotto mentre si allenava). Torniamo alla sua vita. Nel giro di pochi anni Mark si trova catapultato dalla piccola città di Dobbs Ferry, a circa 10 miglia a nord di New York, dove era cresciuto insieme alle tre sorelle, con un padre dentista e una madre psichiatra, nel regno della finanza e un patrimonio di svariati miliardi di dollari. Dal debutto a Wall Street sono traguardi su traguardi. Nel 2010 l’acquisto di Snaptu e Beluga che consentono di ottimizzare Facebook Messenger App, la piattaforma di messaggistica e nello stesso anno arriva il tasto «Mi piace». Sempre nel 2010 il Time inserisce Zuckerberg tra le 100 persone più ricche e influenti del mondo. Anche il cinema si interessa alla sua storia con il film The Social Network. Nel maggio 2013, a 28 anni è il più giovane Ceo della lista Fortune 500 e l’anno dopo la rivista Forbes, lo incorona 5° uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 72,3 miliardi di dollari. Nel 2012 il grande colpo con l’acquisto di Instagram per circa 1 miliardo e di Glancee, la piattaforma che unisce utenti per vicinanza geografica e stessi interessi. Due anni dopo arriva WhatsApp, acquisita per 16 miliardi di dollari. I media si sono sempre interrogati sul Zuck politico. Lui si è sempre trincerato dietro la frase «non sono né di destra né di sinistra» ma dopo l’elezione di Trump si è schierato contro le misure protezionistiche e di restrizione dei flussi migratori tanto che si parlò di una sua discesa in campo. Secondo il Center for responsive politics, Zuckerberg ha speso almeno 600.000 dollari in attività di lobbying nel 2013 per favorire la riforma dell’immigrazione dell’allora governo Obama. Ma risulta che abbia finanziato politici sia democratici che repubblicani a titolo individuale o attraverso Facebook Pac inc. Secondo una stima del portale ThoughtCo, nel 2016 il comitato ha investito 517.000 dollari nella campagna elettorale e il 56% è andato a candidati repubblicani anche se Trump non ha mai nascosto antipatia verso alcune posizioni pro immigrazione del patron di Facebook. Zuck al pari di Warren Buffett e di Bill Gates si è buttato nella corporate philantropy, la filantropia aziendale orientando i fondi verso programmi di educazione digitale dei bambini ma anche per l’immigrazione. Nel 2015 dona 5 milioni di dollari a The Dream, un fondo scolastico per giovani immigrati. Alle scorse elezioni americane del 2020, secondo il New York Post, Zuck ha speso 419 milioni di dollari a favore di organizzazioni che hanno assistito gli uffici elettorali favorendo il voto di Biden in alcuni Stati chiave. Eppure Biden parlando con il New York Times nel 2020 diceva di «non essere mai stato un fan di Facebook e di Zuckerberg». Soldi e potere hanno bisogno gli uni dell’altro, non è una novità. Vedremo cosa farà alle prossime elezioni.
Elisabetta Gardini (Imagoeconomica)
La proposta di legge a prima firma Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia può essere considerata solo un ricordo. «In merito alle notizie riportate dalla stampa sulla proposta di legge in materia di disciplina condominiale, si precisa che la pdl in questione è stata formalmente ritirata», ha chiarito ieri la Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio a seguito della notizia pubblicata da La Verità, sull’iniziativa presa dal comitato tecnico della riforma di inviare alle associazioni di settore una convocazione per aprire tavoli di confronto. Nella missiva che La Verità ha potuto leggere c’era scritto: «Questo comitato tecnico, su mandato degli onorevoli deputati firmatari, sta procedendo con i tavoli di confronto con le parti sociali interessate allo scopo di raccogliere il loro prezioso contributo. Questa proposta», si legge ancora, «è un cantiere aperto e quindi il vostro contributo è ritenuto essenziale e funzionale alla costruzione di una versione definitiva alla proposta che possa , così, riscontrare le segnalazioni di tutti». E poi: «Tanto premesso, codesta associazione/organizzazione è convocata al tavolo che si terrà il giorno...». Seguivano in calce i nomi dei rappresentanti del comitato, Francesco Schena, Pietrantonio Lisi e Carlo Pikler, oltre all’indicazione del comitato tecnico riforma del condominio, onorevole Elisabetta Gardini. Così l’esponente di FdI ha precisato: «La proposta di legge è stata formalmente ritirata». Il caso quindi è chiuso (resta da capire in nome di chi il comitato stesse inviando queste lettere di convocazione) e i proprietari di immobili possono tirare un sospiro di sollievo. D’altronde se in molti auspicano da tempo una riforma della normativa, è pur vero che il testo presentato a dicembre scorso affrontava la materia in modo profondamente penalizzante per i condomini. Tant’è che subito dalle forze politiche della maggioranza era arrivata una levata di scudi. A cominciare dalla Lega che aveva parlato di testo «con evidenti criticità e non condiviso» facendo intendere in modo esplicito che non c’era una scelta collegiale. Anche Forza Italia aveva preso le distanze e per bocca del responsabile del dipartimento casa, Roberto Rosso, che aveva annunciato «una nuova proposta di riforma sulla disciplina dei condomìni». Mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, aveva chiarito. «È una proposta che, come molte altre, è in discussione alla Camera. Trattandosi di una proposta è indispensabile un confronto tra tutti i soggetti interessati in grado di costruire una posizione di buon senso a tutela della casa degli italiani, senza la quale Fratelli d’Italia ritiene che non potrà proseguire il suo iter».
Insomma, nessuna forza politica sembrava interessata a portare avanti un testo che svantaggia i condomìni moltiplicando la burocrazia e creando i presupposti per una situazione caotica nella gestione degli immobili. Si prevedeva, per esempio, la creazione presso il Mimit (il ministero del Made in Italy), di un elenco nazionale pubblico degli amministratori che avrebbero dovuto essere in possesso di laurea. Poi, lo stop ai pagamenti in contanti e l’obbligo di versare i saldi su uno conto corrente dedicato, postale o bancario, intestato al condominio. Inoltre le informazioni relative alla sicurezza delle parti comuni dell’edificio avrebbero dovuto essere verificate e certificate da una società specializzata.
Gli immobili con oltre 20 condomìni, poi, dovevano dotarsi di un revisore. Il punto più controverso era un altro: chi è in regola con i pagamenti finisce per pagare anche per chi è moroso? I creditori infatti possono agire sulle somme sul conto corrente condominiale (alimentato da chi è in regola con i pagamenti) e in via sussidiaria sui beni dei condomìni in base alla morosità di ciascuno e infine su chi ha sempre pagato. Dopo il danno la beffa. Che a questo punto sembra davvero scampata.
Continua a leggereRiduci
Christine Lagarde (Ansa)
È la versione monetaria del «non correte tutti verso l’uscita, le porte restano aperte». In altre parole, la Bce sta costruendo un sistema per evitare vendite obbligate prima ancora che qualcuno pensi di farle. Psicologia dei mercati. Mentre a Bruxelles si discute con tono solenne di integrazione dei mercati dei capitali e di mobilitare il risparmio europeo c’è chi ha deciso di affrontare la questione da un’angolazione sorprendente. I Paesi Bassi hanno scelto di cambiare radicalmente il modo in cui tassano le rendite finanziarie, comprese le criptovalute La riforma entrerà in vigore nel 2028 ma ha già acceso un dibattito degno di un seminario di filosofia morale.
La Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi ha approvato una riforma che certo non agevola gli investimenti. Non sarà tassato solo l’incasso, ma anche ciò che aumenta di valore. Se il portafoglio cresce, anche senza vendere nulla, per il fisco quel guadagno esiste già. È reddito. È imponibile.
È la tassazione dell’arricchimento potenziale. Una metafisica fiscale che Platone avrebbe probabilmente apprezzato. E non importa se questo sistema porterà a vendite forzate visto che i risparmiatori potrebbero essere privi della liquidità necessaria per pagare la tassa.
Il vecchio sistema - che applicava rendimenti teorici stabiliti dallo Stato - era stato demolito dalla magistratura perché giudicato lesivo del diritto di proprietà.
Immobili e partecipazioni in start-up restano fuori. Continueranno a essere tassate solo al momento della vendita - segno che l’economia reale va trattata con cautela. La ricchezza finanziaria, invece, può essere misurata anno per anno, quasi fosse un termometro sociale. Anche le cripto entrano nel perimetro. E qui non è difficile leggere la preoccupazione delle autorità per un fenomeno che cresce più rapidamente delle categorie fiscali tradizionali.
La Nederlandsche Bank ha registrato l’aumento costante degli investimenti digitali tra famiglie e istituzioni, segnale che il confine tra risparmio e speculazione diventa sempre più sfumato. La banca calcola un ammontare di 1,2 miliardi nell’ottobre 2025, rispetto agli 81 milioni di fine 2020. Il settore finanziario deteneva ulteriori 113 milioni di euro in criptovalute direttamente in portafoglio nel terzo trimestre del 2025. Il segretario di Stato al Tesoro, Eugène Heijnen, ha difeso la riforma pur riconoscendo che si poteva fare meglio. Ma il fisco non poteva rinunciare ai 2,3 miliardi di tasse
Continua a leggereRiduci
Auro Bulbarelli (Ansa)
Insomma aveva pagato il pegno di aver divulgato una notizia vera e accertata, senza il permesso del Quirinale. Da qui il cartellino giallo nei suoi confronti e l’avvicendamento in corsa con il direttore Paolo Petrecca al microfono. Con tutto quel che ormai è cronaca acquisita e che persino il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha commentato negativamente. Ridategli il microfono, scrivevamo ieri. E così sarà: sarà proprio Auro Bulbarelli, cronista sportivo di lungo corso, a raccontare la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Non è una nostra vittoria, sia chiaro: non siamo così presuntuosi. Chiedevamo soltanto di rimettere le cose in ordine visto che Bulbarelli era stato designato come «voce» per la cerimonia di inaugurazione e poi sostituito per una colpa che non era una colpa: aver «spoilerato» il siparietto tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e Valentino Rossi. Insomma aveva pagato il pegno di aver divulgato una notizia vera e accertata, senza il permesso del Quirinale. Da qui il cartellino giallo nei suoi confronti e l’avvicendamento in corsa con il direttore Paolo Petrecca al microfono. Con tutto quel che ormai è cronaca acquisita e che persino il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha commentato negativamente.
Poiché nell’appello di ieri ci eravamo rivolti al Quirinale e soprattutto ai vertici Rai, sia all’amministratore delegato Giampaolo Rossi sia allo stesso Paolo Petrecca, chiedendo di riparare l’ingiustizia ai danni di un giornalista che aveva soltanto fatto il suo dovere, ora è giusto riconoscere loro il merito di questa scelta.
Lo ribadiamo: non crediamo di aver influito sulla scelta, se non in quella minuscola porzione che in tanti avranno portato alla causa, però la parola data va onorata: Rossi e Petrecca hanno compiuto la scelta più opportuna e più corretta e se l’hanno concordata con il Colle tanto meglio perché nemmeno lassù ci stavano facendo una bella figura: davvero si può penalizzare la Rai e i telespettatori perché viene anticipato lo sketch tra Mattarella e Valentino Rossi sul tram? Sembra difficile da accettare però questo era accaduto. E l’opposizione, cui non era sembrato vero poter azzannare il direttore di RaiSport compiendo il più facile degli attacchi, in questi giorni di polemiche non ha mai speso una parola a favore di Bulbarelli, neutralizzando così ogni suo commento e ogni suo giudizio velato di difesa dell’azienda e delle professionalità.
Dalla Schlein a Conte, nessuno ha difeso il diritto di Bulbarelli di raccontare - come da prima decisione interna all’azienda, sia chiaro - la cerimonia di inaugurazione; così come, da Conte alla Schlein, nessuno ha fatto cenni critici circa il ruolo del Quirinale rispetto alla esclusione. E questo vale anche per la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (Cinquestelle), la quale non perde occasione per ergersi a paladina della tv pubblica: perché non ha chiesto lumi sulla esclusione di Bulbarelli? Perché non ha voluto vedere la consequenzialità dei fatti, ovvero l’anticipazione giornalistica del ruolo di Mattarella, le polemiche per lo spoiler «non concordato» (come se fosse un obbligo deontologico; e non lo è) e infine la collocazione in panchina del giornalista colpevole, perché?
Dunque, sono stati l’ad Giampaolo Rossi e il direttore Paolo Petrecca a rimediare ad una ingiustizia e a favorire il ritorno di colui che il pubblico Rai ha conosciuto nel tempo come voce autorevole del ciclismo. Pertanto, proprio noi che non risparmiamo critiche al primo e al secondo non vogliamo mancare di parola: ridate il microfono al collega Auro e ve ne renderemo merito. Così è: grazie per la scelta, è una vittoria di tutti. È una vittoria per Bulbarelli, designato in prima battuta per l’inaugurazione e quindi assolutamente competente anche per raccontare la chiusura. È una vittoria per i vertici, perché spengono le polemiche lasciando le opposizioni e i critici col cerino in mano. È una vittoria per la Rai perché la professionalità delle risorse interne torna alla sua sacrosanta valorizzazione. Ed è - last but not least - una vittoria per i telespettatori, siano essi appassionati di sport o solo curiosi delle grandi kermesse, poiché gli eventi seguono una loro liturgia che necessita di bravi giornalisti. La Rai, cui va riconosciuto il merito di una copertura importante, non poteva uscire dalle Olimpiadi con la «patacca» della ormai famigerata telecronaca di inaugurazione: doveva riscattare se stessa e chi dal divano ha scelto la tv pubblica rispetto ad altri broadcast che pure trasmettevano in chiaro i Giochi invernali. Il successo di ascolto vale come riconoscimento assegnato dai telespettatori. Finalmente il cerchio si chiude con Auro Bulbarelli che torna al suo posto di telecronista: lo spirito olimpico ha convinto anche coloro che, per reazione, avevano scelto l’opzione peggiore. Ora pensiamo al medagliere affinché sia il più ricco possibile. Così la festa di chiusura sarà ancora più bella.
Continua a leggereRiduci