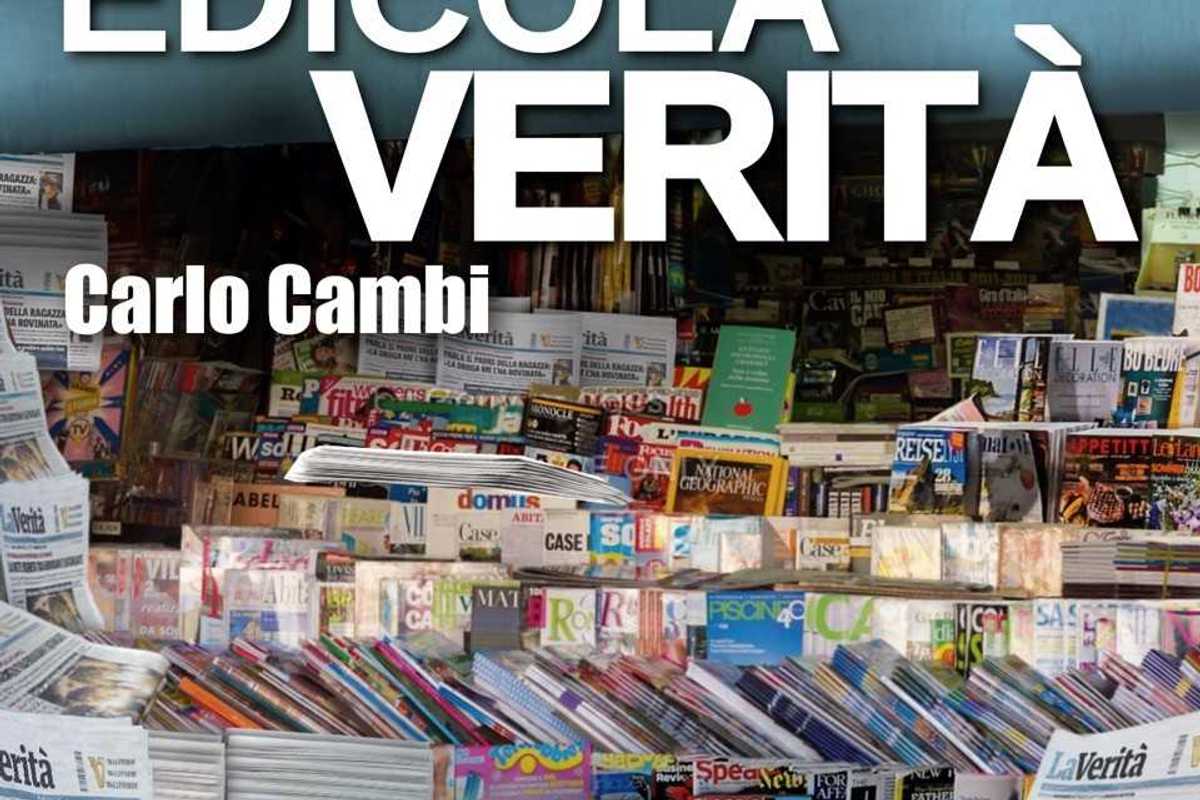Azione e adrenalina. «The Last of Us» torna su Sky con la seconda stagione

La prima stagione dello show è stata un lungo viaggio attraverso i pericoli del mondo esterno. La seconda, al debutto su Sky lunedì 14 aprile, sarà altro: un balzo in avanti di cinque anni, Joel ed Ellie ancora calati nel piccolo eden alle porte del mondo che il fratello di lui, Tommy, ha costruito insieme alla compagna Maria.
La prima stagione è finita con due parole, a suggello di una promessa. «Lo giuro». Poi, più nulla. The Last of Us s'è interrotta su quel che avrebbe dovuto essere il più bello: la possibilità che la vita del genere umano, la sua sopravvivenza e sviluppo, potesse riprendere a fluire.
La serie televisiva, la cui prima stagione è stata accolta all'unanimità come il miglior adattamento di un videogioco mai realizzato, l'ha lasciata lì, però, quella speranza, racchiusa in due sole parole. "Lo giuro", che al mondo, quel mondo disastrato, reso cenere da un virus che ha trasformato l'uomo in zombie, una cura avrebbe potuto esserci.
Pedro Pascal, Joel nello show, ha concluso la prima stagione con una scoperta potenzialmente rivoluzionaria. Altri, oltre ad Ellie (Bella Ramsey), sembrano essere immuni al Cordyceps, il fungo colpevole di aver trasformato i contagiati in esseri mostruosi. Non zombie, non morti, creature a mezza via tra mostri e vegetali, condannati per l'eternità a starsene silenti sotto terra, per nutrirsi al bisogno di altri esseri viventi. The Last of Us, adattamento televisivo del videogioco omonimo, ha raccontato il crollo della civiltà occidentale. Non esistono città, nello show. I grandi palazzi statunitensi, i grattacieli che hanno reso magnifica l'America sono stati mangiati dalla vegetazione, abbandonati da chi li abbia mai abitati. Il po' di umanità che è riuscita a sopravvivere alla pandemia si è riorganizzata in roccheforti, governate da una sorta di dittatura militare. Nessuno entra, nessuno esce. Le classi sociali sono immobili. Si obbedisce, pensando ad arrivare a fine giornata. Senza pretese, senza altra ambizione all'infuori dell'aver salva la vita. Joel, che nell'epidemia di Cordyceps ha perso moglie e figlia, ha sempre fatto quel che l'ordine governativo gli ha chiesto. Poi, però, qualcosa è cambiato. I ribelli lo hanno pregato di portare Ellie, una ragazzina immune al fungo, in un luogo sicuro, dove la sua resistenza possa diventare il punto di partenza di un vaccino.
La prima stagione dello show è stata questo, un lungo viaggio attraverso i pericoli del mondo esterno. La seconda, al debutto su Sky lunedì 14 aprile, sarà altro: un balzo in avanti di cinque anni, Joel ed Ellie ancora calati nel piccolo eden alle porte del mondo che il fratello di lui, Tommy, ha costruito insieme alla compagna Maria. L'armonia degli inizi, però, è scomparsa. Ellie e Joel a malapena si parlano. Troppi segreti, troppi non detti, a partire dal più complesso. Joel, sul finire della prima stagione, ha deciso di salvare Ellie da morte certa, negando parimenti all'umanità la possibilità di una cura. Le avrebbero asportato la gran parte del cervello, per studiarlo e provare a sintetizzare un vaccino. Ma Joel, che in quella ragazzina ha rivisto la figlia perduta, non lo ha permesso. L'ha portata via, e la seconda stagione dello show è stata travolta da un irreversibile effetto farfalla. I mostri sono incattiviti, gli uomini persi. The Last of Us 2 è azione e adrenalina, come il capitolo che l'ha preceduta. Forse, tuttavia, è meno incisiva, meno capace di ricalcare i ritmi e il dinamismo del gioco dal quale è tratta.