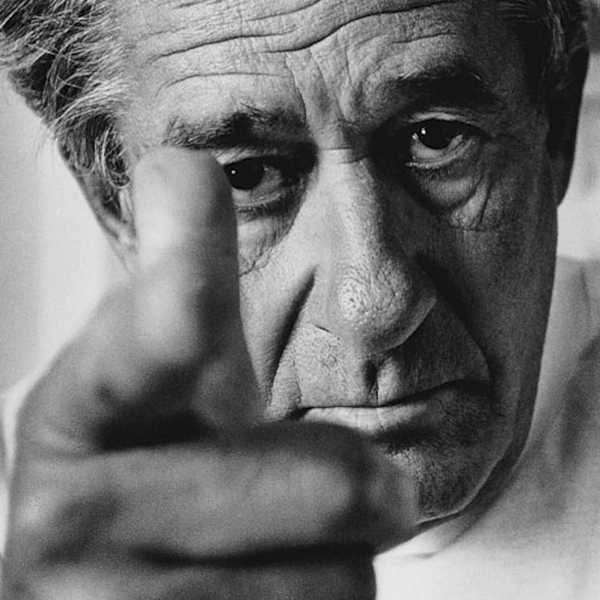La decisione della Pfizer di ridurre il personale
La Pfizer in Italia ha deciso di ridurre i dipendenti dello stabilimento di Catania. A inizio febbraio aveva annunciato il licenziamento di 200 persone, ma alla fine ha raggiunto un accordo con il sindacato per incentivare l’esodo di chi è prossimo alla pensione e il trasferimento di una parte dei cosiddetti esuberi ad Ascoli Piceno, dove la multinazionale ha un secondo sito produttivo.
Fin qui nulla da dire: succede che le aziende abbiamo bisogno di adeguare la forza lavoro sulla base di nuove esigenze e capita anche che i gruppi internazionali non vadano troppo per il sottile. Essendo abituati a un sistema di regole molto più elastico di quello che vige in Italia non apprezzano le liturgie sindacali, con lunghe trattative, tavoli al ministero del lavoro, cassa integrazione, mobilità e quant’altro nel nostro Paese si è inventato per ingessare il mercato del lavoro. Tuttavia, a stupirmi non è la decisione della Pfizer di ridurre il personale, quanto che, grazie al vaccino anti Covid, il 2021 sia stato per la casa farmaceutica americana il miglior anno di sempre. Nel 2019, prima della pandemia, la multinazionale guidata da Albert Bourla aveva fatturato 51,7 miliardi di dollari. Lo scorso anno, quando ha messo in commercio il farmaco contro la pandemia, i suoi ricavi sono cresciuti fino a 81 miliardi, 37 dei quali ricavati proprio grazie al vaccino. Parlando agli analisti e agli investitori, il manager greco che è a capo del gruppo ha lasciato intendere che il 2022 sarà migliore, con un fatturato previsto fra i 98 e i 102 miliardi: un record. Se poi si guarda al profitto netto, dai 9,1 del 2020 si è passati ai 22 dello scorso anno e anche questo è un risultato mai visto.
Certo, le riorganizzazioni all’interno di una fabbrica a volte sono necessarie anche se si fanno tanti utili, perché il compito dei vertici aziendali è guardare all’efficienza di un’azienda e avere una visione di lungo periodo. E però qualche perplessità viene quando si dà uno sguardo anche al ceo pay ratio, ovvero al rapporto fra la remunerazione dell’amministratore delegato con quella della media degli altri dipendenti. Nel 2019, Bourla ha percepito un compenso pari a poco meno di 18 milioni di dollari che, approssimativamente, è pari a 181 volte lo stipendio della media degli impiegati del gruppo, per i quali la remunerazione era di poco inferiore ai 100 mila dollari l’anno. Insomma, il manager greco, già prima della pandemia percepiva un compenso con i fiocchi, che lo collocava tra i meglio retribuiti fra i ceo. Che cos’è successo invece nel 2021, cioè dopo il Covid? La remunerazione è aumentata di circa 6 milioni e mezzo, raggiungendo quota 24 milioni e 353 mila dollari, con un incremento del 35,83 per cento.
Mica male, no? E quella dei dipendenti del gruppo? Beh, purtroppo lo stipendio dei lavoratori si è assottigliato, scendendo a una media inferiore ai 93 mila dollari, con una flessione del 6,04 per cento. E il ceo pay ratio? Quello è passato da 181 a 262, ovvero Bourla percepisce 262 volte ciò che incassa mediamente un suo dipendente. Certo, bisogna premiare chi fa buoni risultati e quelli del ceo Pfizer sono ottimi, forse però anche a scapito di chi lavora al suo fianco. Il motto del gruppo è: «Traduciamo la scienza in vita». Sì, una traduzione oltre che in vita anche in soldi. Soprattutto per il suo amministratore delegato.
La tigre è stanca. Arianna Fontana fallisce l’ultimo ruggito, le esce un miagolio e nella finale dei 1.500 Short Track non va oltre il quinto posto, davanti ad Arianna Sighel. A consolare i tifosi al Forum di Assago è la staffetta guidata da Pietro Sighel (fratellino), che incassa il bronzo dietro a Olanda e Corea del Sud dopo una battaglia all’ultimo respiro. Anche Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli sfilano sul podio con grande merito. E Pietro, il leader indiscusso della squadra, ottiene la seconda medaglia (dopo l’oro in staffetta mista) che lo risarcisce di Giochi pericolosi, con cadute, polemiche con i giudici e frasi sbagliate («Arianna Fontana chi la conosce?») che gli hanno procurato un’omerica shitstorm sui social.
Fontana chiude sulle ginocchia, una caduta in batteria ne limita le potenzialità. Finisce addosso alla polacca Kamila Sellier, è costretta a farsi massaggiare la schiena dolorante dal marito allenatore Anthony Lobello. Ma non ci sono unguenti, lei scricchiola e non può nulla per arginare la vitalità delle coreane Kim e Choi. Terza la statunitense Corinne Stoddard. Comunque la regina della Valtellina colleziona un oro, due argenti e il record storico delle 14 medaglie. Può bastare, anche lei è umana.
Dal resto della truppa arriva la medaglia d’oro del sorriso, chi si contenta gode. Niente di più per l’Italia ingrassata a suon di podi che si affaccia all’ovale ghiacciato di Rho Fiera per l’ennesimo trionfo di Francesca Lollobrigida. Ma anche lei è sazia e sembra dire con quello sguardo sornione: due ori in una settimana, cosa volete di più? Nei 1.500 del Pattinaggio velocità la testa della mammina laziale è sul pezzo ma le gambe paiono legnose; è solo 13ª nella sfida vinta dall’olandese Antoinette Rijpma-De Jong. La nuova Lollo ci aveva avvertiti: «Non aspettatevi medaglie, gareggio per preparare la mass start di sabato, a quella tengo molto». Così saremo di nuovo qui domani nello Speed skating stadium per una chiusura da apoteosi. Nel mirino c’è il terzo oro nella stessa Olimpiade, mai nessun italiano ci è riuscito. A due ci sono lei, Alberto Tomba, Manuela Di Centa, Federica Brignone. E con un problemino da niente: la prova con partenza in linea può riservare ogni sorpresa, visto che somiglia all’uscita da una scuola elementare al suono della campanella, cartellate comprese.
Prima dei fuochi d’artificio notturni nello Short Track, facciamo i conti con un venerdì di occasioni perdute soprattutto nel Biathlon, dove si consuma il dramma sportivo di Tommaso Giacomel, già argento nella staffetta mista, che per qualche minuto si ritrova in testa nella mass start 15 km. Il guerriero di Vipiteno sogna l’oro, sembra imbattibile ma è costretto a fermarsi per un improvviso dolore al costato e conclude i suoi Giochi in infermeria. Un minuto dopo lo stop sta già meglio, ma non era il caso di rischiare.
«La salute viene prima delle gare, quello che ha fatto è corretto», spiega l’allenatore di tiro Fabio Cianciana. Al poligono Tommaso era stato impeccabile (zero errori). Adesso ha le gomme a terra e su Instagram scrive: «Il corpo ha smesso di funzionare, facevo fatica respirare. È stato devastante. Molte cose mi passano per la testa, frustrazione, rabbia delusione». Sul podio finiscono i due norvegesi Johannes Dale-Skjevdal (oro) e Sturla Laegreid. Bronzo al francese Quentin Maillet.
In casa americana si contano gli interventi chirurgici per ripristinare il fisico da Robocop di Lindsey Vonn: oggi è andata sotto i ferri per la sesta volta e sorride da Instagram. Da simbolo di positività, lei si sente fortunata. Non come il cinese Haipeng Sheng, che si è dimenticato il cellulare in una tasca dei calzoni e l’ha perso durante un salto Freestyle. È arrivato 20º ma lo smartphone funziona, gli amici possono spernacchiarlo.
Il resto è hockey. Il primo finalista è il Canada, che arriva alla sfida per l’oro dopo un 3-2 in rimonta sulla Finlandia. Senza Sidney Crosby, uno dei migliori giocatori della storia, e al termine di una sfida rocambolesca: in vantaggio 2-0 gli scandinavi si fanno riprendere e superare a 35’’ dalla sirena finale con un gol contestatissimo per un fuorigioco millimetrico. Gli arbitri convalidano, i canadesi esultano e aspettano gli Stati Uniti (nella notte la semifinale con la Slovacchia) per il Miracle Nhl di domani, prima della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, alla quale parteciperà in tribuna d’onore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dovesse arrivare a sorpresa Trump, lei si è portata avanti.
Domani gli azzurri sparano le penultime cartucce a calendario pieno. Nella maratona del Fondo - 50 km con le barbe gelate e il cuore in gola - va in onda il canto del cigno del formidabile Federico Pellegrino. Nel Biathlon sono possibili dolci sorprese dalla coppia Dorothea Wierer (fin qui perdente) e Lara Vittozzi (fin qui vincente). Poi la già citata chiusura del Pattinaggio velocità con le tonnare mass start uomini e donne, dove Andrea Giovannini può farsi onore e lady Lollobrigida può compiere l’impresa dei tre ori. E da sconosciuta agli sportivi da divano, entrare nella leggenda. Non l’abbiamo vista arrivare.
È l’originale cornice del Filatoio di Caraglio (CN), a ospitare (sino a 1° marzo 2026) una grande retrospettiva dedicata a Helmut Newton (1920-2004), fra i fotografi di moda più famosi e influenti del XX secolo. Intitolata Intrecci, l’esposizione raccoglie oltre 100 dei suoi celebri scatti, connubio perfetto fra eleganza, seduzione… e un tocco d’ironia.
Tedesco di origine ebree naturalizzato australiano, di Helmut Newton (1920-2004) si è visto, detto e scritto di tutto. Fotografo «imperfetto», di se amava dire che «bisogna essere all’altezza della propria cattiva reputazione» e lui, nel bene e nel male, all’altezza della propria fama lo è sempre stato. Irriverente e trasgressivo, Newton voleva, amava e creava immagini forti, di quelle che lasciano il segno. E forti, altere, provocanti, ambigue, enigmatiche erano le sue donne, le modelle che immortalava nei suoi scatti senza tempo e fuori dal tempo. In bianco e nero soprattutto (pur senza disdegnare il colore, nonostante fosse daltonico...), con quei sapienti giochi di luce e ombre che sono il suo tratto distintivo. Donne di una bellezza inarrivabile, eleganti ed erotiche, che Newton, strizzando l’occhio al voyerismo e al sadomaso, ritraeva strette in corsetti di pelle, tacchi vertiginosi, lingerie provocanti, pose al limite della decenza: per alcuni, nessuno come lui ha saputo esaltare l’universo femminile; per altri, nessuno più di lui ne ha degradato la dignità. Il dibattito è tutt’ora aperto, e prendere una posizione non è poi così semplice. Ma una cosa è certa: nessuno può metterne in discussione la genialità.
Newton, ogni volta, riesce a stupire. E anche il «già visto» diventa novità. Come in questa mostra allestita a Caraglio (CN), negli originali spazi di un setificio seicentesco nato per intrecciare fili di seta e produrre tessuti preziosi, un’esposizione che raccoglie oltre 100 scatti del grande Maestro e che già nel titolo, Intrecci, rivela un rapporto profondo fra le immagini esposte e il luogo che le ospita, una sorta di connessione tra le « trame materiali » della tradizione tessile e quelle concettuali, elementi imprescindibili di tutti i lavori di Helmut Newton. Ricercatissimo da stilisti e riviste (Vogue F, Elle Francia e Queen Magazine solo per citarne alcune…), amato da top model ed attrici (per lui hanno posato, fra le altre, Monica Bellucci e Kate Moss, Carla Bruni ed Eva Herzigova), Newton ha saputo rivoluzionare e ridefinire i canoni della fotografia patinata, che con lui - inarrivabile nel creare immagini accuratamente inscenate - diventa linguaggio teatrale ed evocativo, suscitando spesso scandalo: come nel 1981, quando dopo un servizio fotografico di moda per Vogue Italia e Francia chiese alle modelle di spogliarsi per ritrarle nella stessa posa, ma nude…
La Mostra
Appositamente concepito per il Filatoio di Caraglio e curato da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino ( «L’ex setificio, un bellissimo edificio storico da tempo utilizzato per scopi culturali, è il luogo perfetto per una mostra di Helmut Newton incentrata sulla sua fotografia di moda più tarda… Oltre ad alcune delle fotografie iconiche di Helmut Newton, i visitatori avranno modo di scoprire anche numerosi scatti meno conosciuti e, così, di riscoprire la sua opera più celebre» ha dichiarato il curatore in occasione dell’inaugurazione), il ricco percorso espositivo si snoda attraverso otto sale, regalando al visitatore, già da subito, gli scatti più iconici di Newton, quelli che lo hanno reso uno dei fotografi di moda più famosi e influenti del XX secolo: particolarmente significativo, fra i vari ritratti di celebrità, il suo primo nudo, quello di Charlotte Rampling all’Hôtel Nord-Pinus di Arles nel 1973.
Di foto in foto, si passa alle immagini realizzate per le grandi committenze della moda (dal sodalizio decennale con Yves Saint Laurent alle celebri campagne pubblicitarie pensate per Versace e Anna Molinari) e della pubblicità: straordinarie, in mostra, la selezione di sette fotografie realizzate da Newton per la Lavazza, dove - nell’immagine centrale - una modella seminuda e con gli occhi bendati posa sotto il logo del marchio, dipinto con vernice spray su una parete grigia e spoglia.
Genio assoluto nell’uso della «mood photography», la tecnica che evoca il prodotto pubblicizzato senza mai rivelarlo in maniera esplicita, nei mitici anni ’90 firmò indimenticabili campagne pubblicitarie per lanciare i profumi di Laura Biagiotti e Yves Saint Laurent e le borse del marchio italiano Redwall.
Moda, bellezza, seduzione, ambiguità, arte, trasgressione, ironia, potere, genialità: in questa mostra c’è davvero tutto Newton e tutti i suoi Intrecci biografici, professionali e narrativi.
Dopo quarant’anni un altro Papa prenderà parte al Meeting per l’amicizia tra i popoli, l’incontro che dal 1980 alcuni amici di Rimini vollero cominciare ad organizzare per una fede che si faceva cultura. Come insegnerà proprio Giovanni Paolo II nell’agosto del 1982 - quando fu appunto il primo Papa a partecipare al Meeting di Rimini - , l’esperienza nata e sviluppata nell’alveo del movimento di Comunione e Liberazione che da allora rappresenta forse l’appuntamento estivo più importante non solo per chi vive la fede e appartiene al movimento, ma anche per il mondo culturale e politico non solo italiano.
Una partecipazione, quella di Leone XVI, inattesa e che segue l’udienza del 26 gennaio concessa dal pontefice al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. Una partecipazione che assomiglia a una risposta senza troppe parole a certi gossip e chiacchiere da social che aleggiano su Comunione e Liberazione dopo i travagli vissuti in seguito alle dimissioni da presidente della Fraternità di don Julian Carron.
Papa Leone XIV sarà al Meeting sabato 22 agosto nel pomeriggio e poi presiederà una messa con i fedeli della diocesi di Rimini. La partecipazione all’evento del pontefice è stata diffusa ieri, insieme a un programma di visite che papa Prevost terrà in Italia nei prossimi mesi. Oltre a partecipare alla quarantasettesima edizioni del Meeting, il Papa sarà a Pompei e Napoli l’8 maggio, quindi il 23 maggio visiterà le Terre dei Fuochi, il 20 giugno andrà a Pavia sulla tomba del santo a lui più caro, Sant’Agostino, quindi il 4 luglio sarà a Lampedusa, sulle orme del predecessore Francesco (che sull’isola fece il suo primo viaggio). Il 6 agosto papa Leone XIV andrà, invece, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, per incontrare i giovani riuniti per l’ottocentesimo anniversario del Transito di San Francesco.
Un vero e proprio «tour» italiano quello programmato da papa Leone XIV che sempre ieri ha incontrato i preti della diocesi di Roma ricordando loro che «dobbiamo riconoscere che parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, e ciò invita a vigilare anche su una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione». Di fronte a una «crescente erosione della pratica religiosa», ha detto il Papa ai preti romani, non è più possibile applicare una «pastorale ordinaria […] che si preoccupa anzitutto di garantire l’amministrazione dei sacramenti», ma è «urgente ritornare ad annunciare il Vangelo: questa è la priorità». Se tra fede e sacramenti c’è una reciprocità essenziale è chiaro che la conclamata crisi di fede svuota dall’interno questo rapporto e riduce il sacramento, quando va bene, a consuetudine sociale.
Il viaggio in Italia del Papa andrà a toccare diversi punti nodali della vita pubblica e religiosa del Belpaese, e il Papa, ricordiamolo, è anche primate d’Italia. Da Pompei, a Lampedusa, da San Francesco a Sant’Agostino, fino appunto al Meeting di Rimini c’è un filo rosso che probabilmente segna questo tour, il desiderio del pontefice di ridare priorità all’annuncio del Vangelo davanti a una realtà sociale e culturale che appare stanca e ormai priva del nerbo di quei principi che hanno «fatto l’Italia». E gli italiani.
Proprio Giovanni Paolo II al Meeting di Rimini nel 1982 citava Sant’Agostino nell’apertura delle sue celebri Confessioni, laddove il santo ricorda che «il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te». «Siamo fatti per il Signore», chiosava Giovanni Paolo II, «che ha stampato in noi l’orma immortale della sua potenza e del suo amore. Le grandi risorse dell’uomo nascono di qui, sono qui, e solo in Dio trovano la loro salvaguardia». Così papa Wojtyla davanti al popolo del Meeting con parole che probabilmente sono molto vicine al sentire di papa Prevost. Il presidente della Fraternità di CL, Davide Prosperi, ha dichiarato: «Siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accolto il nostro invito: la sua partecipazione rappresenta per noi un segno di affetto molto desiderato».