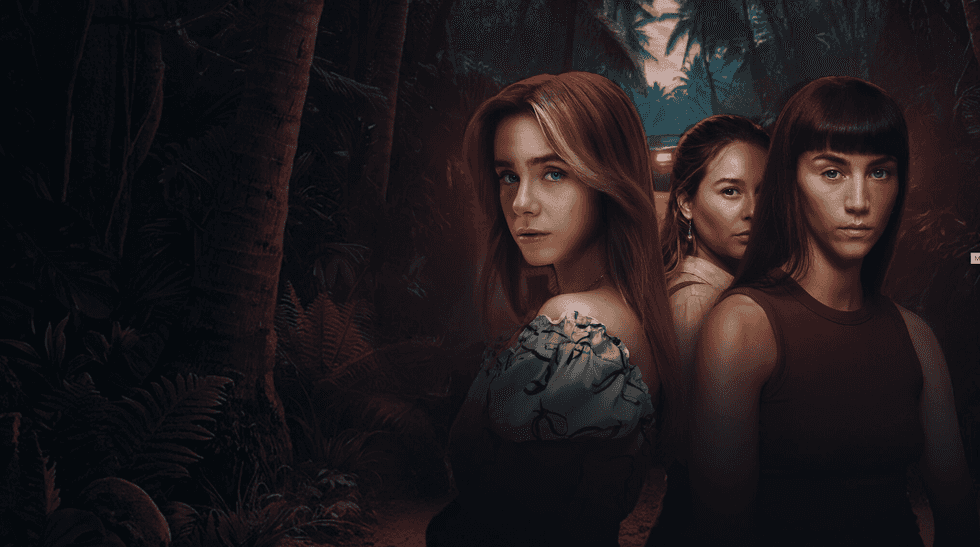Alina Kabaeva è nel mirino anche delle autorità italiane
In Italia non risulterebbero al momento proprietà a lei riconducibili. Mentre risulterebbero frequenti passaggi nel nostro paese, molto amato dai ricchi russi. D’altra parte il patrimonio personale di Alina Kabaeva sarebbe poca cosa, rispetto a uno qualunque dei grandi oligarchi russi.
Eppure, quando si è trattato di inserire anche lei nell’elenco delle personalità russe sanzionate, il governo Usa ci ha pensato a lungo. E poi ha deciso di non farlo. La ragione di tanta cautela, secondo il Wall Street Journal che ha ricostruito la vicenda, è che colpire lei sarebbe una provocazione per Vladimir Putin. Ex ginnasta, un oro olimpico e nove titoli mondiali prima di essere fermata per doping, la Kabaeva è infatti la «fidanzata» del leader russo. L’amante, dice qualcuno perché la relazione tra i due non mai stata ufficializzata sebbene duri da anni. La madre dei figli più piccoli dell’inquilino del Cremlino. La sua figura, la sua ricchezza e ovviamente i suoi rapporti con Putin sono circondati dalla massima segretezza. Il giornale russo che per primo ha scritto della relazione tra Putin e la Kabaeva si chiamava Moskovskij Korrespondant.
Dopo lo scoop ha chiuso. Qualche dettaglio sulla sua fortuna è noto grazie a una serie di inchieste giornalistiche internazionali: si sa ad esempio che l’incarico di presidente del board di National Media Group, colosso russo dei media, megafono della propaganda del Cremlino, di proprietà di Yuriy Kovalchuk - uno degli alleti più stretti di Putin -le frutta uno stipendio di 10,5 milioni di dollari all’anno. Si sa anche che la nonna allora ottantunenne, Anna Zatsepilina, nel 2013 ricevette in regalo una serie di terreni edificabili in uno dei sobborghi più lussuosi della capitale russa, Uspenskoe, dove 100 metri quadri di terreno possono valere fino a 100 mila dollari. A fare i preziosi doni era stato, in entrambi i casi, Grigory Baevskiy, ex dirigente dell’Agenzia per la gestione degli asset statali, poi passato a lavorare per Arkady Rotemberg, uno dei più vecchi amici di Putin, suo sparring partner di judo, diventato a sua volta multimiliardario grazie a una serie di appalti pubblici.
Infine, Baevskiy si è messo in proprio, ottenendo a sua volta una serie di lucrosi contratti statali. Nel frattempo, ha passato proprietà immobiliari anche a Katerina Tikhonova, una della figlie di primo letto di Putin. E a Alisa Kharcheva, che poco più che ventenne divenne famosa per un post sul suo blog intitolato «Pussy for Putin», corredato da una foto di lei con un gattino: «Un regalo per il presidente». Da un altro oligarca, Gennady Timchenko, avrebbe invece ricevuto un appartamento a San Pietroburgo. Le proprietà della Kabaeva non sono solo in Russia. Trascorre molto tempo in una villa nei pressi di Lugano, da dove si reca spesso anche in Italia. La villa avrebbe un valore di 15 milioni di euro. Una inchiesta di una testata svizzera ha rivelato che ha due figli, uno dei quali è nato in una lussuosa clinica svizzera e l’altro a Mosca. Quello della Kabaeva è uno dei nomi attenzionati dalle autorità italiane che stanno tracciando gli asset degli oligarchi per possibili sanzioni. Anche se il suo nome ancora in quella lista non c’è.
Milano-Cortina 2026, l'Italia supera il record di Lillehammer anche alle Paralimpiadi
Milano-Cortina 2026 ha scritto oggi un nuovo capitolo nella storia dello sport paralimpico italiano. Con quattro medaglie conquistate nella giornata odierna, infatti, la spedizione azzurra ha raggiunto quota 14 podi, superando il record di Lillehammer 1994, che resisteva da oltre trent’anni.
Il giorno è iniziato sulle piste di Socrepes con Jacopo Luchini, protagonista nello snowboard banked slalom SB-UL. L’azzurro ha chiuso la prova con il tempo di 56”28, davanti ai due atleti cinesi Wang Pengyao (56”62) e Jiang Zihao (57”03), conquistando così il suo primo oro di giornata e il quarto complessivo per l’Italia a questi Giochi. «Ci si prova sempre a pensare ad una giornata così… quattro anni fa avevo perso la medaglia per otto centesimi, oggi il tempo mi ha ripagato con gli interessi», ha commentato Luchini. Non è mancato il bis dello snowboard con Emanuel Perathoner, che ha dominato il banked slalom SB-LL2. L’azzurro, già vincitore sabato nello snowboard cross, si è confermato il primo snowboarder italiano a realizzare la doppietta d’oro nella stessa Paralimpiade. «La pista era meglio oggi che in training, era più ghiacciata e la preferisco così», ha spiegato Perathoner, che con il tempo di 54”28 ha preceduto lo svizzero Fabrice Von Gruenigen e l’australiano Ben Tudhope. Sul fronte dello sci alpino, Giacomo Bertagnolli ha centrato l’argento nello slalom gigante ipovedenti insieme alla guida Andrea Ravelli. L’azzurro, al comando dopo la prima manche, ha chiuso a soli 34 centesimi dall’austriaco Johannes Aigner. «Siamo quattro su quattro, ma a parte il bronzo iniziale che è stata la sorpresa abbiamo replicato pari pari Pechino», ha dichiarato Bertagnolli. Con questa medaglia, Bertagnolli eguaglia le 12 conquistate in carriera da Bruno Oberhammer, diventando uno degli atleti italiani più medagliati della storia paralimpica. La giornata si è chiusa con il trionfo di René De Silvestro nello slalom gigante categoria sitting. L’azzurro ha preceduto l’olandese Niels De Langen e il norvegese Jesper Pedersen, aggiungendo una medaglia d’oro inedita alla sua collezione e portando l’Italia a quota 14 podi, record assoluto per le Paralimpiadi invernali italiane. «Volevo così tanto questa medaglia che non potevo cadere. I salti? Quando faccio qualcosa di buono finisco sempre a stupire un po’ tutti», ha commentato De Silvestro indicando la figlia con orgoglio.
Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha definito la giornata «meravigliosa» e ha sottolineato come lo snowboard, disciplina in cui l’Italia non aveva mai ottenuto grandi risultati, sia oggi tra i protagonisti di questa spedizione. Anche i grandi campioni dello sci italiano, come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, hanno assistito alle gare, applaudendo i successi degli azzurri e la loro capacità di ispirare nuovi atleti.
Oltre alle vittorie, la giornata ha registrato anche i piazzamenti degli altri azzurri: Federico Pelizzari ha chiuso quarto nel gigante standing, Luca Palla undicesimo, mentre Davide Bendotti non ha completato la prova a causa di una caduta. Nel biathlon, Marco Pisani e Cristian Toninelli hanno chiuso rispettivamente diciottesimo e tredicesimo nelle sprint di inseguimento, con l’obiettivo di migliorare domani nella staffetta.
Con la settima giornata, Milano-Cortina conferma il trend eccezionale della spedizione italiana: sei ori, cinque argenti e tre bronzi, un bottino che segna il record assoluto di medaglie in una Paralimpiade invernale per l’Italia. Il sogno olimpico continua, con nuovi appuntamenti sulle piste e nuovi traguardi da inseguire.
La crisi economica e industriale della Germania inizia a mostrare i suoi effetti anche sui titoli di Stato, creando una situazione potenzialmente esplosiva, che rischia di travolgere la ormai ex locomotiva d’Europa.
Secondo alcuni osservatori l’asta di ieri dei titoli di Stato decennali è tecnicamente fallita. Un’esagerazione, forse, ma sta di fatto che dei 5 miliardi di euro offerti, sono state presentate offerte per soli 4,5 miliardi e collocati solo 3,8 miliardi di euro, con un rendimento del 2,89%, notevolmente superiore al 2,73% registrato nell’asta precedente di febbraio. Si tratta di un tasso che non si vedeva dal gennaio 2023. Al momento la situazione sembra sotto controllo, anche in virtù del meccanismo che tutela il sistema delle aste di titoli pubblici in Germania attraverso un intervento del governo a copertura delle falle. Nello specifico, i 1,2 miliardi trattenuti dall’autorità che emette il debito verranno poi collocati sul mercato secondario, attraverso la cosiddetta clausola salva-Bund, che in Italia non esiste. Resta, però, il fatto che il Paese che per anni ha puntato il dito contro gli altri Stati Ue che si trovano in difficoltà oggi si trova ad affrontare una sorta di contrappasso dantesco. Che se da un lato può far sorridere se la mente torna all’ex cancelliera Angela Merkel che, insieme al presidente francese Nicolas Sarkozy, rideva dell’Italia, dall’altro rischia di avere ricadute pesantissime sulla forza economica di un’Europa che sempre di più appare come un vaso di coccio tra i vasi di ferro.
Va detto però che, complici i timori degli investitori per l’imprevedibilità dei costi della guerra in Iran, anche l’America sembra non essere più quella di un tempo, tanto che il rendimento dei titoli del Tesoro trentennali è arrivato a toccare quasi il 4,90%, il livello più alto in un mese, poiché i mercati, già preoccupati per l’inflazione causata dal petrolio, temono che i governi dovranno indebitarsi di più per pagare la spesa per la Difesa e per proteggere le famiglie dai maggiori costi energetici.
In generale, le obbligazioni globali stanno perdendo i guadagni ottenuti da inizio anno. Oltre che in Germania, i rendimenti obbligazionari sono aumentati vertiginosamente anche in Paesi come Regno Unito, Australia e Giappone. Il timore degli addetti ai lavori è che gli investitori, in virtù dell’aumento dei costi della guerra e del rischio di un aumento dei deficit, possano richiedere maggiori compensi per le obbligazioni a più lunga scadenza. Se a ciò si aggiungono le pressioni inflazionistiche derivanti dall’impennata dei prezzi dell’energia, si tratta di un cocktail volatile per gli investitori obbligazionari.
La Casa Bianca non ha fornito una stima dei costi della campagna, ma al Congresso sono già in corso discussioni per un finanziamento aggiuntivo di circa 50 miliardi di dollari. Un’asta di 22 miliardi di dollari in titoli del Tesoro trentennali sarà il primo banco di prova per l’attuale interesse degli investitori per questi titoli. I rendimenti su tutte le scadenze sono aumentati vertiginosamente dall’inizio del conflitto, con gli investitori che stanno anche valutando l’impatto inflazionistico a breve termine dell’impennata dei prezzi del petrolio.
Il deficit di bilancio degli Stati Uniti si è ridotto negli ultimi mesi, sebbene si sia attestato comunque intorno ai mille miliardi di dollari nei cinque mesi fino a febbraio. Ma gli investitori stanno già tenendo conto dell’impatto di una sentenza della Corte suprema che ha annullato i dazi commerciali statunitensi, che avevano fruttato al governo decine di miliardi di dollari di entrate. Soldi che adesso rischiano di dover tornare indietro, visto che molti importatori si preparano a fare cause milionarie.
Ci sono bilanci che si limitano a raccontare come è andato l’anno. E poi ci sono quelli che, oltre ai conti, mandano messaggi. Il 2025 di Assicurazioni Generali appartiene alla seconda categoria. Perché mentre il Leone di Trieste sfodera numeri da record, l’amministratore delegato Philippe Donnet prende le misure come appartenenti al gruppo Mps.
Partiamo dai numeri, che sono quelli che alla fine contano davvero. Generali chiude il primo anno del nuovo piano con risultati che non si erano mai visti. L’utile netto sale a 4,17 miliardi, in crescita del 12%. Il risultato operativo supera per la prima volta la soglia degli 8 miliardi, fermandosi poco sopra quota 8,1 con un incremento vicino al 10%. Insomma, il Leone continua a ruggire. Donnet, che guida una nave grande in mari agitati, spiega che Generali è abituata a «navigare bene nella tempesta». E tempeste, nel mondo finanziario e geopolitico, non mancano certo. Il messaggio agli azionisti è semplice: continuiamo a guadagnare bene e continueremo a darvi soddisfazioni. La maniera migliore per ricucire i rapporti con i grandi azionisti come Caltagirone e gli eredi Del Vecchio.
La cedola sale a 1,64 euro per azione, con un incremento del 14,7%, superiore alle attese degli analisti. Quasi 2,4 miliardi distribuiti agli azionisti. Donnet lancia anche un nuovo programma di buyback da 500 milioni di euro. In altre parole, soldi che tornano direttamente nelle tasche dei soci. Quando si distribuisce così tanta liquidità significa che il motore gira forte. Le masse gestite dal gruppo arrivano a sfiorare i 900 miliardi di euro, in crescita del 4,3%. Il risparmio gestito porta a casa oltre 1,19 miliardi di utile operativo. Ma il cuore pulsante resta l’attività assicurativa. I premi lordi complessivi salgono a 98,1 miliardi. La solidità patrimoniale resta robusta. In termini semplici: il capitale per coprire i rischi è più che abbondante. Accanto a Donnet, il nuovo direttore generale e vice ceo Giulio Terzariol prova a sintetizzare il momento dei mercati partendo da vicino: «Le assicurazioni non coprono i rischi di guerra». Ma la parte più interessante arriva quando si passa alla geografia della finanza. È cambiato l’azionista di riferimento di Mediobanca, la storica custode della quota strategica di Generali. Un passaggio che ha riacceso i riflettori sugli equilibri del capitalismo tricolore, con i soci Francesco Gaetano Caltagirone e la holding Delfin della famiglia Del Vecchio molto attivi nel riassetto del sistema. Donnet, con diplomazia d’ordinanza, dice di avere «rapporti positivi e istituzionali con tutti gli azionisti». Il riferimento è alla mancata alleanza con la francese Natixis nella gestione del risparmio, stoppata anche in nome della difesa della sovranità nazionale. Il ceo del Leone tira fuori la mossa più elegante della giornata. Se davvero il risparmio italiano deve restare in Italia, dice in sostanza Donnet, allora Generali è prontissima a dare una mano. L’accordo di bancassurance tra Banca Monte dei Paschi e la francese Axa scade il prossimo anno. «Il nostro mestiere è anche la gestione del risparmio», osserva Donnet. «Forse saremo un candidato per sostituire Axa». Pertanto: «Se possiamo rimpatriare questo risparmio italiano in Italia, saremo felici di farlo». Non solo patriottismo (Donnet ha preso la cittadinanza italiana) e tentativo di allacciare nuovi rapporti con la capogruppo: gli sportelli del Monte rappresentano una rete commerciale importante per vendere polizze, previdenza e prodotti di investimento. In altre parole, un affare che vale miliardi. E non è l’unica partita aperta. Generali guarda con interesse anche all’espansione dell’accordo di bancassurance con Unicredit, oggi limitato al Centro ed Est Europa. L’idea è ampliarlo e rafforzarlo sostituendo Amundi, altro gruppo francese. Intanto, mentre a Trieste si parlava di utili record, il titolo Generali a Piazza Affari chiudeva la seduta in controtendenza, salendo dell’1,48% a 33,6 euro. Segno che il mercato apprezza la traiettoria del Leone. Il prossimo appuntamento sarà l’assemblea del 23 aprile. Una riunione un po’ particolare: per la prima volta dopo il periodo Covid gli azionisti non saranno presenti fisicamente e voteranno solo tramite il rappresentante designato. Ma non è detto che mancherà lo spettacolo. Perché quando si parla di Generali, di Mediobanca e di finanza italiana, qualcosa succede sempre.