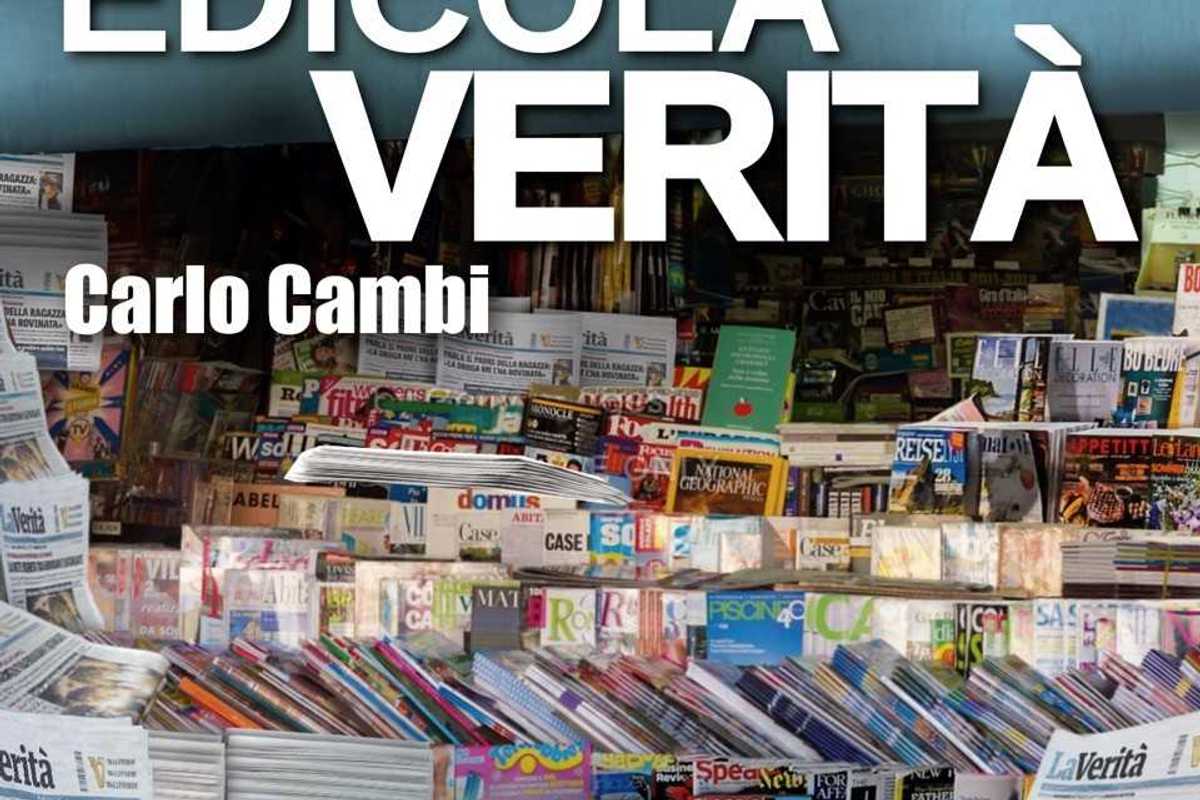Il caso del colosso immobiliare cinese Evergrande è deflagrato proprio il 15 settembre, anniversario del crac di Lehman Brothers avvenuto il 15 settembre del 2008. Tredici anni dopo, il mercato si trova a porsi la domanda: Evergrande è too big to fail o sarà la nuova Lehman cinese? Di certo, con un carico di debiti per 305 miliardi di dollari (pari al Pil della Finlandia), la società non è in grado di pagare gli interessi sui prestiti ed è esposta con 128 banche e 121 istituzioni non bancarie. Lunedì il titolo ha perso oltre il 14% a Hong Kong trascinando in rosso tutti i principali listini asiatici, ma anche europei. Domani scadranno cedole per 83,5 milioni.
La società «uscirà dal suo periodo più buio il più rapidamente possibile» e «si assumerà le responsabilità nei confronti degli acquirenti di proprietà immobiliari, investitori, partner e istituzioni finanziarie», ha scritto il suo presidente Hui Ka Yan in una lettera ai dipendenti. Ma già si teme per il contagio su altri big cinesi del settore e per la tenuta del sistema dopo che Sinic holdings, basata a Shanghai, è stata declassato a CCC+ da S&P e inserita in credit watch negativo a causa di «elevati rischi di pagamento» per la mancanza di un piano concreto per i bond in scadenza a ottobre per 246 milioni di dollari. Questo nonostante la società disponga di sufficiente liquidità. Secondo la stessa agenzia di rating, però, il governo di Pechino non fornirà un supporto diretto, «vuole che gli eventi facciano il loro corso anche nel mercato immobiliare della provincia, lo sviluppatore è insignificante rispetto alla vasta economia locale di Guangdong». Secondo S&P, dunque, Evergrande non è too big to fail. Non solo. Ieri il capo economista dell’Ocse, Laurence Boone, ha detto che la Cina ha la capacità di bilancio e monetaria per «ammortizzare lo shock».
Chiaramente ci saranno conseguenze dall’onda d’urto del raffreddamento dell’immobiliare cinese: il settore è uno di quelli più presi di mira dalla nuova politica quinquennale di restrizioni messa in atto negli ultimi mesi dal governo centrale limitando l’accesso ai finanziamenti per gli sviluppatori e riducendo la possibilità di contrarre prestiti ipotecari agli acquirenti di case nel tentativo di sgonfiare la bolla del mattone e i conseguenti rischi finanziari. La crescita degli investimenti immobiliari è stata così rallentata e le vendite di abitazioni si sono indebolite ad agosto. L’industria rappresenta oltre il 28% della produzione interna lorda della Cina e secondo Morgan Stanley, le società immobiliari sono risultate inadempienti per 6,2 miliardi di dollari da gennaio a metà agosto, 1,3 miliardi di dollari in più rispetto ai 12 anni precedenti messi insieme. Del resto, era tutto già scritto nel 2017, quando Xi Jinping aveva ribadito che «le case servono per viverci, non per fare speculazione». E se si sgonfia, in maniera «controllata», la bolla del mattone cinese, ciò potrebbe addirittura avere un risvolto positivo (il silver lining) nella misura in cui raffredderà i prezzi delle materie prime. Secondo un report di T-Commodity, è probabile che il principale impatto della crisi di Evergrande si registri più che sul sistema bancario cinese - assai più perimetrato rispetto a quello americano - sulle materie prime per uso industriale. In particolare sul rame che è apparso in rialzo nelle ultime settimane e ora è probabile che si muova al ribasso. Il premier cinese Li Keqiang ha detto che utilizzerà «strumenti di mercato» per stabilizzare i prezzi delle commodities.
Sempre secondo T-Commodity, il caso Evergrande non evoca Lehman ma il crollo di Long-Term capital management (Ltcm) avvenuto nel 1998 che comunque è stato gestito molto rapidamente dalla Federal reserve e dalle principali banche e non ha avuto implicazioni globali. Lehman è stata autorizzata a fallire dal Tesoro Usa e dalla Fed mentre T-Commodity si aspetta che il governo cinese ristrutturi Evergrande, probabilmente distribuendo gli asset tra i competitor. Ltcm è stato ristrutturato dalla Fed con l’aiuto delle principali banche statunitensi. Inoltre, i funzionari del governo cinese sono ben consapevoli proprio di quello che sarebbe l’effetto Lehman e quindi faranno di tutto per evitarlo.
Non solo. Cavalcare il «momento Lehman» torna utile a quelli che in Borsa vengono definiti shortisti. E sta già diventando un comodo capro espiatorio se le Borse vanno giù. O se gli spread salgono. Guarda caso proprio alla vigilia del primo meeting della Fed post-Jackson Hole sul tapering. Se la Fed aveva bisogno di un alibi nuovo per ritardare ancora le mosse, la Cina ne sta fornendo uno decisamente spendibile.