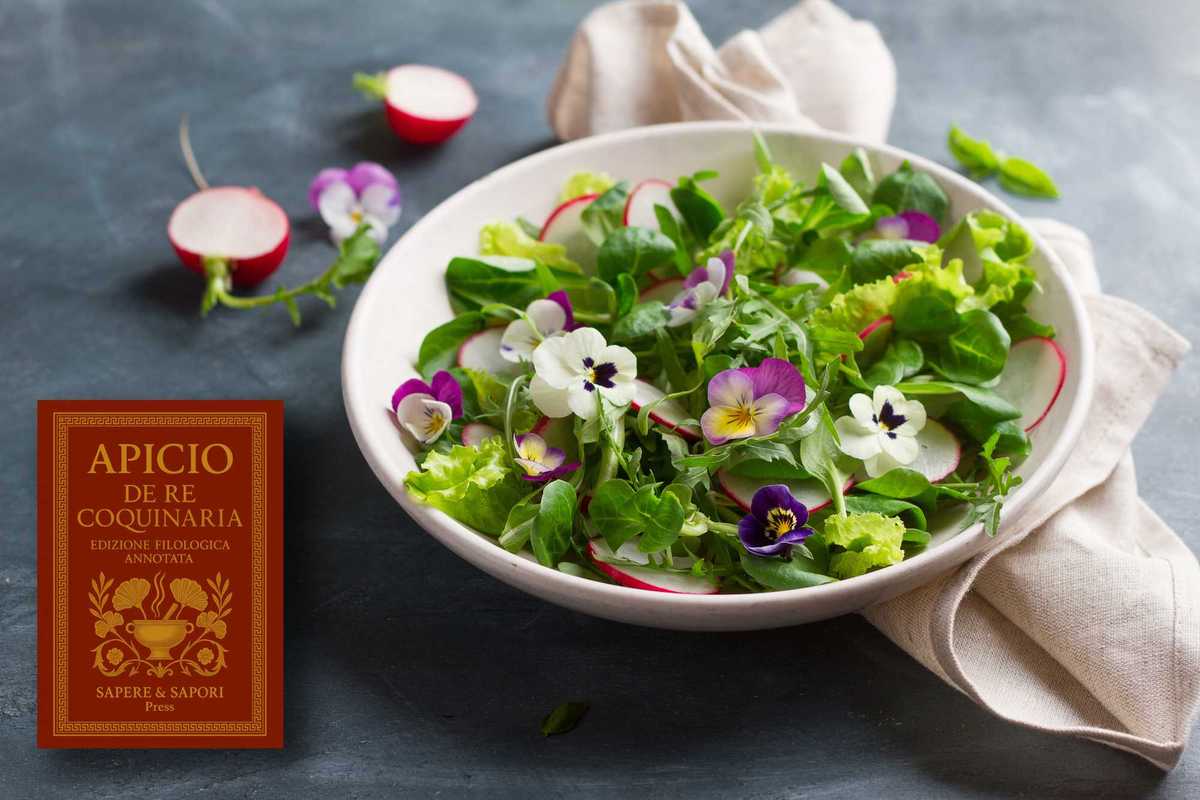Anche il Neanderthal era un po’ Sapiens: i pregiudizi sul nostro «cugino» vanno rivisti

Nuove ricerche riscrivono la storia primitiva del genere Homo. E gettano una luce diversa anche su di noi, sul nostro passato e persino sul nostro avvenire.
Anche i Neanderthal, in fondo, erano un po’ Sapiens. L’immagine stereotipata che abbiamo del nostro “cugino” – i cui primi resti furono scoperti nel 1856 dagli operai di una cava di calcare nella valle di Neander, in Germania, e inizialmente scambiati per i resti di un orso – ci porta invariabilmente alla mente l’idea di un uomo scimmiesco e primitivo per definizione, ma è una concezione che va sicuramente rivista, almeno alla luce di una serie di studi recenti. Una ricerca di João Zilhão, dell'Università di Lisbona, insieme all'archeologo Diego Angelucci dell'Università di Trento e a Mariana Nabais dell'Istituto catalano per la Paleoecologia umana e l'Evoluzione sociale di Tarragona, pubblicato sulla rivista Plos One, ha infatti dimostrato che i Neanderthal non solo sapevano accendere il fuoco, ma avevano imparato a controllarlo, alimentandolo e utilizzandolo per scaldarsi, per difendersi dagli animali e per cucinare dei bovini arcaici chiamati “uri”, oltre a tartarughe, capre, cervi, cavalli e perfino rinoceronti.
Alcuni siti archeologici hanno restituito artigli d’aquila decorati e oggetti che si pensa siano stati utilizzati dai Neanderthal nei rituali di sepoltura: indice di un pensiero simbolico elaborato. Nel 2018, i ricercatori hanno annunciato di aver scoperto resti di pitture rupestri risalenti a 65.000 anni fa: le più antiche opere d’arte di questo genere. L’analisi dei resti scoperti in due siti archeologici in Germania rivela inoltre come i Neanderthal fossero in grado di cacciare uno dei felini più grandi mai conosciuti, il leone delle caverne, usandone poi le pelli in contesti culturali: si tratta della prima prova diretta della caccia al leone nella storia umana. Insomma, tutto l’arsenale tecnico e culturale che definisce quella che chiamiamo civiltà e che per molto tempo abbiamo ritenuto essere esclusiva della nostra specie.
Queste ricerche, va da sé, non rivoluzionano solo le nostre conoscenze scientifiche, ma ci interrogano anche dal punto di vista filosofico: la presenza di un’altra specie del genere Homo intelligente quanto la nostra mette in discussione millenni di antropocentrismo e dà un colpo mortale all’umanismo. Anche il Neanderthal, quindi, era fatto a “immagine e somiglianza di Dio”? Anche il Neanderthal aveva dei “diritti innati”? Insomma, tutto il nostro armamentario culturale, basato sull’eccezionalità della nostra specie, va a farsi benedire. Ancora tutta da scoprire, poi, l’influenza dei geni Neanderthal sulla parabola del Sapiens. Come è noto, nel nostro Dna sono conservati i resti di antiche ibridazioni delle due specie, che per un certo periodo si trovarono a convivere. Questa influenza genetica non si fa però sentire in modo uniforme su tutti i gruppi umani attualmente viventi sulla Terra.
Uno studio uscito nel 2020 su Science Advances ha rivelato il più antico evento di ibridazione mai registrato tra le popolazioni umane arcaiche. Gli antenati di Neanderthal e Denisova (una popolazione sorella dei Neanderthal che ha abitato le grotte di Denisova nei monti Altai, in Siberia), usciti dall’Africa circa 700.000 anni fa, si sarebbero incrociati con una popolazione euroasiatica del genere Homo, probabilmente Erectus, che aveva lasciato l’Africa molto prima, circa 1,9 milioni di anni fa. Non solo: ulteriori ibridazioni si sarebbero ripetute intorno ai 50.000 anni fa tra sapiens da una parte e Neanderthal e Denisova dall’altra. Questi incroci avvenuti tutti dopo l’uscita dall’Africa avrebbero però determinato una sostanziale differenza con le popolazioni che invece in Africa sono restate. Fino a qualche tempo fa si credeva che le popolazioni africane non avessero affatto geni Neanderthal nel loro Dna. Oggi sappiamo che questo è parzialmente falso, una certa quota è presente anche nel loro corredo genetico, seppur in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto non si verifichi fra le popolazioni eurasiatiche.
Quanto ha pesato questa eredità biologica nel differente sviluppo culturale delle popolazioni umane? Non lo sappiamo e ovviamente la questione è piuttosto tabù per via di implicazioni piuttosto evidenti. Ma non di meno merita di essere posta.