True
2019-03-31
La democrazia dei dem negli Usa: togliere peso elettorale agli altri Stati
True
iStock
«Credo che abbiamo bisogno di un emendamento costituzionale che protegga il diritto di voto per ogni cittadino americano», ha non a caso affermato la senatrice del Massachusetts. La proposta è stata ripresa a stretto giro da un altro candidato alla nomination democratica, il texano Beto O' Rourke, secondo cui nell'idea della Warren ci sarebbe «molta saggezza». Se insomma la sinistra del Partito Democratico non sembri amare troppo l'attuale sistema elettorale americano, di diverso avviso pare invece essere Donald Trump, che ha twittato: «La forza del Collegio Elettorale è che devi andare in molti Stati per vincere. Con il voto popolare, vai nei grandi Stati - le città finirebbero per governare il Paese, gli Stati più piccoli e l'intero Midwest finirebbero per perdere ogni rilevanza - e non possiamo permettere che ciò accada».
Per capire come mai tale questione sia piombata improvvisamente al centro del dibattito politico d'oltreoceano, è forse utile fare un passo indietro, partendo dal funzionamento di questo controverso sistema. In base a quanto prescrive la stessa Costituzione, la scelta del presidente degli Stati Uniti avviene attraverso un'elezione di secondo grado. Gli elettori di ciascuno Stato eleggono i grandi elettori che, a loro volta, si trovano ad esprimere il presidente. In quest'ottica, uno Stato ha diritto a un numero di grandi elettori proporzionale all'ampiezza della propria popolazione: per esempio, la popolosa California dispone attualmente di cinquantacinque delegati, laddove lo spopolato Alaska ne possiede appena tre. Solitamente chi riesce a conquistare la maggioranza nel voto popolare in un singolo Stato, consegue l'intero pacchetto di delegati a cui quello stesso Stato ha diritto.
Ora, data tale articolazione, può talvolta accadere che un candidato riesca ad arrivare alla Casa Bianca pur non vincendo nel voto popolare. Una situazione rara che tuttavia può verificarsi quando si riesce a inanellare molte vittorie negli Stati piccoli, perdendo invece in quelli di dimensioni maggiori. Una situazione che si è verificata, ad oggi, cinque volte nella Storia americana. Nel 1824 con John Quincy Adams, nel 1876 con Rutherford Hayes, nel 1888 con Benjamin Harrison, nel 2000 con George W. Bush e infine nel 2016 con Donald Trump. Ed è proprio qui che casca il proverbiale asino.
Due anni fa, il magnate newyorchese ha conquistato la Casa Bianca, nonostante la sua avversaria Hillary Clinton lo avesse sopravanzato del 2,1% nel voto popolare. Questo fatto ha spinto molti democratici ad affermare che quella di Trump non possa considerarsi una vera vittoria, visto che il popolo in realtà non lo avrebbe appoggiato. La stessa Hillary, oltre ad incolpare gli immancabili hacker russi, attribuì la sua sconfitta a un sistema elettorale considerato iniquo e difettoso. Ecco: è proprio a questo argomento che si rifanno le recenti istanze della Warren e di O' Rourke. C'è quindi da capire innanzitutto se le loro proposte abbiano qualche speranza tecnica di successo.
Cambiare il sistema elettorale americano implicherebbe una modifica costituzionale, il che richiederebbe un processo lungo e tortuoso. Per approvare un emendamento è infatti necessario una maggioranza di due terzi al Congresso, oltre all'assenso dei parlamenti di tre quarti degli Stati: risulta pertanto improbabile che gli Stati più piccoli possano decidere di accettare un cambiamento che, di fatto, li taglierebbe fuori dal processo per l'elezione del presidente. Un sistema basato esclusivamente sul voto popolare favorirebbe infatti solo gli Stati di grandi dimensioni e più popolosi, estromettendo tutti gli altri. E' allora chiaro che – nonostante alcuni limiti oggettivi – l'attuale sistema miri a spalmare la rappresentanza su un territorio vasto e culturalmente complesso come effettivamente sono gli Stati Uniti d'America. Paradossalmente sarebbe proprio il modello del voto popolare a minare la possibilità di rappresentanza democratica per tutti i cinquanta Stati americani, perché alla fine il peso elettorale si ritroverebbe limitato a una esigua manciata di territori. Possibile che né la Warren né O' Rourke se ne rendano conto? No: non è possibile. E, infatti, alla base delle loro proposte c'è una ragione squisitamente politica. Non dimentichiamo infatti che – fatta eccezione per il Texas – gli Stati americani tradizionalmente più popolosi (come la California e il New York) siano feudi del Partito Democratico. Va quindi da sé che un'eventuale introduzione del modello del voto popolare avvantaggerebbe infinitamente l'Asinello, penalizzando al contrario il Partito Repubblicano.
Perché alla fine è proprio questo il problema. Nel 2016, Hillary non ha perso per il sistema elettorale. Ha perso perché ha dato per scontato l'appoggio di classi elettorali che invece le hanno voltato le spalle. Ha preferito concentrarsi in aree dove aveva già la vittoria in pugno, anziché impegnarsi ad ascoltare territori e fasce di elettori da lei considerati scomodi (i famosi deplorables). È proprio da qui che il Partito Democratico dovrebbe ripartire, per cercare di metabolizzare e analizzare le cause di quella clamorosa sconfitta. E invece no: per risalire la china, sembra non trovare nulla di meglio che "censurare" gli elettori sgraditi. Non capendo che – proseguendo su questa strada – nel 2020 potrebbe finire col regalare a Trump una nuova, incredibile vittoria.
Breve storia dei tentativi di modificare il sistema elettorale
Nel corso della storia, si sono verificati svariati tentativi per modificare il sistema elettorale americano.
Nel 1934, una votazione per procedere alla sua abolizione fallì al Senato per appena due voti. A quel tempo, l'allora senatore democratico Alben Barkley aveva etichettato il sistema come "inutile", tanto da dire: «Il popolo americano è qualificato per eleggere il proprio presidente con un voto diretto, e spero di vedere il giorno in cui lo farà». Non fu accontentato.
Nel 1966, il senatore democratico Birch Bayh condusse delle audizioni con l'idea di tentare nuovamente lo smantellamento del sistema. Ma anche in quel caso, non ci fu nulla da fare. Era il 1979 quando invece il Senato tentò nuovamente di introdurre un modello di elezione diretta: tuttavia la mossa naufragò, in quanto la camera alta non riuscì a conseguire la maggioranza qualificata di due terzi, richiesta per le modifiche costituzionali.
Negli ultimi tempi, sta invece cercando di imporsi il "National Popular Vote Interstate Compact": un piano che prevedrebbe un insieme di Stati che si impegnerebbero ad assegnare i propri voti elettorali a chiunque vinca il voto popolare nazionale. Tuttavia molti territori sono al momento rimasti fuori da questo progetto. La possibilità di un'abolizione dell'attuale sistema elettorale resta quindi particolarmente difficile da realizzare. Almeno nel breve termine.
Continua a leggereRiduci
I democratici americani hanno trovato un nuovo totem da bersagliare: il sistema elettorale statunitense. Qualche giorno fa, Elizabeth Warren – candidata alle primarie dell'Asinello – ha dichiarato di voler sostenere una proposta che abolisca di fatto il modello dei grandi elettori per introdurre un sistema esclusivamente basato sul voto popolare. «Credo che abbiamo bisogno di un emendamento costituzionale che protegga il diritto di voto per ogni cittadino americano», ha non a caso affermato la senatrice del Massachusetts. La proposta è stata ripresa a stretto giro da un altro candidato alla nomination democratica, il texano Beto O' Rourke, secondo cui nell'idea della Warren ci sarebbe «molta saggezza». Se insomma la sinistra del Partito Democratico non sembri amare troppo l'attuale sistema elettorale americano, di diverso avviso pare invece essere Donald Trump, che ha twittato: «La forza del Collegio Elettorale è che devi andare in molti Stati per vincere. Con il voto popolare, vai nei grandi Stati - le città finirebbero per governare il Paese, gli Stati più piccoli e l'intero Midwest finirebbero per perdere ogni rilevanza - e non possiamo permettere che ciò accada».Per capire come mai tale questione sia piombata improvvisamente al centro del dibattito politico d'oltreoceano, è forse utile fare un passo indietro, partendo dal funzionamento di questo controverso sistema. In base a quanto prescrive la stessa Costituzione, la scelta del presidente degli Stati Uniti avviene attraverso un'elezione di secondo grado. Gli elettori di ciascuno Stato eleggono i grandi elettori che, a loro volta, si trovano ad esprimere il presidente. In quest'ottica, uno Stato ha diritto a un numero di grandi elettori proporzionale all'ampiezza della propria popolazione: per esempio, la popolosa California dispone attualmente di cinquantacinque delegati, laddove lo spopolato Alaska ne possiede appena tre. Solitamente chi riesce a conquistare la maggioranza nel voto popolare in un singolo Stato, consegue l'intero pacchetto di delegati a cui quello stesso Stato ha diritto. Ora, data tale articolazione, può talvolta accadere che un candidato riesca ad arrivare alla Casa Bianca pur non vincendo nel voto popolare. Una situazione rara che tuttavia può verificarsi quando si riesce a inanellare molte vittorie negli Stati piccoli, perdendo invece in quelli di dimensioni maggiori. Una situazione che si è verificata, ad oggi, cinque volte nella Storia americana. Nel 1824 con John Quincy Adams, nel 1876 con Rutherford Hayes, nel 1888 con Benjamin Harrison, nel 2000 con George W. Bush e infine nel 2016 con Donald Trump. Ed è proprio qui che casca il proverbiale asino.Due anni fa, il magnate newyorchese ha conquistato la Casa Bianca, nonostante la sua avversaria Hillary Clinton lo avesse sopravanzato del 2,1% nel voto popolare. Questo fatto ha spinto molti democratici ad affermare che quella di Trump non possa considerarsi una vera vittoria, visto che il popolo in realtà non lo avrebbe appoggiato. La stessa Hillary, oltre ad incolpare gli immancabili hacker russi, attribuì la sua sconfitta a un sistema elettorale considerato iniquo e difettoso. Ecco: è proprio a questo argomento che si rifanno le recenti istanze della Warren e di O' Rourke. C'è quindi da capire innanzitutto se le loro proposte abbiano qualche speranza tecnica di successo. Cambiare il sistema elettorale americano implicherebbe una modifica costituzionale, il che richiederebbe un processo lungo e tortuoso. Per approvare un emendamento è infatti necessario una maggioranza di due terzi al Congresso, oltre all'assenso dei parlamenti di tre quarti degli Stati: risulta pertanto improbabile che gli Stati più piccoli possano decidere di accettare un cambiamento che, di fatto, li taglierebbe fuori dal processo per l'elezione del presidente. Un sistema basato esclusivamente sul voto popolare favorirebbe infatti solo gli Stati di grandi dimensioni e più popolosi, estromettendo tutti gli altri. E' allora chiaro che – nonostante alcuni limiti oggettivi – l'attuale sistema miri a spalmare la rappresentanza su un territorio vasto e culturalmente complesso come effettivamente sono gli Stati Uniti d'America. Paradossalmente sarebbe proprio il modello del voto popolare a minare la possibilità di rappresentanza democratica per tutti i cinquanta Stati americani, perché alla fine il peso elettorale si ritroverebbe limitato a una esigua manciata di territori. Possibile che né la Warren né O' Rourke se ne rendano conto? No: non è possibile. E, infatti, alla base delle loro proposte c'è una ragione squisitamente politica. Non dimentichiamo infatti che – fatta eccezione per il Texas – gli Stati americani tradizionalmente più popolosi (come la California e il New York) siano feudi del Partito Democratico. Va quindi da sé che un'eventuale introduzione del modello del voto popolare avvantaggerebbe infinitamente l'Asinello, penalizzando al contrario il Partito Repubblicano.Perché alla fine è proprio questo il problema. Nel 2016, Hillary non ha perso per il sistema elettorale. Ha perso perché ha dato per scontato l'appoggio di classi elettorali che invece le hanno voltato le spalle. Ha preferito concentrarsi in aree dove aveva già la vittoria in pugno, anziché impegnarsi ad ascoltare territori e fasce di elettori da lei considerati scomodi (i famosi deplorables). È proprio da qui che il Partito Democratico dovrebbe ripartire, per cercare di metabolizzare e analizzare le cause di quella clamorosa sconfitta. E invece no: per risalire la china, sembra non trovare nulla di meglio che "censurare" gli elettori sgraditi. Non capendo che – proseguendo su questa strada – nel 2020 potrebbe finire col regalare a Trump una nuova, incredibile vittoria. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-democrazia-dei-dem-negli-usa-togliere-peso-elettorale-agli-altri-stati-2633242039.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="breve-storia-dei-tentativi-di-modificare-il-sistema-elettorale" data-post-id="2633242039" data-published-at="1773373800" data-use-pagination="False"> Breve storia dei tentativi di modificare il sistema elettorale Nel corso della storia, si sono verificati svariati tentativi per modificare il sistema elettorale americano.Nel 1934, una votazione per procedere alla sua abolizione fallì al Senato per appena due voti. A quel tempo, l'allora senatore democratico Alben Barkley aveva etichettato il sistema come "inutile", tanto da dire: «Il popolo americano è qualificato per eleggere il proprio presidente con un voto diretto, e spero di vedere il giorno in cui lo farà». Non fu accontentato. Nel 1966, il senatore democratico Birch Bayh condusse delle audizioni con l'idea di tentare nuovamente lo smantellamento del sistema. Ma anche in quel caso, non ci fu nulla da fare. Era il 1979 quando invece il Senato tentò nuovamente di introdurre un modello di elezione diretta: tuttavia la mossa naufragò, in quanto la camera alta non riuscì a conseguire la maggioranza qualificata di due terzi, richiesta per le modifiche costituzionali. Negli ultimi tempi, sta invece cercando di imporsi il "National Popular Vote Interstate Compact": un piano che prevedrebbe un insieme di Stati che si impegnerebbero ad assegnare i propri voti elettorali a chiunque vinca il voto popolare nazionale. Tuttavia molti territori sono al momento rimasti fuori da questo progetto. La possibilità di un'abolizione dell'attuale sistema elettorale resta quindi particolarmente difficile da realizzare. Almeno nel breve termine.
Enrica Bonaccorti (Ansa)
Il grande pubblico la conosce per i suoi trascorsi di conduttrice e opinionista tv, ruoli ricoperti a partire dai primi anni Ottanta e proseguiti in modo pressoché continuativo fino a pochi anni or sono, ma la Bonaccorti, nei suoi 75 anni di vita (era nata a Savona il 18 novembre 1949), ha fatto tantissimo altro. Innanzitutto l’attrice, muovendo i primi passi in ambito teatrale tra il finire degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, in quella Capitale dove si era da poco trasferita con la famiglia. Il suo debutto avviene presso il Teatro alla Ringhiera di Trastevere, uno dei tanti luoghi di sperimentazione e avanguardia della Roma di quel tempo (curiosità: lo spazio era situato in Via dei Riari e i Riario erano una nobile famiglia di origini savonesi, come Enrica), quindi giunge la partecipazione, nel 1970, allo spettacolo Mi è cascata una ragazza nel piatto (dalla pièce dell’inglese Terence Frisby), al fianco di Domenico Modugno e Paola Quattrini. Nello stesso periodo, in virtù della frequentazione di Modugno, si cimenta nella stesura di liriche, co-firmando i testi di due capisaldi del repertorio dell’artista pugliese: Amara terra mia (1971) e l’ancor più celebre La lontananza, uscita l’anno precedente. Al 1973 risale un evento fondamentale nell’esistenza della Bonaccorti: la nascita dell’amata (e unica) figlia Verdiana, frutto della relazione con l’allora marito Daniele Pettinari, regista e sceneggiatore. Nel 1969, intanto, Enrica aveva debuttato al cinema, entrando nel cast del film Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. Seguirà la partecipazione a numerose pellicole, buona parte delle quali riconducibili ai generi (talvolta fusi tra loro) della commedia e dell’erotismo, quest’ultimo frequentato dalla Bonaccorti in ragione di un fisico procace e statuario, esibito in film come Il maschio ruspante di Antonio Racioppi (1973) e Rag. Arturo De Fanti, bancario precario di Luciano Salce (1980) e in seguito, nel 1982, in un servizio fotografico per la rivista Playboy.
La carriera televisiva, che le darà la piena celebrità, ha inizio come già detto nei primi anni Ottanta, dapprima con le trasmissioni Rai Italia sera (1983-1986) e Pronto, chi gioca? (1985-1987, continuazione del Pronto, Raffaella? condotto dalla Carrà), poi con vari programmi per la Fininvest come La giostra (1987-1988), Cari genitori (1988) e l’indimenticata prima edizione di Non è la Rai (1991-1992). La Bonaccorti è stata anche scrittrice: nel suo ultimo libro, Nove novelle senza lieto fine, pubblicato pochi mesi fa, vi è un componimento in cui, confermando la sua abilità nell’uso delle parole, affronta con ironia ammirevole quella morte che sapeva vicina a causa del carcinoma al pancreas da cui era affetta: «Ho spesso pensato / alla morte / ma non ci ho mai veramente creduto / Soprattutto alla mia / Ora fra anagrafe e acciacchi / qualche dubbio mi assale / E se anch’io fossi mortale? / Ma non voglio sapere / né approfondire / l’idea di morire / mi uccide».
Continua a leggereRiduci
iStock
Non solo talento e allenamento: l’era dei dati entra nelle competizioni e vale miliardi. Dopo l’esperienza di Milano-Cortina 2026, l’intelligenza artificiale spinge performance, strategie e coinvolgimento dei tifosi, con un mercato globale previsto in crescita del 310% entro il 2034.
Alle Olimpiadi Invernali di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 non si è visto solo talento, fatica e spettacolo. Accanto agli atleti, spesso lontano dalle telecamere, ha lavorato anche un altro protagonista: l’algoritmo. Silenzioso, invisibile, ma sempre più decisivo. È il segno di una trasformazione che non riguarda solo una singola edizione dei Giochi, ma l’intero sistema sportivo.
I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno. Secondo Fortune Business Insights, il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata allo sport valeva 1,22 miliardi di dollari nel 2025, salirà a 1,43 miliardi nel 2026 e toccherà i 5,01 miliardi entro il 2034. Una crescita del +310% in meno di dieci anni, con un tasso medio annuo del 16,9%. A trainare questa espansione sono soprattutto le decisioni basate sui dati per migliorare le prestazioni e i risultati competitivi, insieme alle soluzioni di coinvolgimento personalizzato dei tifosi. Sempre più diffusa è anche l’analisi predittiva, utilizzata per prevenire infortuni, gestire i carichi di allenamento e programmare lo sviluppo degli atleti, mentre le piattaforme cloud rendono questi strumenti accessibili a squadre e campionati di ogni dimensione.
A Milano-Cortina l’intelligenza artificiale si è vista in modo concreto. Il Comitato Olimpico Internazionale ha presentato Olympic Gpt, un assistente digitale capace di rispondere in tempo reale alle domande degli spettatori su regolamenti, risultati e curiosità. Una sorta di guida virtuale per orientarsi tra gare e classifiche. Dietro le quinte, Olympic Broadcasting Services ha sperimentato strumenti di Ia per catalogare enormi flussi video, creare highlight automatici e arricchire le immagini con dati e analisi in tempo reale. Il salto di uno sciatore «fermato» a mezz’aria, con grafica su velocità e angolo d’atterraggio, non è solo un effetto scenico: è un nuovo modo di raccontare lo sport.
L’intelligenza artificiale però non si limita a descrivere le imprese, contribuisce a costruirle. La snowboarder americana Maddie Mastro ha corretto un errore tecnico grazie alla ricostruzione tridimensionale del suo movimento attraverso modelli basati su IA. La nazionale statunitense di bob e skeleton ha trasformato micro-variazioni e dati in un vantaggio competitivo. Nel pattinaggio di velocità sono stati creati gemelli digitali degli atleti per simulare la resistenza dell’aria, replicando virtualmente ciò che un tempo si faceva in galleria del vento. Secondo Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori della community Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e organizzatori della Ai Week, l’Ai non sostituisce il talento ma lo amplifica, permettendo di vedere dettagli invisibili e di prendere decisioni migliori in meno tempo. In discipline dove le medaglie si decidono per centesimi, anche una micro-correzione può fare la differenza. Anche l’Italia ha investito in monitoraggi e protocolli scientifici. Le due medaglie d’oro nello sci di Federica Brignone, tornata in gara dopo un grave infortunio, raccontano anche di analisi continue e della collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Invernali e partner privati per prevenire ricadute e ottimizzare il rientro. E perfino il curling, diventato popolare grazie ai successi di Stefania Constantini e Amos Mosaner, ha visto l’impiego di sistemi capaci di tracciare traiettorie reali e previsionali in tempo reale, offrendo un supporto tattico che fino a ieri era affidato soprattutto all’intuito.
La trasformazione in atto si muove lungo cinque direttrici principali: l’ottimizzazione delle performance in tempo reale attraverso sensori e dispositivi indossabili; la previsione preventiva degli infortuni grazie all’analisi di dati biometrici e carichi di lavoro; il coinvolgimento personalizzato dei tifosi con contenuti e offerte su misura; lo storytelling automatizzato con riassunti generati in tempo reale; e un modello decisionale sempre più fondato su analisi oggettive di video e dati statistici. La passione resta umana, ma l’infrastruttura che la sostiene è sempre più intelligente. E quanto visto a Milano-Cortina potrebbe essere solo l’inizio.
Continua a leggereRiduci
Sul fronte macro, il conflitto che coinvolge Usa, Israele e Iran ha riacceso petrolio e gas, riportando al centro il rischio inflazione e la possibilità che la discesa dei tassi diventi più lenta e accidentata. «La situazione geopolitica fragile e il balzo energetico rischiano di mettere in difficoltà molte aziende, con possibili effetti a catena sul fronte dei prestiti e un aumento delle sofferenze», commenta Gaziano, «rendendo il percorso di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali molto più accidentato del previsto. Uno scenario che lo stesso Donald Trump non può permettersi a lungo, visto il calo di gradimento tra i suoi sostenitori iniziali dovuto all’incertezza economica». Negli Usa la volatilità sostiene ancora trading e advisory; in Europa, invece, la maggiore dipendenza energetica rende il settore più esposto a uno choc prolungato.
«L’esposizione diretta delle banche europee al conflitto in Medio Oriente è molto limitata e si concentra essenzialmente negli Emirati Arabi Uniti, riguardando due istituti, Standard Chartered e Hsbc», aggiunge Jerome Legras, head of research Axiom Alternative Investments. «Dato ciò», continua, «il meccanismo di trasmissione del rischio dominante per gli istituti di credito del Vecchio continente è quello macroeconomico: uno choc dei prezzi del petrolio che si ripercuote sull’inflazione, sulle aspettative dei tassi di interesse e sulle condizioni di finanziamento in generale, piuttosto che tradursi in perdite dirette di bilancio. Sebbene i fattori geopolitici siano molto diversi, questo scenario macroeconomico non è dissimile da quello osservato durante le prime settimane della guerra in Ucraina. In quell’occasione, l’impatto sui tassi ha pesato di più rispetto a quello sulla qualità degli attivi, grazie alle ingenti riserve detenute dalle banche e ai loro criteri conservativi nella concessione dei prestiti. Resta da vedere se lo stesso vale per una guerra che probabilmente sarà molto più breve».
Continua a leggereRiduci
Un secolo di storia, un racconto di famiglia, cultura e bollicine italiane: così Valdo ha celebrato a Milano i suoi primi cento anni. Il Teatro Gerolamo è diventato per un giorno il palcoscenico di un viaggio attraverso i riti sociali, le trasformazioni del gusto, una visione imprenditoriale e l’evoluzione di un prodotto che è diventato un’icona contemporanea.
È così che l’evento Cento anni di Valdo. Quando il Prosecco diventa cultura ha intrecciato narrazione corale, immagini e racconti, restituendo il Prosecco non solo come prodotto, ma come gesto conviviale, linguaggio sociale e simbolo di italianità.

A guidare il pubblico tra ricordi, aneddoti e visioni future è stato Pino Strabioli, conduttore televisivo e divulgatore di costume. Al suo fianco, Pierluigi Bolla, presidente di Valdo e seconda generazione alla guida dell’azienda, ha raccontato il percorso della famiglia e della società, affiancato dalla chef stellata Chiara Pavan e dal giornalista wine expert Giulio Somma. «Se dovessi rappresentare in una definizione la storia di Valdo direi: “una vita vivace”», ha spiegato Bolla, citando lo storico claim pubblicitario degli anni Novanta. «Valdo ha sempre guardato al cambiamento con ottimismo, portando, con la freschezza di un perlage unico, gioia e leggerezza anche nei momenti quotidiani». La storia della famiglia Bolla, partita da Albano che nel 1883 produceva vino per i propri ospiti a Soave, ha trovato continuità nella creazione di Valdo nel 1951, un nome e un brand capaci di coniugare tradizione e innovazione. L’azienda ha saputo anticipare i tempi e costruire uno stile vinicolo riconoscibile. «Dalle sperimentazioni sul metodo classico alle cuvée dedicate alla ristorazione, Valdo ha creato vini che raccontano una storia enologica significativa», ha sottolineato Somma. Per Chiara Pavan, il legame tra territorio e gusto è centrale: «Il prosecco è legato a una terra vocata, con sapori unici, ed è ideale per una cucina sostenibile e attenta alle materie prime».
 Pierluigi Bolla
Pierluigi Bolla
L’intervista esclusiva realizzata a margine con Pierluigi Bolla ha reso ancora più chiaro il filo rosso tra passato e futuro dell’azienda. «Innovazione e tradizione sono sempre stati un mantra per Valdo», spiega l'imprenditore. «Oggi abbiamo sfide importanti: lo sviluppo dell’azienda Magredi, nuovi vini e spumanti, e il progetto dello spumante no alcohol. Innovazione e tradizione sono i binari su cui l’azienda deve continuare a muoversi». Ma l’attualità impone anche di guardare con prudenza ai mercati internazionali. Bolla parla di una «tempesta perfetta»: dazi, svalutazione dell’euro e un cambiamento nei comportamenti dei consumatori globali. «Si produce più vino di quello che si consuma. Negli Stati Uniti e in Francia si stanno spiantando migliaia di ettari. La situazione è complessa e richiede esperienza, prudenza, visione e qualche scommessa». Nonostante le difficoltà, il presidente di Valdo mantiene un ottimismo realistico: «Bisogna navigare in tempesta con la consapevolezza del nostro DNA imprenditoriale: avere visione, essere ottimisti e fare scelte coraggiose. L’impegno è vincere, come abbiamo fatto per cento anni».
Il talk e l’intervista hanno anche esplorato la strada del Prosecco del futuro. Valdo Purø – Alcohol Free Blanc de Blancs rappresenta una sperimentazione significativa: il primo spumante analcolico dell’azienda, premiato con la medaglia d’oro al Berliner Wein Trophy. Un esempio di come Valdo sappia conciliare innovazione, identità storica e attenzione al mercato contemporaneo. La sostenibilità è un tema centrale, sia per la produzione del vino sia per la cucina. «Oggi la cucina è più sobria, concentrata sulla materia prima e attenta all’ambiente», spiega Pavan. «È proprio il rispetto del territorio e dell’ecosistema a permetterci di avere prodotti di qualità e sapori autentici». Il territorio rimane cuore pulsante dell’azienda: le colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco, continuano a offrire la miglior espressione della Glera, interpretata con competenza e spirito innovativo. L’acquisizione di nuovi vigneti nelle Grave del Friuli amplia le possibilità di sperimentazione, tra metodo Charmat, classico e vini fermi.

La celebrazione del centenario non è solo memoria, ma impegno verso il futuro. Bolla sottolinea l’importanza di gestire la crescita in un mercato maturo, senza inseguire mode ma guidando il proprio percorso con responsabilità. «Cent’anni non sono un traguardo, sono una responsabilità», conclude. «Significa aver attraversato la storia senza perdere identità, sapere cambiare senza smarrirsi e avere ancora voglia e coraggio di innovare». Tra brindisi, ricordi e visioni, Milano ha salutato un secolo di Valdo, un’azienda che ha trasformato le bollicine in cultura, leggerezza e futuro, pronta a continuare a raccontare la propria storia, e quella di un’Italia che cambia ma continua a brindare con le sue eccellenze vinicole.
Continua a leggereRiduci
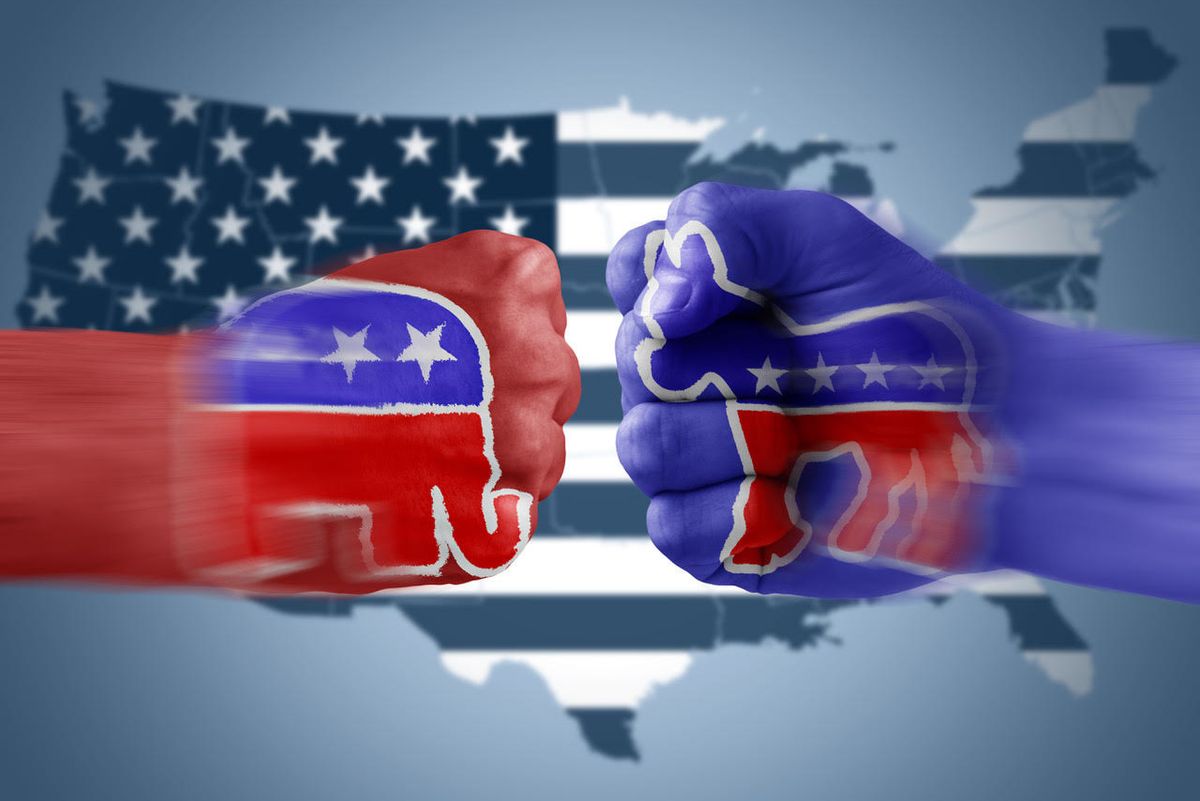





 Pierluigi Bolla
Pierluigi Bolla


