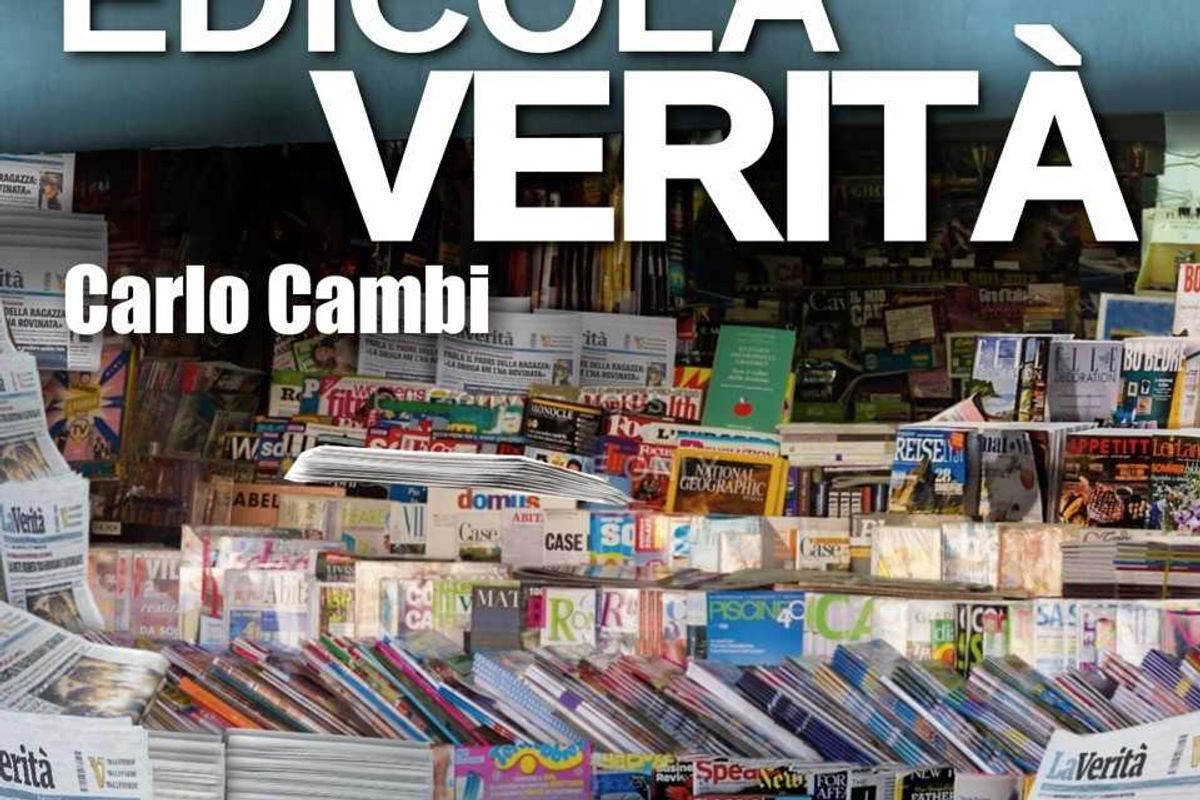Ma va là? Davvero? Chi l’avrebbe detto, eh? La mazzata eurogreen si è abbattuta sulle nostre case: quelle in classe energetica G e F hanno già perso valore, «una tendenza» per altro «destinata a rafforzarsi con l’approvazione della direttiva». Cioè le nostre case hanno già perso valore, ma ne perderanno ancora di più quando il provvedimento Ue sugli immobili sarà esecutivo. A fare la bella scoperta è Repubblica nel Paese delle meraviglie, che come una novella Alice si risveglia all’improvviso e si accorge che la realtà è più forte dell’ideologia. Ma siccome la realtà fa sempre un po’ paura, Repubblica ha pensato di nasconderla per benino dentro l’inserto Affari&Finanza di lunedì 28 agosto, a pagina 7, e rigorosamente in fondo all’articolo. Non si sa mai che qualcuno si accorga davvero di come stanno le cose. E cioè che in attesa delle case al verde, al verde ci finiamo noi.
Affari&Finanza pubblica i risultati di una ricerca del Centro Studi Re/Max, che è una della più grandi società immobiliari del mondo, assai diffusa anche in Italia. I dati si riferiscono al primo semestre dell’anno. E ci dicono che lo sconto medio sulle case di classe G è di circa due punti superiore rispetto alle case di classe A. In alcune regioni il divario è anche maggiore: in Lombardia, per esempio, sfiora i quattro punti, in Puglia supera i cinque, in Veneto si avvicina addirittura agli otto. A prima vista, voi direte, sembra una notizia positiva, perché indica un possibile risparmio per chi sceglie case energetiche di classe G: in Veneto, infatti, si può avere uno sconto addirittura del 12,27 per cento (otto punti in più rispetto a una casa in classe energetica A). Allo stesso modo chi compra una casa in Lombardia in classe energetica G può pagare in media quasi il 4,1 per cento in meno del prezzo indicato (mentre per le case energetiche in classe A il risparmio è praticamente nullo). E qui potrebbe sorgere il primo dubbio: stiamo parlando di sconti sul prezzo base. Perché un possibile risparmio dovrebbe essere una brutta notizia?
Semplice: per due motivi. Il primo è che il risparmio non è un affatto un risparmio. Ma solo la previsione di un costo futuro. In parole semplici: se comprate oggi una casa in classe energetica G, avete la certezza che in futuro dovrete eseguire costosi lavori per adeguarla alla direttiva europea. Il mercato, in attesa dei passaggi istituzionali che renderanno la direttiva esecutiva e che aumenteranno ancora gli effetti sul mercato immobiliare, già calcola il costo dei lavori richiesti dall’Ue. E che, per l’appunto, è l’equivalente di ciò che risparmiate oggi (e che spenderete domani). Ma attenzione (e siamo al secondo motivo): se anziché comprare, voi siete i proprietari di quella casa, beh, allora, ecco che il risparmio non solo smette di essere risparmio, ma diventa una perdita secca. I dati del Centro Studi Re/Max dimostrano infatti in modo inequivocabile, nonostante il tentativo di Repubblica di coprirli, che le vostre (ahimè: nostre) case hanno già perso valore. Valgono già di meno. Avete investito lì i vostri risparmi? Bene: Bruxelles se li è già portati via con la sua mannaia verde.
Facciamo qualche esempio? Immaginiamo che voi viviate in Lombardia e che abbiate una casa che oggi, sul mercato, è valutata 250.000 euro. Se è di classe energetica A continua a valere 250.000 euro o poche briciole di meno. Se è di classe energetica G invece vale 239.750 euro. Cioè vi sono spariti, come se nulla fosse oltre 10.000 euro. E siamo solo all’inizio perché la «tendenza» è «destinata a rafforzarsi con l’approvazione della direttiva». Se vivete in Puglia, per altro, vi va anche peggio: immaginiamo che abbiate sempre la stessa casa valutata 250.000 euro. Se è di classe A, stando sempre al Centro studi Re/max, sul mercato vale un po’ di meno (243.673 euro), ma se è di classe G sul mercato vale molto di meno, cioè 230.700 euro. Ergo: avete già bruciato sull’altare verde quasi 13.000 euro (12.973 per l’esattezza). Ancor peggio se vivete in Veneto: la vostra casa (sempre di valore base 250.000 euro) viene valutata 238.375 euro se è di classe A, e solo 219.325 euro se è di classe G. In altre parole, avete perso fin d’ora quasi 20.000 euro (19.050 euro per l’esattezza). Ovviamente se le vostre case valgono di più la perdita, calcolata in percentuale, aumenta ancora. Sempre in attesa, ovviamente che la «tendenza si rafforzi». E con tanta gratitudine per Timmermans & C.
Fatti i dovuti ringraziamenti anche al Centro studi Re/max che ha svolto lo studio e a Repubblica che ha pubblicato i dati in modo che se ne accorgessero meno persone possibili, ci permettiamo di sollevare un paio di modesti interrogativi. Primo: in un periodo già difficile, con i mutui alle stelle, l’inflazione che erode i risparmi, supermercati che sembrano diventati la boutique di Bulgari, eccetera eccetera, è il caso di massacrare l’ultimo bene rifugio delle famiglie, cioè la casa? È il caso di introdurre un’altra stangata, una patrimoniale da 10-20.000 euro, in salsa europea? Secondo: perché viene deliberatamente tolto valore ai nostri immobili, mentre invece le tasse sui medesimi rimangono le stesse, e cioè altissime? E infine, terzo: siccome queste cose le stiamo dicendo e scrivendo da mesi, quante altri Alici nel Paese delle meraviglie incontreremo ancora lungo il nostro cammino? È triste dovere dire: l’avevamo detto. Perciò non lo diciamo. Ma che le nostre case abbiano già perso valore per effetto della folle politica green europea nessuno lo può negare. E così non stupitevi se quando si parla di verde, a molti non viene in mente l’ambiente pulito. Ma il versamento di bile.