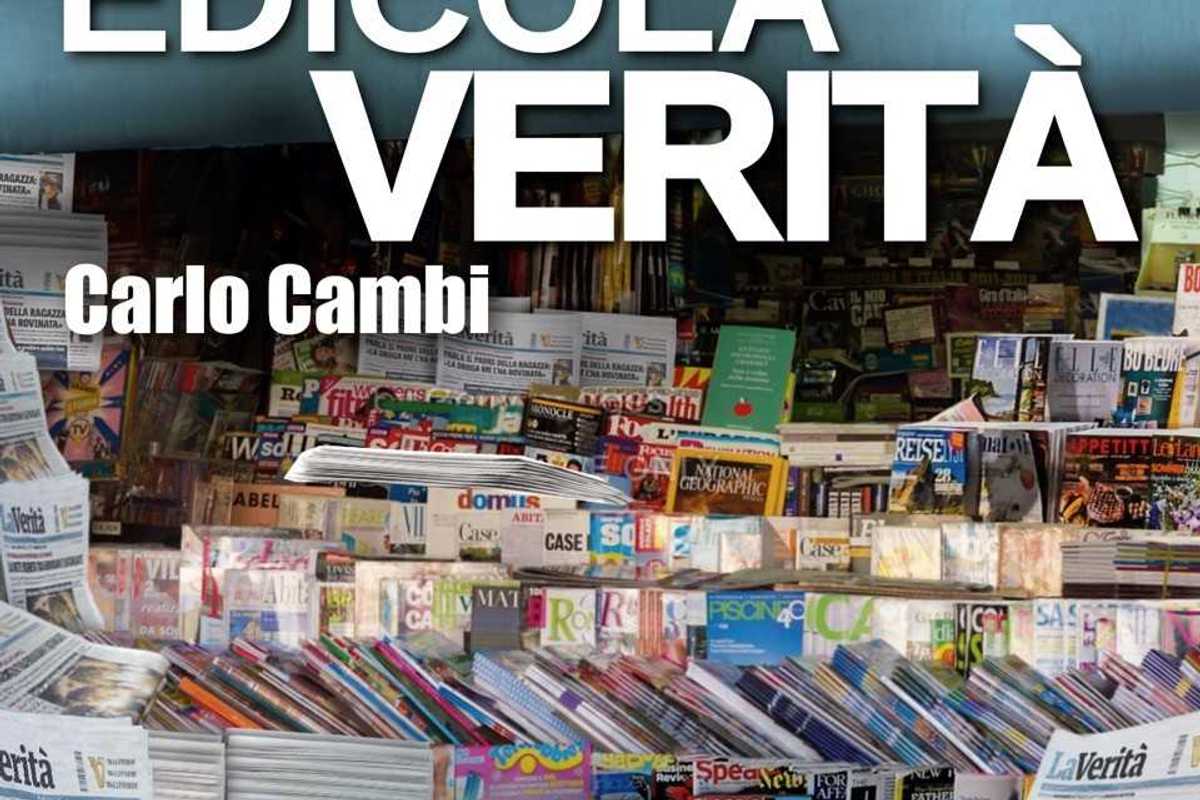Il Clean industrial deal della Commissione europea, che sarà presentato la settimana prossima a Bruxelles, conferma l’indirizzo scelto dall’Unione: spinta a energia rinnovabile, decarbonizzazione e industria delle tecnologie pulite. La bozza del provvedimento conferma che la Commissione intende puntare su questi elementi e perseguire l’obiettivo della decarbonizzazione delle attività industriali. Il tipo di sostegno previsto all’industria sarà variegato: si va dai sussidi ai finanziamenti agevolati, dalle semplificazioni burocratiche agli accordi internazionali, dalla tassazione ad accordi internazionali e provvedimenti di chiara impronta protezionista.
Il documento in sé non conterrà ancora provvedimenti concreti, ma solo i titoli, accompagnati da una breve descrizione. Si tratta infatti di una comunicazione della Commissione, dunque è una sorta di programma di lavoro che tratteggia le linee d’azione dell’Unione per i prossimi due anni. L’elenco dei provvedimenti in cantiere, tra regolamenti, raccomandazioni, piani d’azione, proposte legislative, pacchetti, atti delegati e chi più ne ha più ne metta, è assai corposo. Ne abbiamo contati 33 ma è possibile che qualcosa sia sfuggito o che la versione finale della comunicazione riporti un elenco diverso. La bozza è ancora in discussione e potrebbe subire modifiche anche sostanziali prima della presentazione ufficiale, prevista per il 26 febbraio a opera del commissario spagnolo Teresa Ribera.
La nuova bordata di regole europee per lo sviluppo dell’industria «pulita» è molto variegata anche nei contenuti. Intanto, si punta a prezzi più bassi per l’energia, con incentivi ai Power purchase agreement (Ppa) per le aziende. Si intende poi concedere finanziamenti agevolati per investimenti sulle reti, ammorbidire le regole sugli aiuti di Stato, prevedere condizioni fiscali agevolate (si parla di Iva «green»), snellire le procedure autorizzative, rivedere le regole sugli stoccaggi obbligatori di gas. Saranno imposti criteri obbligatori verdi negli appalti pubblici, etichettatura dei prodotti sul contenuto di CO2 (non obbligatoria ma con incentivi), nuovi sostegni all’idrogeno, spinta all’economia circolare, una disciplina per gli acquisti congiunti di materiali critici e relativo stoccaggio strategico. Vi saranno poi pacchetti di regole specifiche per l’industria dell’acciaio e dei metalli, per l’industria chimica, le biotecnologie e i trasporti.
Mentre spunta un documento che riporta la posizione della Germania (Berlino chiede maggiori sussidi di Stato e semplificazioni), in tema di commercio internazionale la Commissione intende avviare negoziati per nuovi trattati di libero scambio. Inoltre, vi saranno misure di contrasto ai sussidi stranieri e antidumping. In questo capitolo ricade anche la revisione del Carbon border adjustment mechanism (Cbam), argomento spinoso per due motivi. Il primo è che si tratta di un onere che grava sulle aziende europee, sia in termini di burocrazia sia di costi. Il secondo è che il Cbam costituisce di fatto un dazio all’importazione, di cui gli Stati Uniti e altri Paesi si sono già lamentati.
Il Cbam regola l’importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio applicando un prezzo del carbonio su determinati beni che entrano nell’Ue. Al momento il meccanismo è in una fase preliminare ma entrerà pienamente in vigore dal prossimo gennaio. A partire dal 2026, alla fine di ogni anno, le aziende dovranno dichiarare le emissioni delle loro importazioni e consegnare il numero corrispondente di certificati Cbam, acquistati presso le autorità nazionali. Proprio in questo periodo di sperimentazione la Commissione si è accorta che un numero limitato di importatori (circa il 20%) pesa per il 99% della CO2 importata. Già nel provvedimento omnibus in arrivo potrebbe quindi esserci una esenzione dagli obblighi Cbam per circa l’80% delle aziende europee.
Ma la tassa sulla CO2 importata resterà, suscitando così la reazione di molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti.
Sin dal suo apparire nel 2021 gli Usa si sono opposti in tutte le sedi a questo dazio mascherato. In un momento in cui Donald Trump ha già imposto tariffe del 25% su acciaio e alluminio e promette altri dazi reciproci, nonché ulteriori su automobili, farmaci e chip, la conferma del Cbam europeo rende la partita Usa-Ue complessa.
Tra poco più di un mese, il 2 aprile, la Casa Bianca illustrerà il pacchetto di dazi che certamente vedrà l’Ue tra i bersagli principali. Scorrendo il Clean industrial deal appare improbabile che l’Ue voglia fare del Cbam uno strumento negoziale, cioè che voglia esentare gli Stati Uniti dall’applicazione di questa carbon tax in cambio del ritiro dei dazi Usa. Di fatto, anzi, i dazi di Trump sono una reazione anche a questo tipo di tassa. L’approccio dell’Unione alle politiche di Trump sta diventando sempre più di scontro e il Cbam sarà certamente uno dei temi più caldi sul tavolo della discussione con Washington.