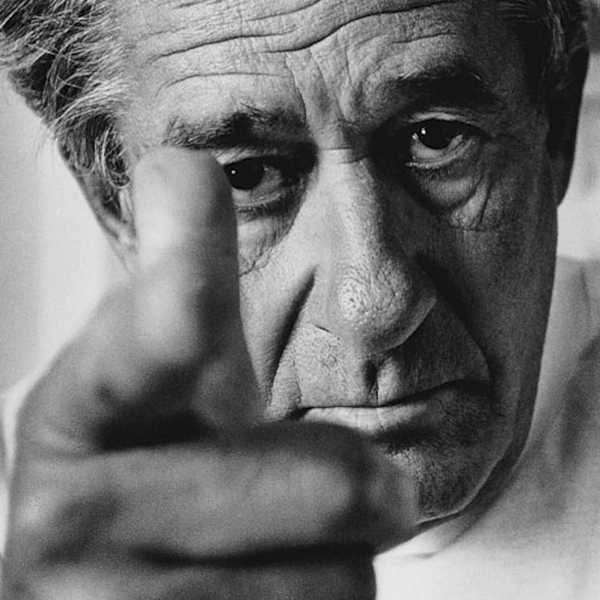True
2019-07-30
Gli americani con il pugnale di Rambo: «Hanno elevata pericolosità sociale»
Ansa
Colpire a sangue freddo un militare con un'arma di elevata potenzialità, un pugnale militare con lama da 18 centimetri, non è un gioco da ragazzi. Il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto di Gabriel Christian Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i due studenti americani che a Roma cercavano sballo e droga, sottolinea in modo preciso la pericolosità dei due indagati. Erano usciti per procurarsi cocaina, sono stati capaci di rubare uno zaino per poi tentare un'estorsione a pusher romani con precedenti di polizia. Ma, soprattutto, sono arrivati ad aggredire due carabinieri che si erano presentati con il tesserino d'ordinanza, assassinandone uno e mandando in ospedale l'altro. Il più compromesso del duo, Elder, è stato addirittura abile a sferrare «ben otto coltellate al torace di un uomo disarmato (l'autopsia in seguito ne referterà ben 11, ndr)», ossia il povero vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Entrambi gli indagati hanno poi avuto la lucidità di tornare in albergo, lavare il coltellaccio e nasconderlo nel controsoffitto della loro suite. I due, quella notte, erano scesi per strada già con cattive intenzioni. Il gip evidenza che il pugnale da Rambo, «custodito in un fodero, è di dimensioni tali che non era certamente possibile occultarlo in tasca. Peraltro», scrive il giudice, «vista la facilità e rapidità con cui Elder l'ha utilizzato nei confronti del vicebrigadiere, deve ritenersi che l'arma fosse a portata di mano dell'indagato». Un particolare che non solo non esclude, a parere del gip, le responsabilità dell'altro indagato ma che addirittura le rafforza. Natale Hjorth sapeva del coltello e conosceva anche le finalità per cui l'arma era stata portata all'incontro: «Ovvero», sottolinea il gip, «portare a compimento in modo fruttuoso il tentativo di estorsione architettato da entrambi». E infatti, «se Natale Hjorth ha risposto al telefono per organizzare l'incontro essendo l'unico tra i due che conosceva la lingua italiana, Elder, che si era materialmente impossessato dello zaino e che aveva proposto di tenerselo, ha poi architettato il piano estorsivo unitamente a Natale Hjorth, dopo essersi accorto della presenza del telefono, assistendo a tutte le fasi dell'organizzazione dell'incontro cui era pronto a partecipare».
Inutile, quindi, il tentativo di Natale Hjorth di far credere d'aver compreso la gravità dell'accaduto solo una volta giunto in albergo. È stato Elder, per esempio, a riferire che proprio il compare aveva nascosto il coltello dopo che lui l'aveva lavato e ha aggiunto che quando il vicebrigadire, dopo i primi colpi, aveva gridato, Natale Hjorth e il carabiniere Varriale si erano «resi conto che era successo qualcosa di brutto». Affermazioni che, secondo il gip, risultano del tutto credibili perché non tese a minimizzare la responsabilità del dichiarante. E siccome Natale Hjorth ha impegnato nella colluttazione Andrea Varriale, impedendogli d'intervenire per aiutare il collega, si becca pure lui l'accusa di concorso in omicidio volontario. «Ha certamente agevolato la condotta materiale posta in essere da Elder», scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale priva della libertà entrambi gli studenti statunitensi. Il giudice, insomma, non trova elementi per escludere che Natale Hjorth fosse consapevole: «Si è recato a un appuntamento con uno spacciatore per realizzare un'estorsione con un complice armato di coltello».
Tutti elementi che rendono prevedibile la messa in atto di azioni violente, «anche di entità tali, avuto riguardo per la potenzialità offensiva dell'arma», ritiene il gip, «di essere idonee a cagionare la morte del destinatario». La morte della persona offesa, a questo punto, secondo il gip, deve essere ritenuta un rischio accettato da Natale Hjorth o, quanto meno, «uno sviluppo logico altamente prevedibile dell'azione delittuosa concretamente posta in essere da entrambi gli indagati».
Il gip non si è lasciato prendere in giro neppure con la bugia del «non avevo capito che erano carabinieri». Perché, se Elder ha confermato la circostanza, dichiarata subito anche da Varriale, secondo cui i due militari si erano presentati mostrando anche il tesserino, Natale Hjorth fa il pesce in barile: riferisce di non aver capito che i due che li avevano avvicinati fossero carabinieri, ma anzi d'aver creduto che fossero uomini mandati dallo spacciatore per vendicarsi e fargli del male. La difesa improntata sulle difficoltà con la lingua italiana non regge. E risulta subito contraddittoria. Anche perché è stato proprio Natale Hjorth a condurre la trattativa telefonica con lo spacciatore. E di certo non l'ha condotta in inglese. Lo ha confermato proprio il pusher, sentito dal pubblico ministero nell'immediatezza, specificando che il ragazzo che aveva risposto al suo telefonino parlava sì con un accento inglese, però in italiano. Quindi immaginare che Natale Hjorth sia stato capace di tentare un'estorsione in italiano con il pusher per poi non comprendere la parola «carabinieri», risulta surreale. Non solo. Come conferma Varriale, l'aggressività mostrata da Natale Hjorth è stata notevole: «Ancor prima di procedere a una qualsiasi forma di regolare controllo ci aggredivano fisicamente per vincere un nostro tentativo di bloccaggio. Le concitate fasi della lite si svolgevano con estrema rapidità e violenza». Varriale sostiene di essere stato «aggredito dal soggetto con la felpa nera», che «dimenandosi fortemente con calci, graffi e pugni riusciva a liberarsi dalla mia presa». Insomma, a parere del gip ce n'è quanto basta per convalidare il fermo e trasformarlo in arresto. In più, come aveva già valutato il pm, «c'è pericolo di fuga». I due, infatti, erano in procinto di lasciare l'albergo: «Una condotta», conclude il giudice, «che non può non ritenersi finalizzata a far perdere le loro tracce». Infine c'è anche il pericolo che i due possano reiterare i reati, «vista la concentrazione di crimini perpetrati in un brevissimo lasso di tempo». Gli statunitensi appaiono anche inconsapevoli del disvalore delle proprie azioni, «mostrando una immaturità eccessiva». Il fatto che abbiano cercato di comprare droga e che, come hanno dichiarato, avevano consumato alcol, sono circostanze che «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e di capacità critica e», annota il gip, «rendono di conseguenza evidente la loro elevata pericolosità sociale».
L'unica misura cautelare valida a impedirgli di sottrarsi alle indagini e al processo, secondo il gip, è quindi quella «inframuraria».
Spaccio, ricatto e delitto. Cronistoria della nottata costata la vita a Mario
Le informative dei carabinieri, le parole dei protagonisti e quelle dei testimoni, gli interrogatori degli indagati e le immagini delle telecamere hanno permesso al gip del Tribunale di Roma, Chiara Gallo, di ricostruire attimo per attimo la sequenza di quanto accaduto tra Trastevere e il quartiere Prati nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Nell'ordinanza che priva della libertà i due studenti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, il gip fotografa le fasi che hanno portato all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e che dimostrano come tutto si è svolto senza grandi «zone d'ombra», al contrario di quanto era emerso nei primi istanti, quando ancora le notizie erano alquanto frammentate.
Tutto ha avuto inizio alle 23.30 del 25 luglio. Sergio Brugiatelli, conosciuto dalle forze dell'ordine e indicato come persona con «precedenti di polizia» (ma non un informatore, come precisato dall'Arma) è in piazza Trilussa con un amico di nome «Meddi». I due vengono avvicinati da due ragazzi stranieri (che poi scopriranno essere gli americani) che chiedono se hanno cocaina da fornirgli. Brugiatelli dice di non averne ma è in grado di recuperarla. I ragazzi, che chiedevano 80 euro di droga, vanno a prelevare da uno sportello bancomat. Trenta minuti dopo la mezzanotte, Brugiatelli e i due ragazzi si incamminano verso piazza Mastai. Brugiatelli contatta un amico - che dice chiamarsi Italo - in via telefonica e ottiene un appuntamento dall'altra parte di viale Trastevere, angolo via Cardinale Merry del Val. Brugiatelli e il ragazzo con i capelli biondi (Natale Hjorth) vanno verso il pusher, l'altro (Finnegan Lee Elder) resta sulla panchina della piazza, ove Brugiatelli aveva lasciato zaino e bicicletta. «Non appena entravamo in contatto con Italo», racconta Brugiatelli, «il ragazzo biondo gli consegnava del denaro e lui gli dava un piccolo involucro di carta stagnola». A questo punto, però, arrivano delle persone (carabinieri in borghese in attività antidroga) che bloccano Italo. Ed entra in scena il carabiniere Andrea Varriale. Nella sua annotazione il militare scrive che alle ore 1.19 ha ricevuto da un superiore della stazione carabinieri Farnese - il maresciallo Pasquale Sansone - ordine di recarsi in piazza Mastai. Il maresciallo gli riferisce di trovarsi sul posto per la ricerca di un soggetto che non si era lasciato identificare dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro contenente una compressa di tachipirina. Qui spunta Brugiatelli, che avvicina le forze dell'ordine e riferisce di essere stato vittima di un borseggio. Dice anche che dopo il furto i due ladri si erano allontanati a piedi verso il Lungotevere, all'altezza di Ponte Garibaldi. Brugiatelli precisa subito che nella borsa c'erano il suo cellulare, i documenti e alcuni effetti personali. I carabinieri gli dicono di presentare denuncia all'indomani in un qualsiasi ufficio di polizia. Dopodiché riprendono il normale servizio. Ma un'ora dopo accade qualcosa che rimescola le carte: Brugiatelli contatta il 112 (sono le 2.04) perché sostiene di essere ora vittima di una tentata estorsione. L'uomo, difatti, ha tentato di chiamare il proprio cellulare con un altro - prestatogli di un amico - e a quel punto gli ha risposto un uomo con accento «inglese, americano», riferisce Brugiatelli, chiedendo soldi e droga per la restituzione dello zainetto. Vista la situazione i carabinieri mandano una pattuglia. Alla presenza dei militari Brugiatelli chiama di nuovo il proprio telefonino e riceve la richiesta di 80 euro e un grammo di cocaina per la restituzione del maltolto. L'appuntamento viene fissato in piazza Belli. Alle 2.10 entra in scena il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Viene contattato dalla centrale operativa che gli fornisce - insieme a Varriale - una nota d'intervento in piazza Belli. I due carabinieri recuperano Brugiatelli, lo lasciano accanto all'auto di servizio e intervengono. «Sono rimasto vicino all'auto civetta, poi ho sentito delle urla e ho visto sopraggiungere altre macchine dei carabinieri e un'ambulanza», dichiarerà al pm Brugiatelli. Sono circa le 3.15. L'annotazione di Varriale completa la ricostruzione. «I due soggetti, notati in atteggiamento palesemente guardingo e sospettoso, venivano da noi repentinamente avvicinati. Contestualmente ci qualificavamo come appartenenti all'Arma dei carabinieri attraverso anche l'esibizione dei nostri tesserini». E qui la situazione precipita. «I due ancor prima di procedere a una qualsiasi forma di regolare controllo ci aggredivano fisicamente». Il tutto si consuma in modo molto veloce. «Lo scrivente», annota Varriale, «veniva aggredito dal soggetto con la felpa nera, il quale dimenandosi fortemente con calci, graffi e pungi, riusciva a liberarsi dalla mia presa. Analogamente il vicebrigadiere, a breve distanza da me, ingaggiava una colluttazione con l'altro giovane e ricordo di aver sentito le urla del collega che proferiva “fermati, siamo carabinieri, basta"». I due americani fuggono. Varriale assiste agli ultimi istanti di vita del collega, «che perdeva moltissimo sangue dal fianco sinistro all'altezza del petto». Prima di accasciarsi, il vicebrigadiere pronuncia le sue ultime parole: «Mi hanno accoltellato».
Continua a leggereRiduci
Lee Elder e Natale Hjorth sono usciti dall'hotel armati, dopo aver cercato cocaina e tentato di ricattare un pusher. Hanno detto di non aver capito l'alt dei militari. Il gip non ci crede: con lo spacciatore si erano intesi in italiano.Ci sono stati vari contatti fra forze dell'ordine e pusher derubato ma non «zone d'ombra». L'Arma: «Non c'è alcun informatore».Lo speciale contiene due articoli. Colpire a sangue freddo un militare con un'arma di elevata potenzialità, un pugnale militare con lama da 18 centimetri, non è un gioco da ragazzi. Il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto di Gabriel Christian Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i due studenti americani che a Roma cercavano sballo e droga, sottolinea in modo preciso la pericolosità dei due indagati. Erano usciti per procurarsi cocaina, sono stati capaci di rubare uno zaino per poi tentare un'estorsione a pusher romani con precedenti di polizia. Ma, soprattutto, sono arrivati ad aggredire due carabinieri che si erano presentati con il tesserino d'ordinanza, assassinandone uno e mandando in ospedale l'altro. Il più compromesso del duo, Elder, è stato addirittura abile a sferrare «ben otto coltellate al torace di un uomo disarmato (l'autopsia in seguito ne referterà ben 11, ndr)», ossia il povero vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Entrambi gli indagati hanno poi avuto la lucidità di tornare in albergo, lavare il coltellaccio e nasconderlo nel controsoffitto della loro suite. I due, quella notte, erano scesi per strada già con cattive intenzioni. Il gip evidenza che il pugnale da Rambo, «custodito in un fodero, è di dimensioni tali che non era certamente possibile occultarlo in tasca. Peraltro», scrive il giudice, «vista la facilità e rapidità con cui Elder l'ha utilizzato nei confronti del vicebrigadiere, deve ritenersi che l'arma fosse a portata di mano dell'indagato». Un particolare che non solo non esclude, a parere del gip, le responsabilità dell'altro indagato ma che addirittura le rafforza. Natale Hjorth sapeva del coltello e conosceva anche le finalità per cui l'arma era stata portata all'incontro: «Ovvero», sottolinea il gip, «portare a compimento in modo fruttuoso il tentativo di estorsione architettato da entrambi». E infatti, «se Natale Hjorth ha risposto al telefono per organizzare l'incontro essendo l'unico tra i due che conosceva la lingua italiana, Elder, che si era materialmente impossessato dello zaino e che aveva proposto di tenerselo, ha poi architettato il piano estorsivo unitamente a Natale Hjorth, dopo essersi accorto della presenza del telefono, assistendo a tutte le fasi dell'organizzazione dell'incontro cui era pronto a partecipare».Inutile, quindi, il tentativo di Natale Hjorth di far credere d'aver compreso la gravità dell'accaduto solo una volta giunto in albergo. È stato Elder, per esempio, a riferire che proprio il compare aveva nascosto il coltello dopo che lui l'aveva lavato e ha aggiunto che quando il vicebrigadire, dopo i primi colpi, aveva gridato, Natale Hjorth e il carabiniere Varriale si erano «resi conto che era successo qualcosa di brutto». Affermazioni che, secondo il gip, risultano del tutto credibili perché non tese a minimizzare la responsabilità del dichiarante. E siccome Natale Hjorth ha impegnato nella colluttazione Andrea Varriale, impedendogli d'intervenire per aiutare il collega, si becca pure lui l'accusa di concorso in omicidio volontario. «Ha certamente agevolato la condotta materiale posta in essere da Elder», scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale priva della libertà entrambi gli studenti statunitensi. Il giudice, insomma, non trova elementi per escludere che Natale Hjorth fosse consapevole: «Si è recato a un appuntamento con uno spacciatore per realizzare un'estorsione con un complice armato di coltello». Tutti elementi che rendono prevedibile la messa in atto di azioni violente, «anche di entità tali, avuto riguardo per la potenzialità offensiva dell'arma», ritiene il gip, «di essere idonee a cagionare la morte del destinatario». La morte della persona offesa, a questo punto, secondo il gip, deve essere ritenuta un rischio accettato da Natale Hjorth o, quanto meno, «uno sviluppo logico altamente prevedibile dell'azione delittuosa concretamente posta in essere da entrambi gli indagati». Il gip non si è lasciato prendere in giro neppure con la bugia del «non avevo capito che erano carabinieri». Perché, se Elder ha confermato la circostanza, dichiarata subito anche da Varriale, secondo cui i due militari si erano presentati mostrando anche il tesserino, Natale Hjorth fa il pesce in barile: riferisce di non aver capito che i due che li avevano avvicinati fossero carabinieri, ma anzi d'aver creduto che fossero uomini mandati dallo spacciatore per vendicarsi e fargli del male. La difesa improntata sulle difficoltà con la lingua italiana non regge. E risulta subito contraddittoria. Anche perché è stato proprio Natale Hjorth a condurre la trattativa telefonica con lo spacciatore. E di certo non l'ha condotta in inglese. Lo ha confermato proprio il pusher, sentito dal pubblico ministero nell'immediatezza, specificando che il ragazzo che aveva risposto al suo telefonino parlava sì con un accento inglese, però in italiano. Quindi immaginare che Natale Hjorth sia stato capace di tentare un'estorsione in italiano con il pusher per poi non comprendere la parola «carabinieri», risulta surreale. Non solo. Come conferma Varriale, l'aggressività mostrata da Natale Hjorth è stata notevole: «Ancor prima di procedere a una qualsiasi forma di regolare controllo ci aggredivano fisicamente per vincere un nostro tentativo di bloccaggio. Le concitate fasi della lite si svolgevano con estrema rapidità e violenza». Varriale sostiene di essere stato «aggredito dal soggetto con la felpa nera», che «dimenandosi fortemente con calci, graffi e pugni riusciva a liberarsi dalla mia presa». Insomma, a parere del gip ce n'è quanto basta per convalidare il fermo e trasformarlo in arresto. In più, come aveva già valutato il pm, «c'è pericolo di fuga». I due, infatti, erano in procinto di lasciare l'albergo: «Una condotta», conclude il giudice, «che non può non ritenersi finalizzata a far perdere le loro tracce». Infine c'è anche il pericolo che i due possano reiterare i reati, «vista la concentrazione di crimini perpetrati in un brevissimo lasso di tempo». Gli statunitensi appaiono anche inconsapevoli del disvalore delle proprie azioni, «mostrando una immaturità eccessiva». Il fatto che abbiano cercato di comprare droga e che, come hanno dichiarato, avevano consumato alcol, sono circostanze che «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e di capacità critica e», annota il gip, «rendono di conseguenza evidente la loro elevata pericolosità sociale».L'unica misura cautelare valida a impedirgli di sottrarsi alle indagini e al processo, secondo il gip, è quindi quella «inframuraria». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/gli-americani-con-il-pugnale-di-rambo-hanno-elevata-pericolosita-sociale-2639466543.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="spaccio-ricatto-e-delitto-cronistoria-della-nottata-costata-la-vita-a-mario" data-post-id="2639466543" data-published-at="1771625202" data-use-pagination="False"> Spaccio, ricatto e delitto. Cronistoria della nottata costata la vita a Mario Le informative dei carabinieri, le parole dei protagonisti e quelle dei testimoni, gli interrogatori degli indagati e le immagini delle telecamere hanno permesso al gip del Tribunale di Roma, Chiara Gallo, di ricostruire attimo per attimo la sequenza di quanto accaduto tra Trastevere e il quartiere Prati nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Nell'ordinanza che priva della libertà i due studenti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, il gip fotografa le fasi che hanno portato all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e che dimostrano come tutto si è svolto senza grandi «zone d'ombra», al contrario di quanto era emerso nei primi istanti, quando ancora le notizie erano alquanto frammentate. Tutto ha avuto inizio alle 23.30 del 25 luglio. Sergio Brugiatelli, conosciuto dalle forze dell'ordine e indicato come persona con «precedenti di polizia» (ma non un informatore, come precisato dall'Arma) è in piazza Trilussa con un amico di nome «Meddi». I due vengono avvicinati da due ragazzi stranieri (che poi scopriranno essere gli americani) che chiedono se hanno cocaina da fornirgli. Brugiatelli dice di non averne ma è in grado di recuperarla. I ragazzi, che chiedevano 80 euro di droga, vanno a prelevare da uno sportello bancomat. Trenta minuti dopo la mezzanotte, Brugiatelli e i due ragazzi si incamminano verso piazza Mastai. Brugiatelli contatta un amico - che dice chiamarsi Italo - in via telefonica e ottiene un appuntamento dall'altra parte di viale Trastevere, angolo via Cardinale Merry del Val. Brugiatelli e il ragazzo con i capelli biondi (Natale Hjorth) vanno verso il pusher, l'altro (Finnegan Lee Elder) resta sulla panchina della piazza, ove Brugiatelli aveva lasciato zaino e bicicletta. «Non appena entravamo in contatto con Italo», racconta Brugiatelli, «il ragazzo biondo gli consegnava del denaro e lui gli dava un piccolo involucro di carta stagnola». A questo punto, però, arrivano delle persone (carabinieri in borghese in attività antidroga) che bloccano Italo. Ed entra in scena il carabiniere Andrea Varriale. Nella sua annotazione il militare scrive che alle ore 1.19 ha ricevuto da un superiore della stazione carabinieri Farnese - il maresciallo Pasquale Sansone - ordine di recarsi in piazza Mastai. Il maresciallo gli riferisce di trovarsi sul posto per la ricerca di un soggetto che non si era lasciato identificare dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro contenente una compressa di tachipirina. Qui spunta Brugiatelli, che avvicina le forze dell'ordine e riferisce di essere stato vittima di un borseggio. Dice anche che dopo il furto i due ladri si erano allontanati a piedi verso il Lungotevere, all'altezza di Ponte Garibaldi. Brugiatelli precisa subito che nella borsa c'erano il suo cellulare, i documenti e alcuni effetti personali. I carabinieri gli dicono di presentare denuncia all'indomani in un qualsiasi ufficio di polizia. Dopodiché riprendono il normale servizio. Ma un'ora dopo accade qualcosa che rimescola le carte: Brugiatelli contatta il 112 (sono le 2.04) perché sostiene di essere ora vittima di una tentata estorsione. L'uomo, difatti, ha tentato di chiamare il proprio cellulare con un altro - prestatogli di un amico - e a quel punto gli ha risposto un uomo con accento «inglese, americano», riferisce Brugiatelli, chiedendo soldi e droga per la restituzione dello zainetto. Vista la situazione i carabinieri mandano una pattuglia. Alla presenza dei militari Brugiatelli chiama di nuovo il proprio telefonino e riceve la richiesta di 80 euro e un grammo di cocaina per la restituzione del maltolto. L'appuntamento viene fissato in piazza Belli. Alle 2.10 entra in scena il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Viene contattato dalla centrale operativa che gli fornisce - insieme a Varriale - una nota d'intervento in piazza Belli. I due carabinieri recuperano Brugiatelli, lo lasciano accanto all'auto di servizio e intervengono. «Sono rimasto vicino all'auto civetta, poi ho sentito delle urla e ho visto sopraggiungere altre macchine dei carabinieri e un'ambulanza», dichiarerà al pm Brugiatelli. Sono circa le 3.15. L'annotazione di Varriale completa la ricostruzione. «I due soggetti, notati in atteggiamento palesemente guardingo e sospettoso, venivano da noi repentinamente avvicinati. Contestualmente ci qualificavamo come appartenenti all'Arma dei carabinieri attraverso anche l'esibizione dei nostri tesserini». E qui la situazione precipita. «I due ancor prima di procedere a una qualsiasi forma di regolare controllo ci aggredivano fisicamente». Il tutto si consuma in modo molto veloce. «Lo scrivente», annota Varriale, «veniva aggredito dal soggetto con la felpa nera, il quale dimenandosi fortemente con calci, graffi e pungi, riusciva a liberarsi dalla mia presa. Analogamente il vicebrigadiere, a breve distanza da me, ingaggiava una colluttazione con l'altro giovane e ricordo di aver sentito le urla del collega che proferiva “fermati, siamo carabinieri, basta"». I due americani fuggono. Varriale assiste agli ultimi istanti di vita del collega, «che perdeva moltissimo sangue dal fianco sinistro all'altezza del petto». Prima di accasciarsi, il vicebrigadiere pronuncia le sue ultime parole: «Mi hanno accoltellato».
Helmut Newton. Monica Bellucci, Blumarine, Monaco 1992 © Helmut Newton Foundabon
Tedesco di origine ebree naturalizzato australiano, di Helmut Newton (1920-2004) si è visto, detto e scritto di tutto. Fotografo «imperfetto», di se amava dire che «bisogna essere all’altezza della propria cattiva reputazione» e lui, nel bene e nel male, all’altezza della propria fama lo è sempre stato. Irriverente e trasgressivo, Newton voleva, amava e creava immagini forti, di quelle che lasciano il segno. E forti, altere, provocanti, ambigue, enigmatiche erano le sue donne, le modelle che immortalava nei suoi scatti senza tempo e fuori dal tempo. In bianco e nero soprattutto (pur senza disdegnare il colore, nonostante fosse daltonico...), con quei sapienti giochi di luce e ombre che sono il suo tratto distintivo. Donne di una bellezza inarrivabile, eleganti ed erotiche, che Newton, strizzando l’occhio al voyerismo e al sadomaso, ritraeva strette in corsetti di pelle, tacchi vertiginosi, lingerie provocanti, pose al limite della decenza: per alcuni, nessuno come lui ha saputo esaltare l’universo femminile; per altri, nessuno più di lui ne ha degradato la dignità. Il dibattito è tutt’ora aperto, e prendere una posizione non è poi così semplice. Ma una cosa è certa: nessuno può metterne in discussione la genialità.
Newton, ogni volta, riesce a stupire. E anche il «già visto» diventa novità. Come in questa mostra allestita a Caraglio (CN), negli originali spazi di un setificio seicentesco nato per intrecciare fili di seta e produrre tessuti preziosi, un’esposizione che raccoglie oltre 100 scatti del grande Maestro e che già nel titolo, Intrecci, rivela un rapporto profondo fra le immagini esposte e il luogo che le ospita, una sorta di connessione tra le « trame materiali » della tradizione tessile e quelle concettuali, elementi imprescindibili di tutti i lavori di Helmut Newton. Ricercatissimo da stilisti e riviste (Vogue F, Elle Francia e Queen Magazine solo per citarne alcune…), amato da top model ed attrici (per lui hanno posato, fra le altre, Monica Bellucci e Kate Moss, Carla Bruni ed Eva Herzigova), Newton ha saputo rivoluzionare e ridefinire i canoni della fotografia patinata, che con lui - inarrivabile nel creare immagini accuratamente inscenate - diventa linguaggio teatrale ed evocativo, suscitando spesso scandalo: come nel 1981, quando dopo un servizio fotografico di moda per Vogue Italia e Francia chiese alle modelle di spogliarsi per ritrarle nella stessa posa, ma nude…
La Mostra
Appositamente concepito per il Filatoio di Caraglio e curato da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino ( «L’ex setificio, un bellissimo edificio storico da tempo utilizzato per scopi culturali, è il luogo perfetto per una mostra di Helmut Newton incentrata sulla sua fotografia di moda più tarda… Oltre ad alcune delle fotografie iconiche di Helmut Newton, i visitatori avranno modo di scoprire anche numerosi scatti meno conosciuti e, così, di riscoprire la sua opera più celebre» ha dichiarato il curatore in occasione dell’inaugurazione), il ricco percorso espositivo si snoda attraverso otto sale, regalando al visitatore, già da subito, gli scatti più iconici di Newton, quelli che lo hanno reso uno dei fotografi di moda più famosi e influenti del XX secolo: particolarmente significativo, fra i vari ritratti di celebrità, il suo primo nudo, quello di Charlotte Rampling all’Hôtel Nord-Pinus di Arles nel 1973.
Di foto in foto, si passa alle immagini realizzate per le grandi committenze della moda (dal sodalizio decennale con Yves Saint Laurent alle celebri campagne pubblicitarie pensate per Versace e Anna Molinari) e della pubblicità: straordinarie, in mostra, la selezione di sette fotografie realizzate da Newton per la Lavazza, dove - nell’immagine centrale - una modella seminuda e con gli occhi bendati posa sotto il logo del marchio, dipinto con vernice spray su una parete grigia e spoglia.
Genio assoluto nell’uso della «mood photography», la tecnica che evoca il prodotto pubblicizzato senza mai rivelarlo in maniera esplicita, nei mitici anni ’90 firmò indimenticabili campagne pubblicitarie per lanciare i profumi di Laura Biagiotti e Yves Saint Laurent e le borse del marchio italiano Redwall.
Moda, bellezza, seduzione, ambiguità, arte, trasgressione, ironia, potere, genialità: in questa mostra c’è davvero tutto Newton e tutti i suoi Intrecci biografici, professionali e narrativi.
Continua a leggereRiduci
Papa Leone XIV (Ansa)
Una partecipazione, quella di Leone XVI, inattesa e che segue l’udienza del 26 gennaio concessa dal pontefice al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. Una partecipazione che assomiglia a una risposta senza troppe parole a certi gossip e chiacchiere da social che aleggiano su Comunione e Liberazione dopo i travagli vissuti in seguito alle dimissioni da presidente della Fraternità di don Julian Carron.
Papa Leone XIV sarà al Meeting sabato 22 agosto nel pomeriggio e poi presiederà una messa con i fedeli della diocesi di Rimini. La partecipazione all’evento del pontefice è stata diffusa ieri, insieme a un programma di visite che papa Prevost terrà in Italia nei prossimi mesi. Oltre a partecipare alla quarantasettesima edizioni del Meeting, il Papa sarà a Pompei e Napoli l’8 maggio, quindi il 23 maggio visiterà le Terre dei Fuochi, il 20 giugno andrà a Pavia sulla tomba del santo a lui più caro, Sant’Agostino, quindi il 4 luglio sarà a Lampedusa, sulle orme del predecessore Francesco (che sull’isola fece il suo primo viaggio). Il 6 agosto papa Leone XIV andrà, invece, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, per incontrare i giovani riuniti per l’ottocentesimo anniversario del Transito di San Francesco.
Un vero e proprio «tour» italiano quello programmato da papa Leone XIV che sempre ieri ha incontrato i preti della diocesi di Roma ricordando loro che «dobbiamo riconoscere che parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, e ciò invita a vigilare anche su una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione». Di fronte a una «crescente erosione della pratica religiosa», ha detto il Papa ai preti romani, non è più possibile applicare una «pastorale ordinaria […] che si preoccupa anzitutto di garantire l’amministrazione dei sacramenti», ma è «urgente ritornare ad annunciare il Vangelo: questa è la priorità». Se tra fede e sacramenti c’è una reciprocità essenziale è chiaro che la conclamata crisi di fede svuota dall’interno questo rapporto e riduce il sacramento, quando va bene, a consuetudine sociale.
Il viaggio in Italia del Papa andrà a toccare diversi punti nodali della vita pubblica e religiosa del Belpaese, e il Papa, ricordiamolo, è anche primate d’Italia. Da Pompei, a Lampedusa, da San Francesco a Sant’Agostino, fino appunto al Meeting di Rimini c’è un filo rosso che probabilmente segna questo tour, il desiderio del pontefice di ridare priorità all’annuncio del Vangelo davanti a una realtà sociale e culturale che appare stanca e ormai priva del nerbo di quei principi che hanno «fatto l’Italia». E gli italiani.
Proprio Giovanni Paolo II al Meeting di Rimini nel 1982 citava Sant’Agostino nell’apertura delle sue celebri Confessioni, laddove il santo ricorda che «il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te». «Siamo fatti per il Signore», chiosava Giovanni Paolo II, «che ha stampato in noi l’orma immortale della sua potenza e del suo amore. Le grandi risorse dell’uomo nascono di qui, sono qui, e solo in Dio trovano la loro salvaguardia». Così papa Wojtyla davanti al popolo del Meeting con parole che probabilmente sono molto vicine al sentire di papa Prevost. Il presidente della Fraternità di CL, Davide Prosperi, ha dichiarato: «Siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accolto il nostro invito: la sua partecipazione rappresenta per noi un segno di affetto molto desiderato».
Continua a leggereRiduci
La famiglia Trevallion (Ansa)
Ieri abbiamo pubblicato un testo scritto da questa donna che da troppo tempo soffre, e che era estremamente eloquente riguardo alla situazione in cui tutta la famiglia si ritrova. Il problema è che siamo di fronte a un dramma nel dramma. Quel documento - che è vero e importante - nasce come una comunicazione privata tra Catherine e le due donne che hanno la responsabilità dei suoi figli, e cioè Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, rispettivamente tutrice e curatrice dei tre minori. Secondo gli avvocati della famiglia, la tutrice, durante uno degli ultimi incontri, avrebbe sollecitato Catherine a esporre il proprio disagio e i motivi per cui secondo lei si sarebbe incrinato il rapporto con le istituzioni. Ebbene, Catherine ha accolto l’invito e scritto un lungo messaggio Whatsapp. La tutrice, per tutta risposta, ha preso quel messaggio e lo ha allegato alla relazione consegnata al tribunale. Perché lo ha fatto? Beh, per dimostrare la riottosità della madre.
Secondo la tutrice, infatti, quel messaggio è segno di «una totale chiusura al confronto da parte della madre con la scrivente, il cui atteggiamento è divenuto palesemente non dialogante». Catherine viene accusata di avere «mosso gravi addebiti alla scrivente (la tutrice, ndr), accusandola di trascurare il supremo interesse dei minori e di ignorare asseriti episodi di gravità verificatisi presso la struttura ospitante». Insomma, secondo la signora Palladino «si evidenzia un progressivo e allarmante irrigidimento dei minori nei confronti della scrivente che li ha incontrati plurime volte durante l’intero periodo, con cadenza quasi settimanale. Si osserva un mutamento involutivo nelle dinamiche relazionali, se in una prima fase era possibile mantenere un confronto costante, anche sereno e giocoso, nell’ultimo periodo - in coincidenza con il più brusco atteggiamento della madre - i minori tendono a sottrarsi sistematicamente all’interazione anche in forma di gioco».
Quella lettera, conferma alla Verità Tonino Cantelmi, autorevole esperto e consulente dei Trevallion, «è un messaggio che Catherine ha ritenuto di voler mandare alla tutrice e alla curatrice, e che loro hanno invece interpretato come ulteriore dimostrazione di ostilità, depositandolo in tribunale. Ma di fatto», continua Cantelmi, «quel testo esprime tutto il dolore di Catherine, e dal mio punto di vista, certifica perfettamente l’incapacità della tutrice, della curatrice e dell’assistente sociale di vedere il dolore di una madre e anche il dolore dei bambini. È un dolore che rimane invisibile agli occhi di quasi tutti quelli che si occupano dal punto di vista istituzionale di questa vicenda».
Constatare questo fatto mette i brividi. Una mamma sofferente viene invitata a confidarsi e quando lo fa le sue parole sono usate contro di lei come presunta prova della sua inadeguatezza. E non è tutto. Nei confronti di Catherine sembra esserci una particolare insistenza, come se la avessero presa di mira o individuata quale anello debole della catena famigliare. Per settimane sono state fatte trapelare mezze verità e indiscrezioni al fine di metterla in cattiva luce presso l’opinione pubblica. E come se non bastasse, durante i colloqui psicologici è stata sottoposta a un pesantissimo fuoco di fila di domande. Ben 570 quesiti, tanto che a un certo punto la poveretta è crollata.
«Ho molte perplessità su come è stata organizzata la seduta per questi test», dice Cantelmi. «Catherine ha tanto dolore, se avessimo dovuto fare tutto quello che era previsto avremmo finito forse per le 10 di sera. Dettaglieremo le nostre perplessità nelle sedi opportune. Abbiamo dato tutto il supporto possibile alla testista perché le cose venissero fatte bene: abbiamo una certa esperienza e forse potremmo, se accettassero il nostro aiuto, rendere le cose più semplici. Ma se non lo fanno ciascuno di assumerà le sue responsabilità».
Per Cantelmi, a questo punto, di responsabilità da assumersi ce ne sono parecchie. «Dal mio punto di vista - e non solo dal mio - non c’erano gli estremi per una sottrazione, un prelievo così doloroso. C’è stato un errore. Oggi ci rendiamo conto che quanto fatto è più dannoso di ciò che si voleva riparare, ma non ci sono il coraggio, la forza, la capacità autocritica di tornare indietro. Ho assistito con stupore, per esempio, alla difesa d’ufficio di quanto è stato fatto da parte della presidente dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo. Sarebbe più produttivo interrogarsi sul perché la maggior parte degli italiani, quando si parla di assistenti sociali, li immagini sottrattori di minori e non benefattori... In questo caso il prelievo si sta dimostrando drammaticamente controproducente. Bisognerebbe allora fare autocritica e tornare indietro.
A quanto pare, però, non c’è alcuna intenzione di riavvolgere il nastro. E nel frattempo va avanti con tempi discutibili la perizia psicologica sui genitori. «Questa perizia», spiega Cantelmi, «è partita in ritardo perché non si trovava un traduttore per fare una mediazione linguistica decente. Questo già la dice lunga. Questo traduttore, tra l’altro, ha degli impegni per cui ha accettato con delle limitazioni, di conseguenza ci sono dei periodi di sospensione. Io sono molto perplesso», continua il professore, «sull’azione della ausiliaria che deve fare i test o ha iniziato a fare i test con i genitori, sulle sue reali competenze e sulle sue reali capacità di mediazione. Inoltre questa perizia, a mio parere, oggi è largamente superata da tutti i dati che abbiamo a disposizione, provenienti anche dal team di neuropsichiatria infantile dell’Asl di Vasto che dichiara senza ombra di dubbio che questi genitori sono dei validi sostegni emotivi per i bambini, costituiscono un punto di riferimento importante. E concludono che occorre riunificare il nucleo familiare».
Il punto centrale di tutta la storia è, manco a dirlo, che i bambini stanno male. «Stanno subendo un trauma dolorosissimo che si rivela superiore ai problemi che erano stati in precedenza segnalati», dice Cantelmi. «Dal mio punto di vista il problema sono i servizi, hanno preso una decisione che si è rivelata, a mio parere, sbagliata e dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro. Basta con questa favola secondo cui prima del prelievo dei bambini sarebbe stato tentato di tutto: non è vero, si poteva fare meglio, si poteva fare di più e dobbiamo avere il coraggio di verificare le responsabilità di quello che è successo».
Il messaggio è chiaro: chi continua a tenere i bambini Trevallion separati dai genitori li danneggia, e dovrebbe prendersene la responsabilità. Tuttavia dubitiamo che lo farà.
Continua a leggereRiduci
Gli attori Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Fabrizio Gifuni, il regista Marco Bellocchio e l'attrice Barbora Bobulova alla première di «Portobello» durante l'82ª Mostra del Cinema di Venezia (Ansa)
Portobello, disponibile sulla nuovissima Hbo Max a partire da venerdì 20 febbraio, è la storia di un errore giudiziario, reso clamoroso dalla notorietà di colui che vi è rimasto implicato. Enzo Tortora era sulla bocca di tutti, nel 1982, conduttore d'oro, capace di raccontare il Paese e divertirlo. Aveva un pappagallo, con sé. Sorrideva, ordinato e composto. Non c'era italiano che non lo conoscesse. Era un divo. Eppure, non è scampato all'infamia, alla menzogna, alla crudeltà di chi non s'è fatto scrupolo nel gettargli addosso un inferno di bugie.
Bellocchio ha detto aver scelto la sua storia per la potenza delle immagini: lo sguardo spaesato di un uomo che, pur abituato alla messa in scena, non riusciva a spiegarsi cosa gli stesse succedendo, in manette fuori da una caserma. Tortora, che nella serie, la prima italiana a debuttare sulla piattaforma, è interpretato da Fabrizio Gifuni, è stato arrestato il 17 giugno 1983, dopo che un pentito della Camorra, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo, ne ha fatto il nome. Lo ha fatto dalla propria cella, quando il terremoto dell'Irpinia ha fatto scricchiolare l'organizzazione che la Camorra s'era data. Tortora, allora, è stato accusato di avere legami con il clan mafioso, di aver le mani in pasta, traffico di droga, piccoli e grandi orrori. Lo hanno portato in galera, poi processato.
Ed è di questo, dei suoi proclami di innocenza, degli occhi colmi di paura, del processo, che racconta Portobello, arrivando ad un'assoluzione che, però, non ha potuto restituire al conduttore tv la vita che gli era stata strappata.«C’erano reali contraddizioni, o anche apparenti, in Tortora. Era un antipatico di successo. Così popolare da arrivare a 28 milioni di Italiani, ma c’era una buona parte di Italia che con lui non simpatizzava. In parte era carattere, in parte certe posizioni che ha preso. Ci accorgiamo che le cose succedono quando finiscono di accadere. Lui si batteva all’interno dell’unica azienda di Stato. Non c’era nemmeno Rai Tre e lui si batteva in solitaria per la fine del monopolio dell’emittenza. Non apparteneva a nessuna delle due “grandi Chiese” a cui poi si sarebbe aggiunta la massoneria, è un laico in un paese molto cattolico. Tutto questo non spiega il caso ma ci fa capire perché il paese era pronto a voltargli le spalle.
Le cadute dei potenti attirano sempre, oggi lo vediamo coi social. Ma tutto questo spiega perché non si risveglia da quell’incubo. Era un fiero, orgoglioso che non ammiccava al pubblico. Non aveva la "furbizia" di Bongiorno e Pippo Baudo. Perfino le gaffes di Mike erano un modo per essere ricordato. Tortora parlava perfettamente, manteneva l’ambizione di un signore distaccato ammirato dall’Inghilterra. Così lo spavento diventa una furia interna. Non perse mai la calma, o quasi. Si sente tradito, comunque, il che lo accomuna ad Aldo Moro», ha provato a sintetizzare Gifuni, la cui interpretazione è stata datata al 20 febbraio per ricordare il giorno del 1987 in cui Tortora è tornato a condurre Portobello, uomo a metà in un'Italia di malagiustizia.
Continua a leggereRiduci