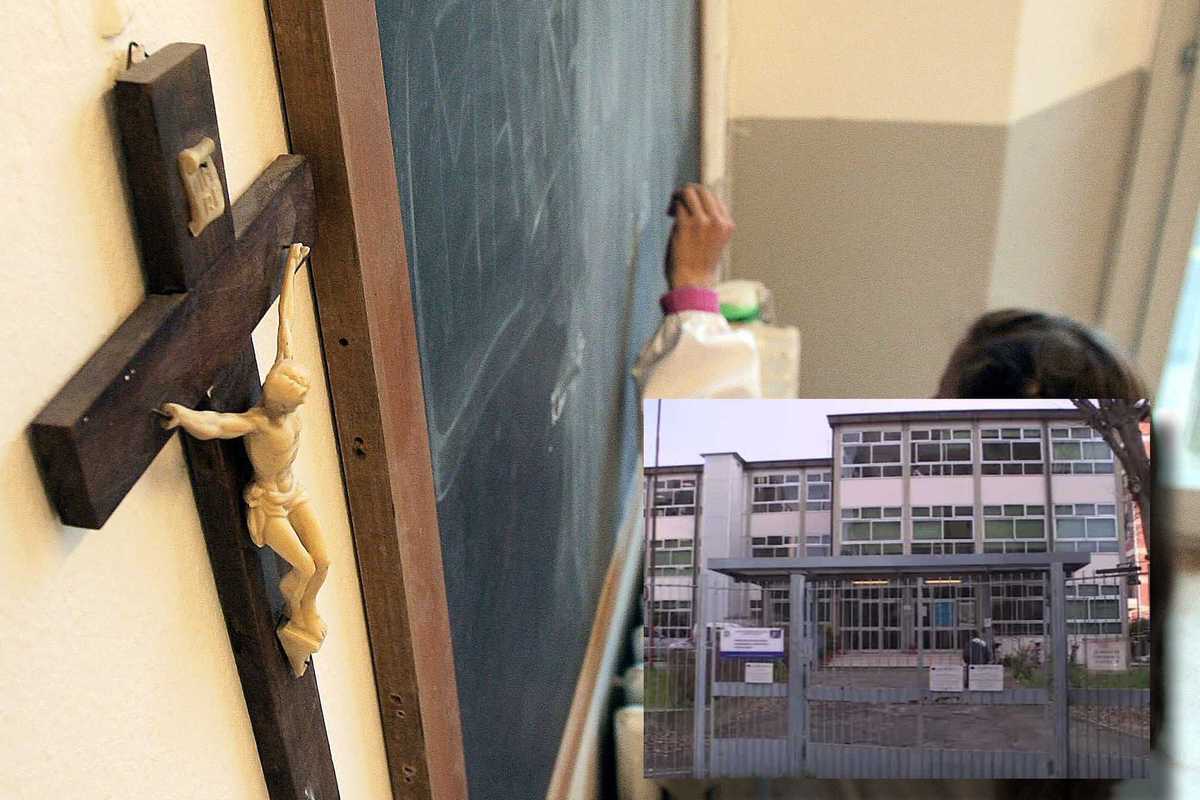Il tema della Difesa già in secondo piano. L’ipotesi recessione seppellisce il Rearm

Una delle prime vittime dei dazi imposti da Donald Trump sull'Unione europea è il piano di riarmo lanciato da Ursula von der Leyen. Dopo la tassa costituita dalla salita dei rendimenti obbligazionari europei a seguito dell'annuncio del Rearm Eu (poi ribattezzato più prudentemente Readiness 2030) ora il comparto delle industrie europee della difesa subisce il contraccolpo delle aspettative negative innescate dai dazi reciproci decisi dalla Casa Bianca la scorsa settimana.
Alla borsa di Francoforte la maggiore industria tedesca nel campo degli armamenti, Rheinmetall, ha toccato un minimo a 940 euro, dopo che venerdì aveva chiuso a 1.276 euro, con un calo del 26% e azzerando tutti i guadagni di marzo. Poi il titolo si è ripreso nel pomeriggio, arrivando a chiudere a 1.244, in calo del 2,5%. In apertura sono crollati anche altri due titoli tedeschi legati ai sistemi di difesa: Hensoldt, che ha toccato un minimo a -15% e ha chiuso a -2,34% rispetto a venerdì, e Mtu Aero Eng ines, che ha chiuso invece a -6,39%. In calo anche titoli francesi come Dassault (-5,18%) e Thales, che è scesa di oltre il 4,2%. In Italia, Leonardo ha chiuso a -3,32% dopo un’apertura da brivido a -14%. Giù anche i titoli britannici del settore. Tutti i titoli hanno aperto malissimo per poi recuperare nel pomeriggio, sulle voci di una sospensione di tre mesi dei dazi americani, poi smentita dalla Casa Bianca.
Sul mercato in calo fioccano le ipotesi sulle conseguenze dei dazi sull’economia mondiale, con la gran parte degli osservatori che propende per una recessione globale, con accenti diversi. Il comparto della difesa, che era salito molto negli ultimi due mesi a seguito delle discussioni con gli Stati Uniti sulla questione ucraina e sul riarmo europeo, aveva retto bene all’annuncio dei dazi americani. Ma la ritorsione cinese, che ha deciso contro-dazi del 34%, ha fatto precipitare la situazione innescando timori di una dura guerra commerciale.
I mercati temono il muro contro muro e gli andamenti delle borse di venerdì e di oggi lo testimoniano. Al di là delle dichiarazioni di facciata di Bruxelles e delle capitali del Nord Europa, è probabile che Parigi e Berlino stiano già trattando sottotraccia con gli Stati Uniti per cercare di alleviare il carico imposto sull’export.
Ma non sono solo i rischi di recessione, veri o presunti, a guidare il calo nei valori di borsa del comparto della difesa. Il vero potere che Donald Trump sta esercitando, in questo momento, è quello di imporre la propria agenda a tutto il mondo. Così come il tema della difesa era considerato prioritario e urgente sino al 1° aprile, dal 2 aprile il punto fondamentale nell’agenda è diventato il commercio globale e la difesa è passata in secondo piano.
Questo anche perché l’ipotesi di una recessione globale si scontra oggettivamente con l’idea del riarmo europeo. Oggi l’unico Stato dell’Unione europea che può fare massicci investimenti in armamenti è la Germania, cosa che peraltro creerebbe una pericolosa asimmetria interna all’Europa. Gli altri Paesi dovrebbero stornare fondi destinati ad altro (come i fondi di coesione), cosa che l’Italia, come ha già detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, non farà. Oppure, anzi in aggiunta, occorrerà sospendere il Patto di stabilità e le regole sul divieto di aiuti di Stato. Solo per decidere di investire, l’Unione europea deve sospendere o abolire regole che ingessano l’azione degli Stati e impediscono di agire. Già da qui si percepisce la distanza tra Washington e Bruxelles.
La prospettiva di una recessione richiede la possibilità di fare interventi anti-ciclici, cioè di investire per sostenere la domanda interna e le industrie nazionali, ma gli investimenti in armamenti in Europa non hanno un moltiplicatore molto favorevole. Dati gli spazi fiscali ristretti, è difficile che l’Unione possa sostenere un serio programma di riarmo in quelle condizioni. In realtà, anche allentando le regole europee su deficit e debito, sui mercati finanziari si rovescerebbe una massa enorme di obbligazioni, e non è detto che il mercato sia disposto ad acquistarle, se non a tassi più alti di quelli attuali.
In più, i due grandi Paesi che spingono per il riarmo, cioè Francia e Germania, sono in preda ad una crisi politica senza precedenti. Il raccogliticcio governo messo in piedi a Parigi da Emmanuel Macron si regge a stento e il cancelliere in pectore Friedrich Merz, non ancora in carica, vede la Cdu già in crisi di consenso, con Alternative für Deutschland che nei sondaggi è a un passo dall’essere il primo partito in Germania.
La serietà e la fattibilità del piano europeo di riarmo devono fare i conti con il ruolo primario esercitato nell’economia dagli Stati Uniti e dal dollaro. Gli scossoni cui stiamo assistendo sul mercato mostrano che nei momenti di crisi il sistema finanziario si rivolge al dollaro, non certo all’euro. Il calo dei rendimenti dei titoli del tesoro americano, asset molto liquido e considerato sicuro, lo testimonia. Infatti l’euro, che nei giorni scorsi aveva guadagnato sulla divisa americana, ieri è tornato a scendere riportandosi verso 1,09. Nonostante le roboanti dichiarazioni di Macron, Merz e Von der Leyen, insomma, l’influenza che Washington esercita sulla sfera europea è ben lontana dall’affievolirsi. It’s the economy, Ursula.