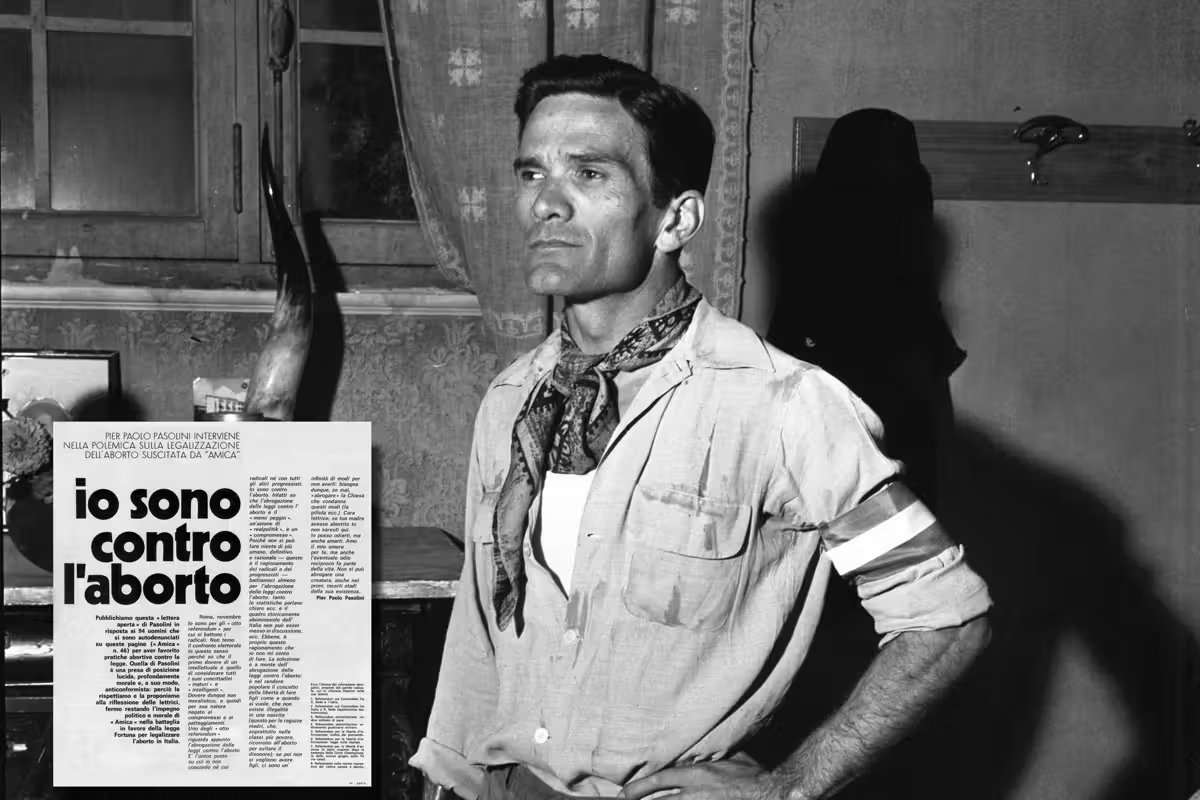Brunello Cucinelli: «Viviamo quel garbo che Draghi ci ha aiutato a ritrovare»
La Settimana della moda di Milano, dedicata alle collezioni uomo per la prossima primavera/estate, vede un ritorno all'eleganza e alla semplicità.
Brunello Cucinelli, uno degli imprenditori/stilisti più noti al mondo, che da tempo si diletta di filosofia, di Creato, che ama approfondire argomenti che toccano l'uomo nell'intimo, non a caso, nella presentazione della sua collezione cita una frase di Platone: «La bellezza dello stile, l'armonia, la grazia e il buon ritmo dipendono dalla semplicità, intendo la vera semplicità, quella propria di una disposizione retta e nobilmente ordinata». Che si plasma perfettamente sia sulla sua moda che sul suo pensiero. «Mi sembra che stiamo godendo, noi italiani, di quel garbo che il nostro Draghi ci ha aiutato a ritrovare» ha detto Cucinelli.
«Un garbo che ritroviamo anche nello sport. Mancini lo dimostra. Tutti i ragazzi sono curati, fanno gol e non vanno a sbraitare, esultano con un certo comportamento. Quando ci guardano da fuori vedono un'Italia diversa. Guardando le imprese italiane, ahimeè abbiamo perso, ma stiamo andando avanti positivamente. Il manufatto di basso livello non è più di nostra competenza e quello ci ha portato via un po' di lavoro». Brunello Cucinelli, comunque, risponde con un prodotto, come sempre, di altissima qualità che parte dalla semplicità, dal piacere di ritrovare il gusto per l'eleganza e il ben vestire. L'abito, simbolo per antonomasia di eleganza, è reinterpretato in una chiave fresca e disinvolta con giacca spezzata e pantaloni dalle linee leggermente ammorbidite in fibre naturali, dai classici cotoni ai lini estivi sino alle preziose tele di lana vergine. La qualità prima di tutto.
Anche Brett Johnson, designer originario della Virginia ma folgorato dall'Italia, punta su materiali di gran pregio come cashmere suede, pelle tinta a immersione a mano, baby cashmere, cotone sea island, seersucker di seta, jersey di cotone cashmere per la sua collezione estremamente raffinata. L'ispirazione arriva da un viaggio romantico a Portofino con la moglie al punto che visitare la costa italiana è stata un'esperienza trascendentale dopo il complicato periodo pandemico, una iniezione di energia positiva che ha dato vita ad una collezione di abbigliamento casual sportivo dal linguaggio elevato. I capi sono intrisi di colori mediterranei: bianchi, neutri, tonalità di blu, verde tropicale e flash di vivaci colori floreali si intrecciano con una palette più calda di marroni, miele e cammello, riflettendo la bellezza del paesaggio naturale sia alla luce del giorno che al tramonto.
Parla di «desiderate evasioni» Marco Baldassari, fondatore e direttore creativo uomo Eleventy. «Siamo ottimisti, fiduciosi e positivi e dopo lunghe stagioni di sport/homewear e di activewear, riapriamo il palcoscenico alla pura eleganza ritrovata». Il piacere della nuova libertà e il desiderio di cura di se stessi riporta il blazer al centro del guardaroba. «Un grande desiderio di libertà, che ho espresso nella volatilità di abiti e capi ultraleggeri e confortevoli, da indossare con naturalezza nell'intera giornata». La giacca ritorna così protagonista e, nella nuova generazione, è leggera e moderna da indossare non solo a lavoro ma anche in viaggio, nel tempo libero e perfino in momenti di relaxing e gym, come quella in seersucker leggermente elasticizzata che sta nel palmo di una mano e non si sgualcisce mai. Blazer in pregiati tessuti leggeri ma anche in tricot decostruiti o in maglia di lino chicco riso. Il Gruppo Eleventy, nell'occasione di presentazione della nuova collezione, ha annunciato un nuovo piano di sviluppo nel comparto dell'hotellerie di lusso che prende avvio con l'apertura di tre esclusivi flagship store all'interno di eleganti Resort in Italia: Verdura-Roccoforte Hotel, situato sulla costa meridionale della Sicilia a Sciacca; Forte Village in Sardegna a Santa Margherita di Pula; Terme di Saturnia&Golf in Toscana; che si aggiungono alla boutique al Capri Palace, inaugurata due anni fa.