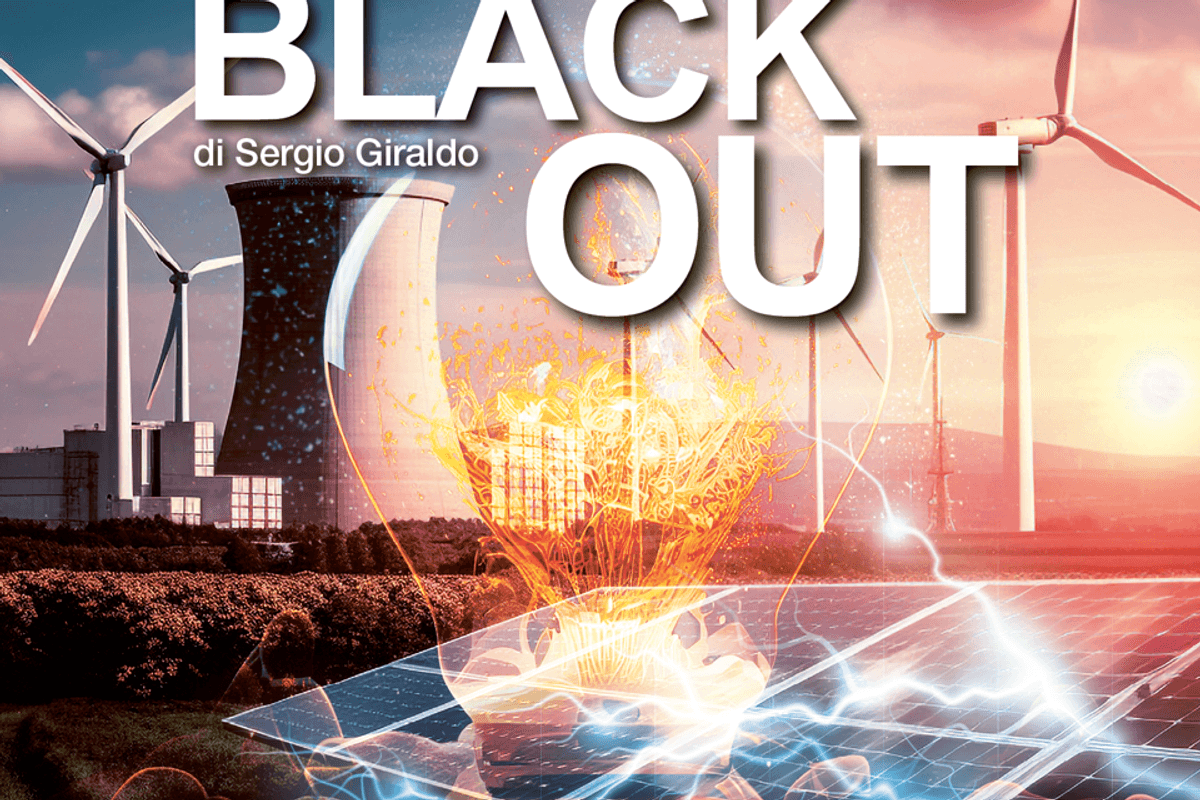«L’ipocrisia globalista con Trump è finita. E per il nostro Paese è una buona notizia»

Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, da giorni si ragiona, con evidente patema d’animo, dei dazi di Donald Trump. Dobbiamo spaventarci?
«Partirei da una premessa: l’internazionale progressista, qui da noi rappresentata dal Pd, ha tifato Kamala e ha perso, dopo aver negato l’evidenza, cioè che Biden non era un candidato plausibile (per motivi personali, meritevoli di rispetto e solidarietà), e dopo aver scornacchiato in ogni modo possibile il probabile vincitore, Donald Trump. Ci sta quindi che ora certi media e certi colleghi siano nervosetti e abbiano interesse a dipingere l’era Trump in toni apocalittici, aggiungendo la solita vena agrodolce di colpevolizzazione dell’elettorato, che fa tanto Maria Antonietta! In generale, avrebbe aiutato tutti, anche l’Italia, non negare l’evidenza e mantenere una posizione di terzietà rispetto alle vicende di un altro Paese. Questo è sempre il miglior viatico: male non dire, paura non avere».
Ragionevolmente, quindi, che cosa cambierà secondo lei rispetto all’era Biden?
«Il principale cambiamento non saranno i dazi, usati anche da Biden. Ho dato un’occhiata alla rassegna stampa fra novembre 2016 e febbraio 2017: anche allora si parlava dei dazi di Trump con toni da tregenda. Risultato: le esportazioni dell’Italia verso gli Usa aumentarono del 13% dal 2016 al 2019, un punto in più di quelle rispetto al resto del mondo. Questo perché i dazi sono uno strumento selettivo. Nel corso della disputa fra Boeing e Airbus Trump mise dazi sul vino inglese, francese e tedesco, non su quello italiano. Il vero cambiamento sarà un ridimensionamento del multilateralismo a vantaggio di accordi bilaterali fra Paesi: un’operazione di verità dopo i tanti fallimenti di tutte le istituzioni della globalizzazione (basti pensare a come l’Onu o il Fmi hanno gestito le emergenze di rispettiva competenza, dal Rwanda alla Jugoslavia all’Argentina alla Grecia). Diciamo che basta così».
È davvero possibile secondo lei implementare la domanda interna per fare fronte alle nuove gabelle?
«Sì! Si chiede oggi di fare all’Ue quello che è stato impedito di fare all’Italia: usare adeguatamente la propria domanda interna, senza soffocarla, per mettersi al riparo dalle sfide internazionali. Ha senso oggi, ma aveva molto senso anche nel 2011-‘12. Sarebbe più facile se il mercato unico europeo potesse funzionare liberamente».
Mario Draghi sostiene che l’Europa si è autoimposta i dazi e che bisogna cambiare strategia. Ha ragione?
«La tesi di Draghi è che le barriere interne avrebbero soffocato il mercato unico. Ora, a parte che alcune di queste barriere sono di natura antropologica (esempi: la lingua!) e quindi difficilmente sormontabili (per un dentista di Salonicco che voglia aprire uno studio a Helsinki la burocrazia non è il problema principale), questo argomento non tiene nei numeri: quello che ha strozzato il mercato interno è il fatto che in assenza della flessibilità del cambio, i Paesi membri si sono dovuti fare concorrenza al ribasso sui salari. Lo ha dichiarato lo stesso Draghi al Forum Sociale Europeo in aprile. Insomma: quando il mercato unico serve, perché quelli internazionali languono, siamo costretti a togliere soldi dalle tasche dei clienti per poter meglio vendere fuori dal mercato unico i beni che produciamo! Che cosa può andare storto in un sistema che funziona così? Direi quasi tutto, e la tenuta dell’Italia in questo contesto ha del miracoloso».
Viene appunto da chiedersi dove sia stato Draghi finora. E soprattutto che cosa motivi il suo cambio di visione.
«Dove fosse Draghi dal Britannia in qua lo sappiamo. Che cosa voglia è intuibile: mantenere un potere di indirizzo politico, ovviamente scisso da una legittimazione democratica. Dove voglia andare è chiaro: in fondo a ogni suo ragionamento, andando all’osso, c’è il keynesismo bellico pro domo Usa, cioè l’acquisto di armi degli Stati Uniti indebitandosi con i fondi degli Stati Uniti. Non siamo contrari né agli Usa né all’industria militare, mi sembra ovvio. Diciamo però che un ruolo così subalterno era quello in cui ci confinava l’amministrazione democratica: con la nuova credo che si possa fare un discorso più articolato».
Quanto ha impattato la guerra in Ucraina sulla attuale situazione europea?
«Le sanzioni non ci hanno aiutato e, per dirla tutta, non mi pare che abbiano danneggiato particolarmente l’economia russa. La Lega, peraltro, ha sempre esortato alla prudenza, almeno tanto quanto era possibile in un regime in cui chi osava dire una parola di buonsenso veniva tacciato a reti unificate di intelligenza con il nemico e rischiava di farsi silenziare sui media (parlamentari inclusi). Ma il disastro europeo è precedente e dovuto ad altre cause: all’idea tutta tedesca di far crescere l’economia sulla domanda degli altri Paesi, cioè sulle esportazioni, senza comprendere che il ruolo di una potenza egemone è anche quello di sostenere con la propria domanda i Paesi satelliti (gli Usa lo fanno) e senza capire che chi esporta beni importa problemi: i problemi geopolitici ed economici dei Paesi acquirenti. La Germania ha distrutto o indispettito tutti i suoi mercati di sbocco e ora si accartoccia su sé stessa tirandoci giù. Questa storia, anche nei dati, si palesa nel 2017 ed era prevedibile almeno dal 2011: l’Ucraina è una tragedia immane ma con questo c’entra poco».
Ieri a Parigi si è tenuto il vertice organizzato da Macron. Questo attivismo europeo per ottenere maggiore coinvolgimento nelle trattative sull’Ucraina a che cosa può portare secondo lei?
«L’Unione europea aveva un modo semplice per meritarsi un posto al tavolo, e in generale per legittimare la propria esistenza: evitare di spalmarsi acriticamente sulle posizioni non tanto degli Usa, quanto specificamente dell’amministrazione Biden, contemperando l’esigenza di affermare il diritto internazionale con quella di assicurare la pace. Difficile? Forse. Bastava però ricordarsi un dato di fatto: negli Usa i democratici dichiarano la guerra (anche per procura) e i repubblicani firmano la pace. Ma la prima Commissione Von der Leyen non ci ha nemmeno provato, reagendo con una violenza repressiva inusitata contro chiunque dicesse una parola di ragionevolezza. Risultato? L’Ue non viene più considerata dai Paesi emergenti come uno strumento di diversificazione del rischio politico (banalizzo: se sai che quando ti congelano il conto negli Usa te lo congelano anche nell’Ue, compri oro e te lo tieni in casa). Non viene considerata nemmeno un interlocutore politico, perché non ha avuto una voce propria: per sapere cosa penserebbe l’amministrazione Biden, Trump può telefonare all’interessato! Resta il fatto che, se da qui in avanti deponesse l’arroganza, anche questa Commissione poco lungimirante potrebbe avere un ruolo, dato che l’Europa (non l’Ue) è una piattaforma logistica imprescindibile per la ricostruzione dell’Ucraina».
Hanno fatto molto discutere le parole di J.D. Vance su Bruxelles. Le condivide?
«Sì, perché ha semplicemente detto la verità, rinfacciando all’Unione europea ciò cui accennavo prima, cui tutti abbiamo assistito e di cui molti hanno sofferto: il tradimento del principale valore di una democrazia occidentale, la libertà di espressione del pensiero, incluso quello che si esprime nelle urne con un voto democraticamente espresso (come è accaduto in Romania). Del resto, non è la prima volta che gli Stati Uniti vengono in Europa per restituire ai cittadini la libertà di esprimersi».
Che scenario va disegnandosi per l’Europa? Che cosa ci aspetta, dal punto di vista economico se non altro?
«Sono e resto positivo. La fine dell’ipocrisia globalista non può che avere dei vantaggi per un Paese che è abituato a denigrare sé stesso, ma che ha un patrimonio unico di capacità e di intelligenze, incluse quelle che servono per gestire in modo razionale i rapporti bilaterali su cui si articolerà il nuovo quadro geopolitico. Col permesso di chi continua a volere il male del Paese per causare la caduta del governo, sono e resto convinto che l’Italia può farcela».