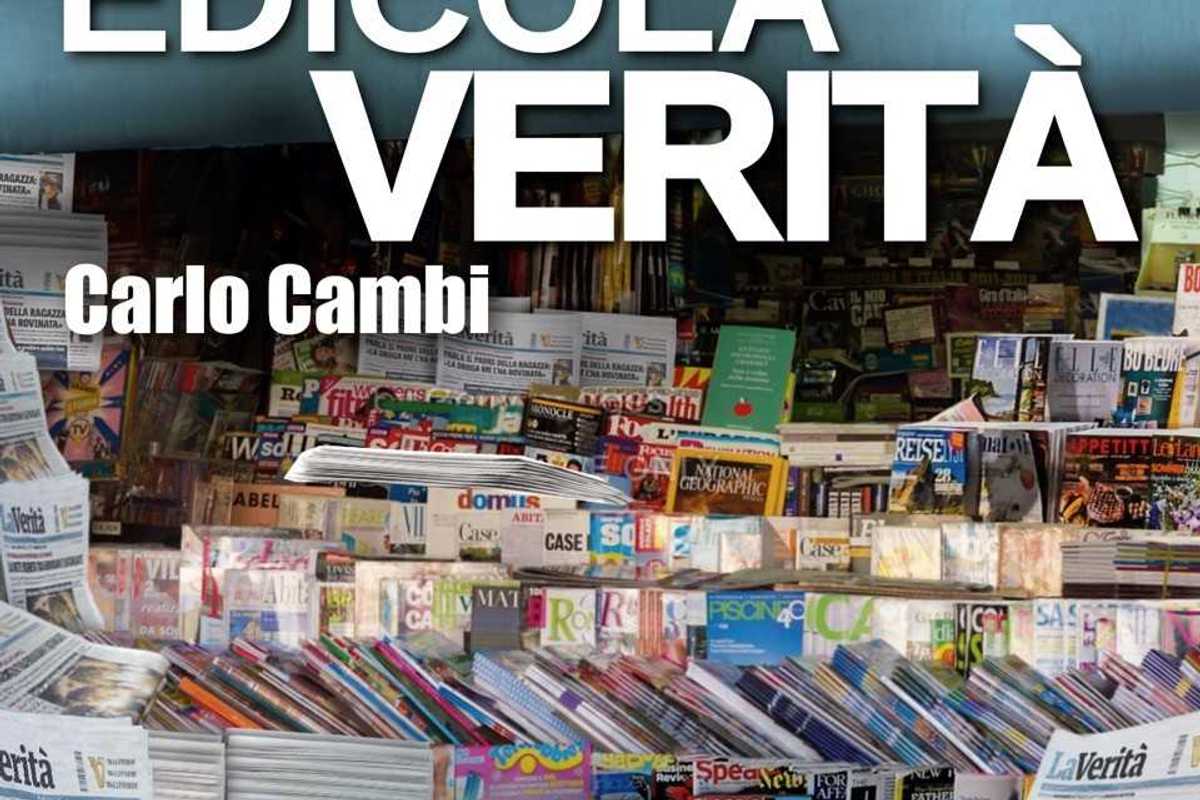«Tramò con Pechino contro Trump». Bufera sul capo di stato maggiore Usa

È uno scenario allarmante quello emerso dalle anticipazioni di Peril: il nuovo libro dei giornalisti, Bob Woodward e Robert Costa. Un libro che, oltre a ricostruire le ultime (tumultuose) settimane dell'amministrazione Trump, getta una luce sinistra sul capo dello stato maggiore congiunto americano, il generale Mark Milley. In base a quanto trapelato, costui avrebbe infatti agito travalicando i propri poteri e aprendo la porta a scenari piuttosto inquietanti.
Secondo il Washington Post, il libro rivela che Milley avrebbe innanzitutto avuto ben due conversazioni segrete con il suo omologo cinese, il generale Li Zuocheng, il 30 ottobre 2020 e l'8 gennaio 2021: due conversazioni con cui il militare avrebbe garantito a Pechino che gli Stati Uniti non avrebbero effettuato un attacco militare ai suoi danni. «Generale Li, voglio assicurarvi che il governo americano è stabile e che tutto andrà bene», dichiarò Milley nella prima telefonata, «Non attaccheremo o condurremo alcuna operazione cinetica contro di voi». «Milley», riporta il Washington Post, «è arrivato al punto di promettere che avrebbe avvisato il suo omologo in caso di attacco statunitense, sottolineando il rapporto che avevano stabilito attraverso un canale segreto». Una conversazione, come si può vedere, abbastanza inquietante. E che delinea l'ipotesi di un reato ben preciso: quello di tradimento. Una fattispecie, questa, che il codice degli Stati Uniti descrive come segue: «Chiunque, dovendo fedeltà agli Stati Uniti, muova guerra contro di loro o aderisca ai loro nemici, dando loro aiuto negli Stati Uniti o altrove, è colpevole di tradimento».
Ma non è tutto. Come riportato dalla Cnn, il libro offre ulteriori dettagli sul comportamento di Milley. A seguito dell'irruzione in Campidoglio del 6 gennaio, il generale convocò una riunione segreta al Pentagono l'8, per avviare una revisione del processo di ricorso alle armi nucleari. In quell'occasione, il capo dello Stato maggiore congiunto intimò agli ufficiali presenti di non eseguire degli ordini, a meno che lui stesso non fosse coinvolto. Non solo: quel medesimo giorno, Milley ebbe una conversazione telefonica con la Speaker della Camera, Nancy Pelosi. «Se non sono riusciti nemmeno a fermare [Donald Trump] da lanciare un assalto al Campidoglio, chissà cos'altro potrebbe fare? E c'è qualcuno in carica alla Casa Bianca che stava facendo qualcosa tranne baciare il suo grosso culo?», chiese la Pelosi al generale, per poi proseguire: «Sai che è pazzo. È pazzo da molto tempo». Al che Milley avrebbe risposto: «Signora Speaker, sono d'accordo con lei su tutto». Cnn riferisce che, dopo quella telefonata, il generale avrebbe esortato all'allerta massima l'allora direttrice della Cia, Gina Haspel, e il direttore della Nsa, Paul Nakasone.
L'invasione di campo è palese. La Costituzione americana stabilisce infatti che «il presidente sarà Comandante in capo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti». Né lo Speaker della Camera né il capo dello Stato maggiore congiunto dispongono pertanto dell'autorità di interferire in tale materia. Tanto più che proprio il capo dello Stato maggiore congiunto è nominato dal presidente, previa ratifica del Senato (non certo della Camera!). Né quindi Nancy Pelosi aveva l'autorità di intervenire sui codici nucleari né Milley di sindacare sulle eventuali scelte di politica estera di Trump. Inoltre il presidente degli Stati Uniti detiene la pienezza dei poteri fino all'insediamento del suo successore: l'attuale capo dello Stato maggiore congiunto invece non solo ha interferito indebitamente nel periodo di transizione, ma addirittura prima delle elezioni presidenziali (una delle due telefonate con Li Zuocheng, lo abbiamo visto, risale al 30 ottobre 2021, con le elezioni che si sarebbero tenute il successivo 3 novembre). Gli stessi autori di Peril affermano che «alcuni potrebbero sostenere che Milley abbia oltrepassato la sua autorità e avocato un potere straordinario a sé». Entrambi tendono tuttavia ad assolverlo, parlando di una «buona fede» volta ad evitare una «guerra accidentale».
Non la pensano però tutti così. Il senatore repubblicano, Marco Rubio, ha chiesto al presidente, Joe Biden, di licenziare Milley. In particolare, Rubio ha sostenuto che il generale «ha lavorato per minare attivamente il comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti in carica e ha contemplato una traditrice fuga di informazioni riservate al Partito comunista cinese». Richieste di dimissioni sono arrivate dall'ex membro del Consiglio per la sicurezza nazionale, Alexander Vindman, secondo cui Milley «ha usurpato l'autorità civile, ha rotto la catena del comando e ha violato il sacrosanto principio del controllo civile sui militari». Ricordiamo, per inciso, che Vindman testimoniò contro Trump durante l'inchiesta per impeachment dell'autunno 2019 e che non può quindi essere tacciato di lealismo verso l'ex inquilino della Casa Bianca, il quale, in un comunicato, ha a sua volta dichiarato che, se quanto trapelato corrispondesse al vero, si profilerebbe un'accusa di «tradimento».
Il precedente aperto dal capo dello Stato maggiore congiunto è effettivamente grave. Inoltre, al di là dei fatti in sé stessi, immaginate soltanto che inferno sarebbe esploso, se il presidente danneggiato in questa vicenda fosse stato un democratico, invece di un repubblicano. Dove sono finiti di grazia quelli che gridano sempre al golpismo?