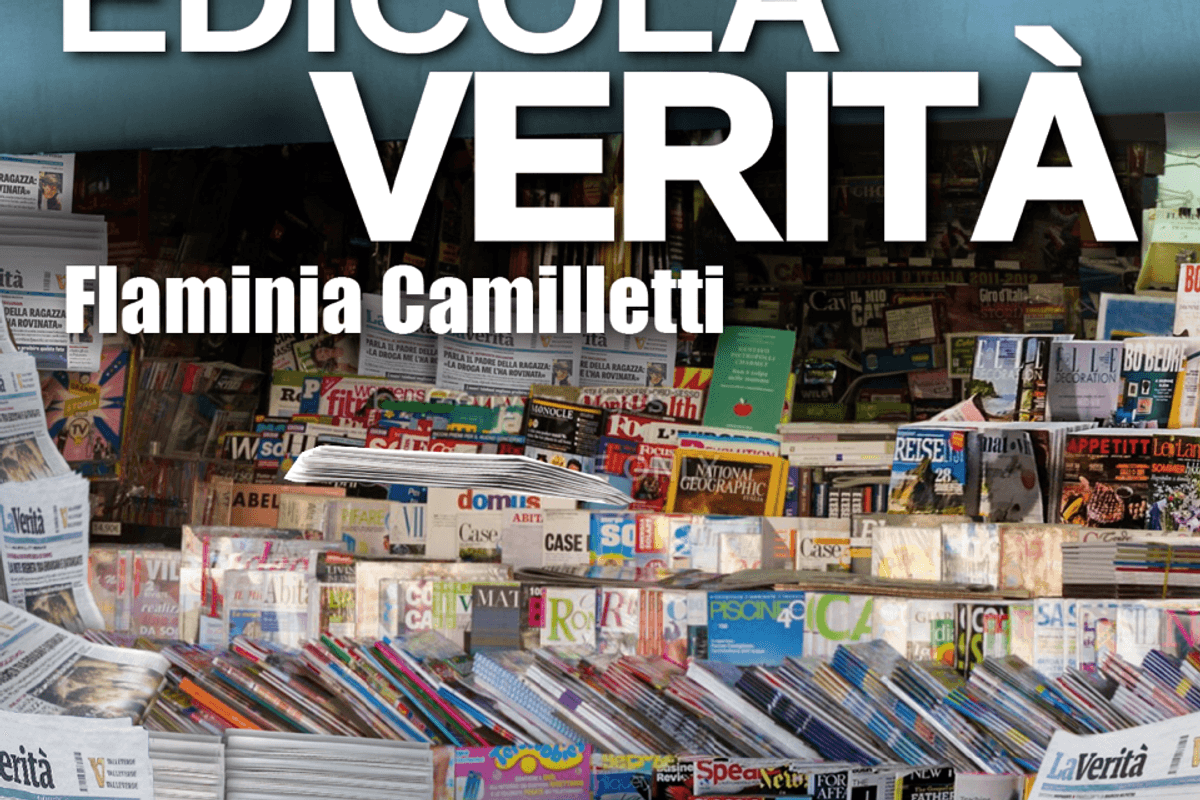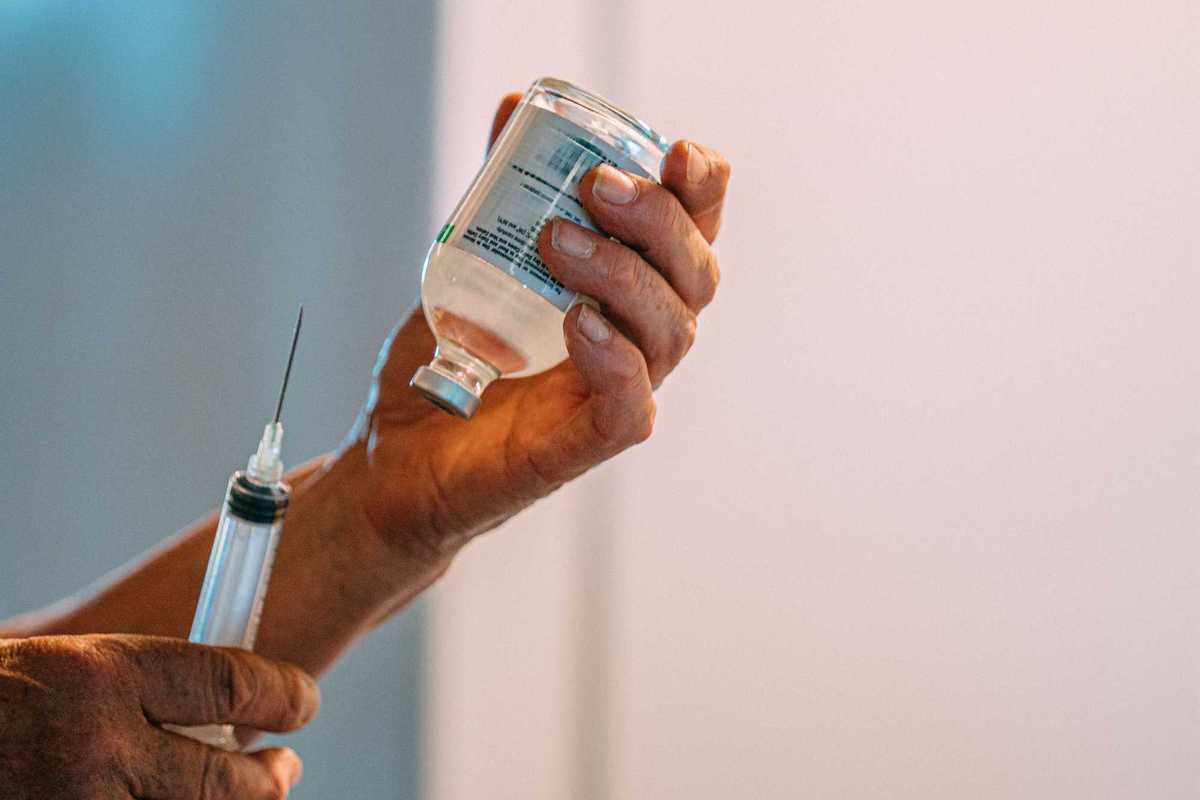True
2020-01-23
La Giornata della memoria squalificata dal vittimismo
Ansa
Coordinatore del Tribunale rabbinico del Centro-Nord Italia
Che la Giornata della memoria sia scappata di mano è un dato di fatto. Si fanno sempre più strada, tra molti ebrei come pure tra tante persone non ebree, sentimenti di disagio, esasperazione e, purtroppo, finanche fastidio. Prima ancora del cattivo uso della memoria della Shoah, vi è un dilagante e ossessivo abuso di tale memoria. Questo abuso si è spesso ubriacato di retorica e di iperboli, più che di sensibilità, studio e riflessione.
Di anno in anno, l'impianto liturgico si è fatto più imponente: una solenne «messa» laica, post cristiana. Alla confessione di peccato corrispondono i crimini d'odio, insidiosamente declinati più in maniera collettiva che afferente alle responsabilità individuali; alle letture bibliche si sostituiscono le testimonianze dei sopravvissuti o pagine dei loro sofferti ricordi; a omelie stantie si avvicendano trite lezioni di morale civile e politica; al crocifisso si sovrappongono gli ebrei, nuovamente figure cristiche e interessanti soltanto in quanto vittime. Ed è così che il ricordo della Shoah sembra essere sottoposto anch'esso a un'ermeneutica non troppo dissimile da quella con cui la patristica strappò le Scritture ebraiche agli ebrei, generalizzandole e universalizzandole per una nuova società e per nuovi scopi, talora rivolgendole proprio contro gli stessi ebrei, quando cioè non ci si poteva agevolmente svincolare dal riferimento concreto e puntuale, particolare e peculiare, all'ebraismo e agli ebrei.
Se la Giornata della memoria è anzitutto, universalmente, il luogo per parlare di ogni forma di discriminazione e persecuzione, ossia l'espressione estrema del razzismo, il problema sarà allora addomesticare e contenere l'antisemitismo nel più generale razzismo. Ed è così che il riferimento agli ebrei insiste unicamente sul loro essere stati vittime, fossilizzandoli a quel ruolo drammatico e passivo, con un totale disinteresse sulle rinascite e sui conseguimenti successivi, personali e comunitari. Sulla vita dopo, nonostante. Non solo: man mano che questo processo di generalizzazione procede, inevitabilmente si moltiplica la tentazione di accostarvi ogni altra tragedia e violenza umana, sì che il riferimento storico specifico all'antisemitismo e agli ebrei o viene ridimensionato e sbiadito, oppure infastidisce, perché sembra tradire l'afflato universalizzante.
È doveroso rivendicare la portata universale di Auschwitz, con i suoi moniti all'intero genere umano. Per farlo è però, al contempo, imprescindibile precondizione e criterio regolatore comprenderne la primaria e specifica portata per gli ebrei e in relazione agli ebrei. I progressisti, molti in assoluta buona fede e con nobili intenti, taluni invece con sofisticata cattiva coscienza, hanno cercato di svellere questo nesso, che, se perduto, tradisce l'intera memoria della Shoah, falsificandola. Ed è esattamente così che è stato possibile usare tale preziosa memoria, appropriandosene alcuni, per delegittimare culturalmente e politicamente altri. Questa è, a tutti gli effetti, una profanazione.
I «liturgisti» della memoria, comunque, nonostante il carattere «ecumenico» di molte cerimonie, non sono stati, sin dagli inizi, tuttavia così universali e inclusivi come vorrebbero apparire. Dove sono e dove sono state, infatti, le testimonianze presso le massime istituzioni della Repubblica dei Testimoni di Geova o degli omosessuali, vittime anch'essi?
Chiaramente c'è un certo imbarazzo… colpevole a mio avviso. Quando verranno sdoganate anche queste testimonianze, la colpevolezza si trasformerà in semplice ipocrisia. Ciò sottolineato, è indubbio che vi sia una distanza, da riconoscersi, tra la Shoah patita dagli ebrei, e le tremende persecuzioni di cui soffrirono, nell'imperversare della stessa barbarie nazifascista, altre comunità umane. Certamente, una riflessione attenta, onesta e puntuale sull'antisemitismo, come pure sul pregiudizio delegittimante e omicida contro gli omosessuali, romperebbe l'idea che tutto ciò sia facilmente riducibile a declinazioni diverse di un più ampio razzismo, dato che si tratta, occorre ripeterlo ancora una volta, di mali specifici, con origini, attitudini e declinazioni tra loro anche irriducibili.
Da anni mi tormenta un interrogativo: perché gli occidentali non hanno riconosciuto anche al genocidio armeno (patito pure da 800.000 cristiani assiri e da 400.000 greci del Ponto) questa cesura drammatica della Storia, tremendamente reale e con un enorme portato simbolico?
Perché abbiamo teologie della Shoah -persino da parte cristiana- e nulla o quasi sul genocidio armeno? Perché la filosofia non se ne curò (e in ampia misura ancora non se ne cura), nonostante il pensiero politico, filosofico e teologico tedesco ben sapesse cosa stesse accadendo agli armeni e talora lo giustificasse, essendo peraltro i tedeschi i principali complici dei turchi nell'opera genocidaria? Perché non contrastare con ogni mezzo politico ed economico un negazionismo di Stato, perpetrato durante e dopo (sino a oggi) l'opera genocidaria contro gli armeni, a fronte di un Paese che arretra di ora in ora rispetto al riconoscimento di diritti minimi irrinunciabili, quali quello di espressione e di stampa?
Dopotutto, le deportazioni moderne di massa non sono state certo inventate dai nazisti con la Shoah. Le nazioni europee (Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Olanda) si sono con successo peritate nel deportare con industriale efficacia dall'Africa almeno una dozzina di milioni di esseri umani, con spesso ampia complicità delle potenze musulmane: c'era là uno scopo economico. L'Inquisizione portoghese deportò via nave, per processarli e condannarli scenograficamente a Lisbona, decine di migliaia di marrani, criptoebrei e giudaizzanti da Rio de Janeiro e dal Brasile: fu totalmente antieconomico, ma vi era un fine dimostrativo e autocelebrativo.
Le deportazioni in massa degli armeni e degli ebrei, invece, dovevano occultare (negazionismo intragenocidario) l'opera genocidaria ed eliminare, per la sola colpa di essere nati, ebrei e armeni, anche se questo significava distruggere la società ottomana o quelle europee e impoverirle, persino quando questo risultò totalmente antieconomico, con i rispettivi regimi allo strenuo. E, ancora, dopotutto, anche gli armeni, il più antico popolo cristiano, morto martire e non apostata, possono essere intesi da alcuni come una figura cristica. Infine, la parola «genocidio», subito giustamente applicata alla Shoah, fu coniata da un pensatore e giurista ebreo, Raphael Lemkin, che la inventò pensando agli armeni.
Molti rispondono che quel che è successo agli ebrei è successo qui da noi, ecco perché. Ammesso (e non concesso) che questa risposta sia valida, si impone un'obiezione: perché mai, allora, andare sempre e in primo luogo ad Auschwitz, disertando istituzioni e scuole i principali luoghi della memoria italiana, confinando all'alterità oltreconfine la barbarie nazista? È raro che vi siano circuiti e treni della memoria, con un itinerario tutto italiano, che partano dai ghetti romano, veneziano o anconetano (i primi della Storia, proprio alla radice di questa drammatica storia) e che poi transitino per le Fosse Ardeatine e per Fossoli, per Borgo S. Dalmazzo, il Memoriale della Shoah di Milano, il Meis di Ferrara, il campo di Bolzano e la Risiera di S. Sabba, con il suo crematorio italiano. È più facile esorcizzare gran parte del male Oltralpe, e rende possibili narrazioni nazionali più confortanti. Ed è così che si può cercare di ridimensionare il tradimento atroce patito dagli ebrei italiani, tra i più entusiasti e fedeli fautori dell'Unità d'Italia, durante gli anni del nazifascismo. Così come è più facile tacere sui tradimenti successivi, inflitti ai superstiti: dalle odiose parole di Benedetto Croce alla trasformazione oscena e ignobile di un pur grande giurista, Gaetano Azzariti, da presidente del famigerato Tribunale della Razza a Presidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana, in quota comunista, con silenzi decennali.
La Giornata della memoria dovrebbe educarci al silenzio, all'interrogativo angoscioso e all'assunzione drammatica ed esigente della complessità dell'umano e delle sue tenebre intrinseche, e non agli slogan facili, come il pur doveroso e auspicabile «mai più».
La polemica su via Almirante è una scusa per oscurare l’antisemitismo della sinistra
«Non si può fare storia demonizzando certi nomi anziché riferendosi alle situazioni reali». Queste parole pronunciate da Renzo De Felice (e contenute nel terzo volume dei suoi Scritti giornalistici editi da Luni), tornano in mente mentre si assiste alla polemica sulla via dedicata a Giorgio Almirante dal Comune di Verona. Secondo Liliana Segre, l'intitolazione di una strada al fu leader missino sarebbe incompatibile con la sua cittadinanza onoraria. Il pensiero della senatrice a vita - sopravvissuta all'Olocausto - è comprensibile, e non sta certo a noi discuterlo. Decisamente meno giustificata, invece, è la posizione di vari esponenti della sinistra, a partire da quelli veronesi per arrivare ai nomi di rilievo nazionale (Alessia Rotta, Massimo Cacciari e altri).
Il punto è che la baruffa su Almirante oscura un pezzo di storia. Per l'ennesima volta, si tenta di presentare l'antisemitismo come un tratto distintivo della destra italiana e si stende una coltre di oblio sull'odio di stampo progressista. Il capo missino, come ha ricordato sulla Stampa Mattia Feltri, condannò con decisione ogni forma di anti ebraismo, oltre ad avere aiutato una famiglia ebrea a scampare alle persecuzioni. Più in generale, la destra italiana - anche perché è spesso stata costretta a farlo - ha affrontato il proprio passato, lo ha elaborato e ne ha tratto insegnamenti preziosi. Lo stesso, purtroppo, non si può dire del fronte progressista. Il quale, ancora oggi, continua a nascondere e proteggere la propria componente antisemita e ostinatamente rifiuta di fare i conti con la realtà.
A portare un po' di chiarezza sull'argomento sono due volumi che meriterebbero una vasta eco, e che dovrebbero essere lungamente discussi non soltanto a livello accademico. Il primo è La sinistra italiana e gli ebrei di Alessandra Tarquini, appena pubblicato dal Mulino. Il secondo è «Ben venga la propaganda», di Claudio Siniscalchi (Studium). Partiamo da quest'ultimo. Storico del cinema, Siniscalchi esamina il film Süss, l'ebreo (Jud Süss, 1940) di Veit Harlan e la ricezione che ha avuto nel nostro Paese. Stiamo parlando di una delle più famose pellicole di propaganda realizzate dal regime nazionalsocialista: l'ebreo Süss si presenta in un paesino tedesco a cerca, con fare mellifluo, di portare corruzione e decadenza fra gli ariani. La carica antisemita, come si può immaginare, è ai massimi livelli.
Il film fu accolto come un capolavoro nel nostro Paese, e tra i più entusiasti recensori ci furono alcuni personaggi oggi piuttosto noti. Dopo la prima bolognese del 1941, per esempio, sul settimanale L'Assalto comparve un articolo elogiativo firmato da un giovane critico cinematografico di nome Enzo Biagi. Sì, proprio lui, una delle colonne del giornalismo italiano. Sentite che scriveva di Süss, l'ebreo: «Poiché l'opera è umana e razionale incontra l'approvazione e raggiunge lo scopo: molta gente apprende che cosa è l'ebraismo, e ne capisce i moventi della battaglia che lo combatte, perché li trova illustrati con una efficacia che né il libro, il giornale o il teatro potrebbero avere». Niente male: Biagi sosteneva che si potesse comprendere perfettamente l'ebraismo tramite un film di propaganda antiebraica nazista. Che dite, cancelliamo dallo stradario le vie dedicate al celeberrimo cronista, divenuto negli ultimi anni di vita un eroe della sinistra antiberlusconiana?
Ancora meglio di Biagi, però, fece un altro mito progressista, il futuro regista Michelangelo Antonioni, che sul Corriere Padano diede libero sfogo all'entusiasmo per la pellicola di Harlan: «Non esitiamo a dire che se questa è propaganda, ben venga la propaganda», scrisse. «Poiché il film è potente, incisivo, efficacissimo. [...] Stonature non ce ne sono, tutto procede con una coerenza lucidissima, con un ritmo incalzante, con una precisione matematica, che vuol dire intelligente. E di intelligenza in L'ebreo Süss ce n'è molta, molta. Vedrete l'episodio di Süss che violenta la fanciulla: è condotto con una abilità sorprendente». Un film bellissimo, intelligente perfino. Di nuovo: facciamo piazza pulita delle strade intitolate ad Antonioni? Ovviamente abbiamo citato soltanto due casi che, per quanto sorprendenti, risultano minori all'interno della vastissima storia dell'odio rosso contro gli ebrei.
Del resto, come nota Alessandra Tarquini, «l'antisemitismo moderno nacque nella cultura politica della sinistra e non in quella della destra». Gran parte dei socialisti e dei comunisti, quand'anche non facevano proprio gli stereotipi razzisti mutuati dall'anti ebraismo «biologico», ritenevano che l'unico modo per risolvere la «questione ebraica» fosse quello di cancellare l'identità degli ebrei, assimilandoli fino a che smettessero di esistere come corpo estraneo.
Il volume della Tarquini smonta un luogo comune, e cioè che l'antisemitismo di sinistra sia legato al dibattito su Israele e Palestina. In realtà non poche personalità progressiste, nel corso dei decenni, hanno dato prova di odio verso gli ebrei in quanto tali. Poi, certo, la nascita dello Stato ebraico ha esacerbato gli animi. Persino Enrico Berlinguer, nel 1967, criticava l'atteggiamento degli arabi verso Israele poiché «puntare sulla distruzione significa puntare su una prospettiva irrealizzabile» (e se fosse stata realizzabile?). Di esempi potremmo farne a centinaia: dai ruggiti di Alberto Asor Rosa fino ai grugniti di Chef Rubio, per tacere del filo islamismo di sinistra (ben descritto da Giulio Meotti in L'Europa senza ebrei, Lindau). Ma questo pezzo di storia non si racconta mai. Perché ai cari progressisti non interessa davvero combattere l'odio: a loro importa sfruttarlo per accusare di nazismo chiunque non la pensi come loro.
Continua a leggereRiduci
È diventata una «messa laica» contro il razzismo: così si oscura il riferimento agli ebrei. E intanto si dimentica il genocidio armeno.L'astio verso il popolo d'Israele non è affatto «di destra». I progressisti alimentano l'ennesimo scontro sul leader missino per lavarsi una coscienza tutt'altro che pulita.Lo speciale contiene due articoliCoordinatore del Tribunale rabbinico del Centro-Nord ItaliaChe la Giornata della memoria sia scappata di mano è un dato di fatto. Si fanno sempre più strada, tra molti ebrei come pure tra tante persone non ebree, sentimenti di disagio, esasperazione e, purtroppo, finanche fastidio. Prima ancora del cattivo uso della memoria della Shoah, vi è un dilagante e ossessivo abuso di tale memoria. Questo abuso si è spesso ubriacato di retorica e di iperboli, più che di sensibilità, studio e riflessione.Di anno in anno, l'impianto liturgico si è fatto più imponente: una solenne «messa» laica, post cristiana. Alla confessione di peccato corrispondono i crimini d'odio, insidiosamente declinati più in maniera collettiva che afferente alle responsabilità individuali; alle letture bibliche si sostituiscono le testimonianze dei sopravvissuti o pagine dei loro sofferti ricordi; a omelie stantie si avvicendano trite lezioni di morale civile e politica; al crocifisso si sovrappongono gli ebrei, nuovamente figure cristiche e interessanti soltanto in quanto vittime. Ed è così che il ricordo della Shoah sembra essere sottoposto anch'esso a un'ermeneutica non troppo dissimile da quella con cui la patristica strappò le Scritture ebraiche agli ebrei, generalizzandole e universalizzandole per una nuova società e per nuovi scopi, talora rivolgendole proprio contro gli stessi ebrei, quando cioè non ci si poteva agevolmente svincolare dal riferimento concreto e puntuale, particolare e peculiare, all'ebraismo e agli ebrei.Se la Giornata della memoria è anzitutto, universalmente, il luogo per parlare di ogni forma di discriminazione e persecuzione, ossia l'espressione estrema del razzismo, il problema sarà allora addomesticare e contenere l'antisemitismo nel più generale razzismo. Ed è così che il riferimento agli ebrei insiste unicamente sul loro essere stati vittime, fossilizzandoli a quel ruolo drammatico e passivo, con un totale disinteresse sulle rinascite e sui conseguimenti successivi, personali e comunitari. Sulla vita dopo, nonostante. Non solo: man mano che questo processo di generalizzazione procede, inevitabilmente si moltiplica la tentazione di accostarvi ogni altra tragedia e violenza umana, sì che il riferimento storico specifico all'antisemitismo e agli ebrei o viene ridimensionato e sbiadito, oppure infastidisce, perché sembra tradire l'afflato universalizzante.È doveroso rivendicare la portata universale di Auschwitz, con i suoi moniti all'intero genere umano. Per farlo è però, al contempo, imprescindibile precondizione e criterio regolatore comprenderne la primaria e specifica portata per gli ebrei e in relazione agli ebrei. I progressisti, molti in assoluta buona fede e con nobili intenti, taluni invece con sofisticata cattiva coscienza, hanno cercato di svellere questo nesso, che, se perduto, tradisce l'intera memoria della Shoah, falsificandola. Ed è esattamente così che è stato possibile usare tale preziosa memoria, appropriandosene alcuni, per delegittimare culturalmente e politicamente altri. Questa è, a tutti gli effetti, una profanazione.I «liturgisti» della memoria, comunque, nonostante il carattere «ecumenico» di molte cerimonie, non sono stati, sin dagli inizi, tuttavia così universali e inclusivi come vorrebbero apparire. Dove sono e dove sono state, infatti, le testimonianze presso le massime istituzioni della Repubblica dei Testimoni di Geova o degli omosessuali, vittime anch'essi? Chiaramente c'è un certo imbarazzo… colpevole a mio avviso. Quando verranno sdoganate anche queste testimonianze, la colpevolezza si trasformerà in semplice ipocrisia. Ciò sottolineato, è indubbio che vi sia una distanza, da riconoscersi, tra la Shoah patita dagli ebrei, e le tremende persecuzioni di cui soffrirono, nell'imperversare della stessa barbarie nazifascista, altre comunità umane. Certamente, una riflessione attenta, onesta e puntuale sull'antisemitismo, come pure sul pregiudizio delegittimante e omicida contro gli omosessuali, romperebbe l'idea che tutto ciò sia facilmente riducibile a declinazioni diverse di un più ampio razzismo, dato che si tratta, occorre ripeterlo ancora una volta, di mali specifici, con origini, attitudini e declinazioni tra loro anche irriducibili.Da anni mi tormenta un interrogativo: perché gli occidentali non hanno riconosciuto anche al genocidio armeno (patito pure da 800.000 cristiani assiri e da 400.000 greci del Ponto) questa cesura drammatica della Storia, tremendamente reale e con un enorme portato simbolico? Perché abbiamo teologie della Shoah -persino da parte cristiana- e nulla o quasi sul genocidio armeno? Perché la filosofia non se ne curò (e in ampia misura ancora non se ne cura), nonostante il pensiero politico, filosofico e teologico tedesco ben sapesse cosa stesse accadendo agli armeni e talora lo giustificasse, essendo peraltro i tedeschi i principali complici dei turchi nell'opera genocidaria? Perché non contrastare con ogni mezzo politico ed economico un negazionismo di Stato, perpetrato durante e dopo (sino a oggi) l'opera genocidaria contro gli armeni, a fronte di un Paese che arretra di ora in ora rispetto al riconoscimento di diritti minimi irrinunciabili, quali quello di espressione e di stampa?Dopotutto, le deportazioni moderne di massa non sono state certo inventate dai nazisti con la Shoah. Le nazioni europee (Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Olanda) si sono con successo peritate nel deportare con industriale efficacia dall'Africa almeno una dozzina di milioni di esseri umani, con spesso ampia complicità delle potenze musulmane: c'era là uno scopo economico. L'Inquisizione portoghese deportò via nave, per processarli e condannarli scenograficamente a Lisbona, decine di migliaia di marrani, criptoebrei e giudaizzanti da Rio de Janeiro e dal Brasile: fu totalmente antieconomico, ma vi era un fine dimostrativo e autocelebrativo. Le deportazioni in massa degli armeni e degli ebrei, invece, dovevano occultare (negazionismo intragenocidario) l'opera genocidaria ed eliminare, per la sola colpa di essere nati, ebrei e armeni, anche se questo significava distruggere la società ottomana o quelle europee e impoverirle, persino quando questo risultò totalmente antieconomico, con i rispettivi regimi allo strenuo. E, ancora, dopotutto, anche gli armeni, il più antico popolo cristiano, morto martire e non apostata, possono essere intesi da alcuni come una figura cristica. Infine, la parola «genocidio», subito giustamente applicata alla Shoah, fu coniata da un pensatore e giurista ebreo, Raphael Lemkin, che la inventò pensando agli armeni.Molti rispondono che quel che è successo agli ebrei è successo qui da noi, ecco perché. Ammesso (e non concesso) che questa risposta sia valida, si impone un'obiezione: perché mai, allora, andare sempre e in primo luogo ad Auschwitz, disertando istituzioni e scuole i principali luoghi della memoria italiana, confinando all'alterità oltreconfine la barbarie nazista? È raro che vi siano circuiti e treni della memoria, con un itinerario tutto italiano, che partano dai ghetti romano, veneziano o anconetano (i primi della Storia, proprio alla radice di questa drammatica storia) e che poi transitino per le Fosse Ardeatine e per Fossoli, per Borgo S. Dalmazzo, il Memoriale della Shoah di Milano, il Meis di Ferrara, il campo di Bolzano e la Risiera di S. Sabba, con il suo crematorio italiano. È più facile esorcizzare gran parte del male Oltralpe, e rende possibili narrazioni nazionali più confortanti. Ed è così che si può cercare di ridimensionare il tradimento atroce patito dagli ebrei italiani, tra i più entusiasti e fedeli fautori dell'Unità d'Italia, durante gli anni del nazifascismo. Così come è più facile tacere sui tradimenti successivi, inflitti ai superstiti: dalle odiose parole di Benedetto Croce alla trasformazione oscena e ignobile di un pur grande giurista, Gaetano Azzariti, da presidente del famigerato Tribunale della Razza a Presidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana, in quota comunista, con silenzi decennali.La Giornata della memoria dovrebbe educarci al silenzio, all'interrogativo angoscioso e all'assunzione drammatica ed esigente della complessità dell'umano e delle sue tenebre intrinseche, e non agli slogan facili, come il pur doveroso e auspicabile «mai più».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-giornata-della-memoria-squalificata-dal-vittimismo-2644891391.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-polemica-su-via-almirante-e-una-scusa-per-oscurare-lantisemitismo-della-sinistra" data-post-id="2644891391" data-published-at="1771230072" data-use-pagination="False"> La polemica su via Almirante è una scusa per oscurare l’antisemitismo della sinistra «Non si può fare storia demonizzando certi nomi anziché riferendosi alle situazioni reali». Queste parole pronunciate da Renzo De Felice (e contenute nel terzo volume dei suoi Scritti giornalistici editi da Luni), tornano in mente mentre si assiste alla polemica sulla via dedicata a Giorgio Almirante dal Comune di Verona. Secondo Liliana Segre, l'intitolazione di una strada al fu leader missino sarebbe incompatibile con la sua cittadinanza onoraria. Il pensiero della senatrice a vita - sopravvissuta all'Olocausto - è comprensibile, e non sta certo a noi discuterlo. Decisamente meno giustificata, invece, è la posizione di vari esponenti della sinistra, a partire da quelli veronesi per arrivare ai nomi di rilievo nazionale (Alessia Rotta, Massimo Cacciari e altri). Il punto è che la baruffa su Almirante oscura un pezzo di storia. Per l'ennesima volta, si tenta di presentare l'antisemitismo come un tratto distintivo della destra italiana e si stende una coltre di oblio sull'odio di stampo progressista. Il capo missino, come ha ricordato sulla Stampa Mattia Feltri, condannò con decisione ogni forma di anti ebraismo, oltre ad avere aiutato una famiglia ebrea a scampare alle persecuzioni. Più in generale, la destra italiana - anche perché è spesso stata costretta a farlo - ha affrontato il proprio passato, lo ha elaborato e ne ha tratto insegnamenti preziosi. Lo stesso, purtroppo, non si può dire del fronte progressista. Il quale, ancora oggi, continua a nascondere e proteggere la propria componente antisemita e ostinatamente rifiuta di fare i conti con la realtà. A portare un po' di chiarezza sull'argomento sono due volumi che meriterebbero una vasta eco, e che dovrebbero essere lungamente discussi non soltanto a livello accademico. Il primo è La sinistra italiana e gli ebrei di Alessandra Tarquini, appena pubblicato dal Mulino. Il secondo è «Ben venga la propaganda», di Claudio Siniscalchi (Studium). Partiamo da quest'ultimo. Storico del cinema, Siniscalchi esamina il film Süss, l'ebreo (Jud Süss, 1940) di Veit Harlan e la ricezione che ha avuto nel nostro Paese. Stiamo parlando di una delle più famose pellicole di propaganda realizzate dal regime nazionalsocialista: l'ebreo Süss si presenta in un paesino tedesco a cerca, con fare mellifluo, di portare corruzione e decadenza fra gli ariani. La carica antisemita, come si può immaginare, è ai massimi livelli. Il film fu accolto come un capolavoro nel nostro Paese, e tra i più entusiasti recensori ci furono alcuni personaggi oggi piuttosto noti. Dopo la prima bolognese del 1941, per esempio, sul settimanale L'Assalto comparve un articolo elogiativo firmato da un giovane critico cinematografico di nome Enzo Biagi. Sì, proprio lui, una delle colonne del giornalismo italiano. Sentite che scriveva di Süss, l'ebreo: «Poiché l'opera è umana e razionale incontra l'approvazione e raggiunge lo scopo: molta gente apprende che cosa è l'ebraismo, e ne capisce i moventi della battaglia che lo combatte, perché li trova illustrati con una efficacia che né il libro, il giornale o il teatro potrebbero avere». Niente male: Biagi sosteneva che si potesse comprendere perfettamente l'ebraismo tramite un film di propaganda antiebraica nazista. Che dite, cancelliamo dallo stradario le vie dedicate al celeberrimo cronista, divenuto negli ultimi anni di vita un eroe della sinistra antiberlusconiana? Ancora meglio di Biagi, però, fece un altro mito progressista, il futuro regista Michelangelo Antonioni, che sul Corriere Padano diede libero sfogo all'entusiasmo per la pellicola di Harlan: «Non esitiamo a dire che se questa è propaganda, ben venga la propaganda», scrisse. «Poiché il film è potente, incisivo, efficacissimo. [...] Stonature non ce ne sono, tutto procede con una coerenza lucidissima, con un ritmo incalzante, con una precisione matematica, che vuol dire intelligente. E di intelligenza in L'ebreo Süss ce n'è molta, molta. Vedrete l'episodio di Süss che violenta la fanciulla: è condotto con una abilità sorprendente». Un film bellissimo, intelligente perfino. Di nuovo: facciamo piazza pulita delle strade intitolate ad Antonioni? Ovviamente abbiamo citato soltanto due casi che, per quanto sorprendenti, risultano minori all'interno della vastissima storia dell'odio rosso contro gli ebrei. Del resto, come nota Alessandra Tarquini, «l'antisemitismo moderno nacque nella cultura politica della sinistra e non in quella della destra». Gran parte dei socialisti e dei comunisti, quand'anche non facevano proprio gli stereotipi razzisti mutuati dall'anti ebraismo «biologico», ritenevano che l'unico modo per risolvere la «questione ebraica» fosse quello di cancellare l'identità degli ebrei, assimilandoli fino a che smettessero di esistere come corpo estraneo. Il volume della Tarquini smonta un luogo comune, e cioè che l'antisemitismo di sinistra sia legato al dibattito su Israele e Palestina. In realtà non poche personalità progressiste, nel corso dei decenni, hanno dato prova di odio verso gli ebrei in quanto tali. Poi, certo, la nascita dello Stato ebraico ha esacerbato gli animi. Persino Enrico Berlinguer, nel 1967, criticava l'atteggiamento degli arabi verso Israele poiché «puntare sulla distruzione significa puntare su una prospettiva irrealizzabile» (e se fosse stata realizzabile?). Di esempi potremmo farne a centinaia: dai ruggiti di Alberto Asor Rosa fino ai grugniti di Chef Rubio, per tacere del filo islamismo di sinistra (ben descritto da Giulio Meotti in L'Europa senza ebrei, Lindau). Ma questo pezzo di storia non si racconta mai. Perché ai cari progressisti non interessa davvero combattere l'odio: a loro importa sfruttarlo per accusare di nazismo chiunque non la pensi come loro.
Stefano Ceccanti (Ansa)
Professor Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare Pd, lei è a favore della riforma della giustizia. Il dibattito è ridotto allo scontro tra due tifoserie?
«L’errore è stato fatto in Parlamento, perché il clima sbagliato è nato lì, da parte di tutti. Tanto più che, essendo questa riforma la conseguenza logica di quella dell’articolo 111 della Costituzione fatta insieme nel 1999, si sarebbe potuti arrivare tranquillamente a un voto di due terzi, senza referendum».
I giudici in Italia sono neutrali, come impone la Costituzione?
«Il cambiamento col nuovo processo accusatorio e poi col nuovo articolo 111 è radicale, di modello. Non si cambia un modello radicato solo con un nuovo codice perché le persone possono continuare inerzialmente come prima. Per questo i parlamentari, rispetto a tante resistenze, vollero il giusto processo anche in norma costituzionale. Riprendiamo il nuovo 111: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.” La Costituzione, e non più solo il codice, lo impone dal 1999: purtroppo allora, a causa delle polemiche tra i pm di Milano e Berlusconi, non si fece subito il passaggio ulteriore sul Csm».
Il punto principale è il doppio Csm. Ma in tanti sostengono che le carriere dei magistrati siano già «separate».
«Certo che il punto centrale è lo sdoppiamento del Csm, perché separare le carriere non vuol dire tanto impedire i salti dall’una all’altra, ma non avere più un organo di governo del sistema dove siede una sola delle due parti e il giudice terzo. Quest’ultimo deve essere equidistante, e quindi non può stare in un organo con una sola delle due parti».
Tra giudici e pm esiste «contiguità»?
«Sì: nelle fasi preliminari i giudici che intervengono (i gip e i gup) sentono la pressione dei media giustizialisti, dall’altro lato ancora temono i possibili riflessi negativi sulle proprie carriere da parte del Csm unico, dove siedono anche i pm. Così, nel 95-100% dei casi, finiscono col dare lassenso alle richieste dei pm, con grave danno per i cittadini. Molti rinvii a giudizio di cause che dovrebbero fermarsi subito, sono il frutto di questa commistione. È vero che alla fine le assoluzioni superano il 40%, ma intanto il processo lo subisci».
L’altro tema è quello delle sanzioni per gli errori giudiziari. L’Alta Corte sarà la soluzione?
«È dal 1991 che la Commissione Paladin propose di superare il doppio ruolo del Csm, per un verso di alta amministrazione e per un altro di giurisdizione, creando un organo ad hoc. È una riforma che da allora è stata largamente condivisa. Stava nel programma Pd delle politiche 2022. La cosa importante, per non essere un organo punitivo, è che i magistrati abbiamo una maggioranza, che qui è di tre quinti».
Lo strumento del sorteggio non minerà la credibilità dei due Csm?
«Credo che sarebbero stati preferibili i collegi uninominali (rifiutati dall’Anm quando furono proposti), ma che il sorteggio, rendendo più liberi i singoli dalle appartenenze, sia comunque un miglioramento. Non spariranno le correnti, utili come luoghi di elaborazione, ma sparirà la loro attuale tendenza a comportarsi come partititi che ne ha fatto il centro decisionale nel Csm a danno dell’autonomia dei singoli magistrati. Accanto all’indipendenza esterna, c’è il problema di tutelare quella interna».
Gli avversari della riforma dicono: la magistratura, se passa il Sì, non sarà più indipendente.
«La riforma rende più liberi i giudici rispetto ai pm, non cambia i rapporti tra giustizia e politica».
Cosa pensa dell’Anm, che si è schierato in blocco per il No?
« Mi preoccupano gli effetti per il dopo referendum. I cittadini si saranno abituati a vedere i magistrati come una parte».
Il procuratore Gratteri sostiene che la riforma sia una «vendetta della politica per Tangentopoli» e che a votare Sì «saranno gli imputati e la massoneria deviata».
«Penso che il vostro quotidiano, che è sempre stato critico nei confronti del presidente Napolitano, dovrebbe fare autocritica almeno su un punto, e cioè sul suo rifiuto di nominare il procuratore Gratteri ministro della Giustizia, quando glielo propose Renzi».
Pensa che il centrosinistra dovrebbe ripensare la sua filosofia sui temi inerenti alla giustizia?
«Penso che dovrebbe cambiare linea sulle questioni istituzionali, esattamente come dovrebbe cambiarla la maggioranza di governo. Nessuno dei due schieramenti sembra capace in questa legislatura di accogliere l’invito del presidente Mattarella: distinguere le materie ordinarie su cui essere alternativi da quelle che toccano le regole del gioco in cui è conveniente per tutti, specie per il Paese, cercare convergenze».
Ci saranno defezioni nel Pd?
«Molte defezioni pubbliche si vedono, da parte di persone che privilegiano il merito della riforma; se ce ne saranno altre nel segreto del voto non sono sicuro, ma penso di sì».
Continua a leggereRiduci
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 febbraio con Flaminia Camilletti
iStock
Discorsi comprensibili, peccato che la pratica metta decisamente in crisi la teoria. Sul referendum, ad esempio, abbiamo raccontato il curioso e inopportuno attivismo di alcuni alti prelati che occupano i vertici della Conferenza episcopale italiana ed esprimono posizioni che mal si conciliano con la divisione dei ruoli richiamata da Avvenire. La sensazione, va detto, è che una parte molto visibile delle gerarchie ecclesiastiche sia pronta a schierarsi politicamente, e con decisione, anche su temi che non chiamano direttamente in causa la dottrina, ma che toccano una certa sensibilità progressista, come nel caso della battaglia per il No. E pure quando ci sono in gioco questioni rilevantissime per la Chiesa, che bussano con forza alla coscienza dei fedeli, quella sensibilità progressista torna a riaffacciarsi, tanto da far pensare che sia proprio quella a regolare la presenza pubblica della Cei.
Un esempio eclatante lo fornisce monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale che non perde occasione per esporsi. Giusto ieri abbiamo ricordato che parteciperà al congresso di Magistratura democratica, fornendo un appoggio fattuale ai sostenitori del No al referendum sulla giustizia. Mesi fa si era schierato con ancora più forza sul referendum riguardante lavoro e cittadinanza, assumendo manco a dirlo una postura affine a quella della sinistra parlamentare. Non pago, ha deciso ieri di prendere parola pure sul fine vita. Argomento, quest’ultimo, su cui la Chiesa ha tutto il diritto e probabilmente anche il dovere di pronunciarsi, ma su cui dovrebbe valutare con grande attenzione le mosse, possibilmente evitando di accordarsi ancora una volta con il fronte sinistrorso. Ancora una volta, però, Savino sceglie una prospettiva di sicuro non ostile ai progressisti. Dichiara che «la legge sul fine vita non è più rimandabile», ben sapendo che non è affatto indispensabile legiferare sul tema e che anzi una nuova legge sarebbe la proverbiale apertura della porta che prelude allo spalancamento. Savino chiede un intervento legislativo basato «su un ampio consenso» fra le parti politiche, e benché insista molto sulla sacrosanta necessità di potenziare le cure palliative e l’assistenza, di fatto apre al suicidio assistito, scelta discutibile visto il ruolo che occupa. «Per evitare le fughe in avanti c’è bisogno di una legge nazionale», dice Savino. «Non per inseguire una circolare regionale ma per assumere una responsabilità che è nazionale. Il fine vita tocca il cuore dei diritti personalissimi, incrocia la coscienza e i profili di diritto penale, responsabilità professionale, livelli essenziali di assistenza e principio di uguaglianza. Il Paese non può permettersi geografie variabili». Si potrebbe obiettare che la geografia variabile viene creata proprio da chi ha cercato in ogni modo di forzare la normativa vigente, provando a scavalcare il Parlamento con ogni mezzo disponibile.
Il vicepresidente della Cei, per altro, legittima l’idea che basti un pronunciamento della Corte costituzionale per creare un diritto, convinzione che è contestabile in assoluto e che stupisce ancora di più se a farla propria è un uomo di Chiesa. Nulla di inedito, per carità, ma almeno ci venga risparmiata la pantomima sulla Chiesa che non deve «entrare in politica». La verità è che ci entra eccome, e fin troppo spesso da sinistra.
Continua a leggereRiduci
Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore.