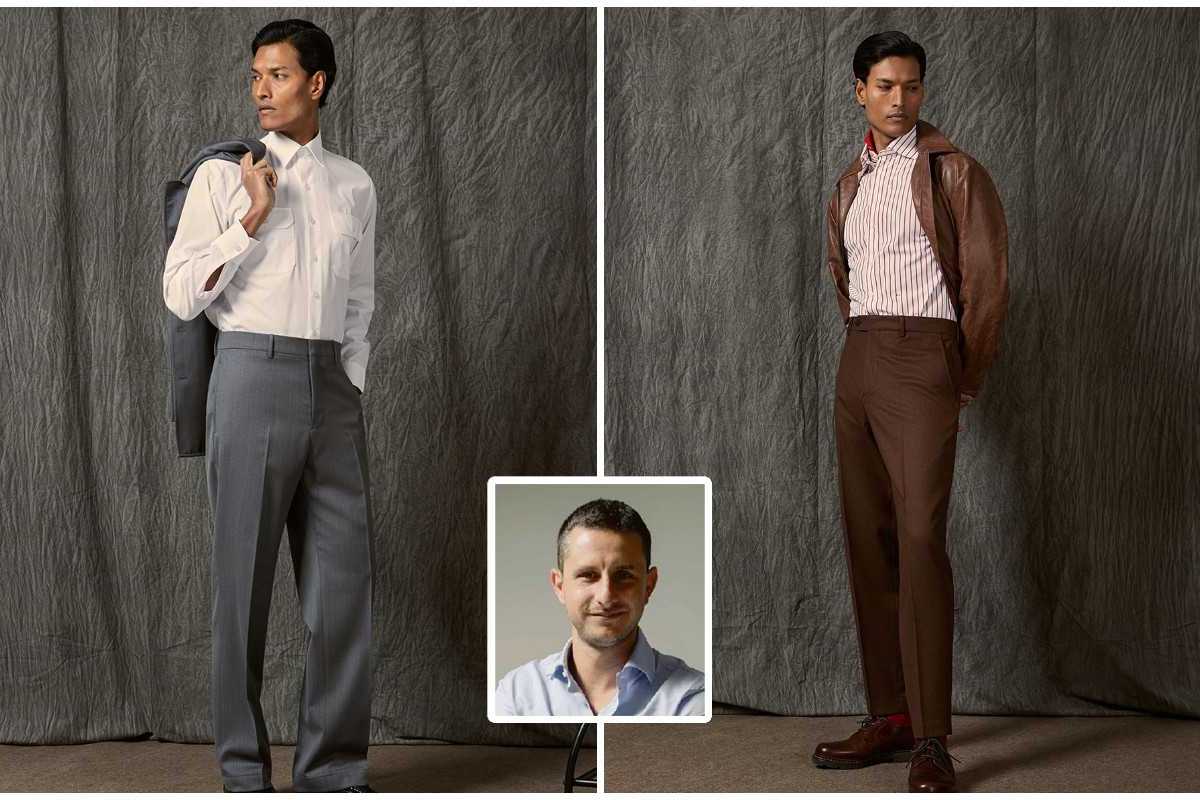La bella contessa che fece l’Italia andando a letto con tutti i potenti

«L'Austria rappresenta per l'imperatore il matrimonio di ragione, l'Italia la passione pericolosa». La battuta, pronunciata dall'ambasciatore austriaco Hübner alla conclusione del congresso di pace di Parigi del 1856, fa in apparenza riferimento all'impegno di Napoleone III per la causa italiana, ma cela un'allusione alla liaison fra l'imperatore e la bellissima Virginia Oldoini, meglio nota come la contessa di Castiglione.
Della contessa si è parlato molto, nella storia: enigmatica e spregiudicata, bellissima e affascinante, continua a intrigare e irritare al tempo stesso. Che sia stata una nobile «avventuriera» di gran classe, che abbia fatto innamorare e sedotto molti uomini potenti, ricchi, famosi, è un fatto incontestabile. Pur tuttavia, anche lei ha giocato un ruolo nelle vicende del nostro Risorgimento. Certo, non un ruolo eroico, né grandioso o generoso. Virginia non ha dato la vita per la patria, non ha preso parte alle spedizioni militari sotto mentite spoglie, non ha finanziato i moti, non ha curato i feriti, non ha neppure tenuto un salotto culturale. Si è limitata a utilizzare la sua venustà - è stata definita «la donna più bella d'Europa» - per raggiungere una serie di scopi.
Si è anche molto divertita, regnando sulla vita mondana di Torino, Firenze, Parigi e anche Londra. Ha avuto ai suoi piedi sovrani come Napoleone III e Vittorio Emanuele II, ministri e diplomatici quali Constantino Nigra, grandi banchieri come Rothschild, nobili quali i fratelli Doria; che ha usato e da cui si è fatta usare. Che nella vita tutto abbia un prezzo e nulla un valore, le è stato subito chiaro. Egocentrica, narcisista, innamorata di sé, ambiziosa, pronta a qualunque menzogna pur di forgiare la propria leggenda... ma anche ammaliante e disposta a impegnarsi per il proprio Paese. Forse, perché desiderosa di interpretare una parte nelle vicende unitarie nazionali.
Non a caso, in una lettera a Luigi Cibrario, ministro degli Esteri, Camillo Benso di Cavour scrive dal congresso di Parigi: «Andiamo in scena, se non piacevole, sarà curiosa. Intanto sono cominciati i pranzi ufficiali, e, se non le intelligenze, i nostri stomaci sono stati messi a dura prova... Vi avverto che ho arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di XXX...»
Virginia nasce a Firenze il 22 marzo 1837: suo padre è il marchese Filippo Oldoini Rapallini, che diventerà deputato al Parlamento del Regno di Sardegna nel 1848; sua madre è la mondana marchesa fiorentina Isabella Lamporecchi, figlia di un'importante giureconsulto e cugina di Cavour. Nessuno dei due presta troppa attenzione alla figlia, che cresce viziata e capricciosa. Elogiatissima dalla prima infanzia per l'avvenenza, ha un gran concetto di sé, un'enorme sicurezza e una naturale capacità di manipolare il sesso forte. Parla francese, inglese e tedesco, che le saranno molto utili. Nella casa fiorentina conosce Massimo d'Azeglio, il cardinale Giacomo Antonelli, il principe Luigi Napoleone figlio minore di Hortense de Beauharnais e di Luigi Bonaparte, il principe Giuseppe Poniatowski. È D'Azeglio a inventare per lei il soprannome di Nicchia.
Dopo svariati flirt, Virginia sposa nel gennaio 1854 Francesco Verasis, conte di Castigliole d'Asti e di Castiglione Tinella, da cui avrà un figlio, Giorgio. Il conte è innamorato cotto della sua bella moglie e si indebita per assecondarne i capricci; lei non lo ricambia, anzi ricomincia con una girandola di corteggiatori Comunque, gli sponsali hanno il vantaggio di introdurla nel ristretto circolo della corte sabauda.
Alta, bionda, occhi fra l'azzurro e il viola, fisico statuario, volto perfetto, Nicchia viene chiamata «la Madonna degli Oldoini», ma anche «la statua di carne». L'unico che non soccombe al suo charme - e verso il quale nutre un timore reverenziale - è Cavour, che aveva scritto al conte Francesco prima del matrimonio: «Quella ragazzetta è ammalata di egocentrismo e di narcisismo».
Il 1855 è l'anno in cui comincia il vero «debutto» politico-mondano di Virginia, per merito dello stesso Cavour, che - pur criticandola - non ne misconosce il fascino. Il politico ha fatto tesoro delle esperienze precedenti, soprattutto del fallimento dei moti mazziniani e dei risultati della prima Guerra d'Indipendenza, ed è deciso a proseguire il cammino verso sull'Unità sui binari diplomatici. Il suo uomo è Napoleone III. Cresciuto in Italia, massone, carbonaro, costui ha partecipato ai moti di Romagna del 1831. Inoltre, è stato ricercato dalla polizia austriaca, è emigrato a Londra e negli Stati Uniti (dove ha percosso con un frustino Hudson Lowe, carceriere di Napoleone a Sant'Elena), quindi è tornato in Francia, è stato arrestato, ha trascorso anni nella fortezza di Ham, è fuggito ed è arrivato a Parigi durante la stagione rivoluzionaria del 1848. Alle elezioni della Seconda repubblica Bonaparte ha ottenuto un grande successo, per diventarne poco dopo il presidente. Il 2 dicembre 1851 si è lanciato nel colpo di Stato e, dopo il referendum dell'anno successivo, ha assunto il nome di Napoleone III, dando inizio al Secondo impero. Quindi, il 30 dicembre 1853, ha sposato la bella spagnola Eugenia de Montijo.
Pur di agganciarlo, Cavour impone al Piemonte di uscire dall'isolamento e partecipare alla Guerra di Crimea. Con una mossa tattica, convince il re e il governo a inviare un contingente in loco, per dare man forte a Francia e Inghilterra contro la Russia. In cambio, strappa la promessa che, in una fase successiva, verrà discussa la questione italiana. La vittoria fa sì che al congresso di Pace, il Piemonte venga invitato e Napoleone III imponga di parlare delle faccende italiche.
Cavour è soddisfatto, ma sa che la strada è ancora lunga e preferisce giocare su più tavoli (ufficiali e ufficiosi). Non a caso, ha spedito Virginia a Parigi, nel 1855. Le ha scritto che deve «charmer politiquement l'Empereur, coqueter avec lui, le seduire s'il le fallait», «affascinare politicamente l'imperatore, flirtare con lui, sedurlo se necessario». Lei si reca nella Ville Lumière - che vive una fase edonista, splendida e festaiola, abbellita com'è dall'opera del barone Haussmann - e trionfa in ogni senso. Pare che l'idillio con Napoleone III sia cominciato durante un soggiorno nella reggia di Compiègne e proseguito per oltre un anno, per poi concludersi abbastanza male, anche per un misterioso attentato di cui verrà fatto oggetto l'imperatore. L'imperatrice Eugenia potrebbe averci messo lo zampino: ha preso in ovvia antipatia la rivale, e cerca di allontanarla.
Nel periodo francese, la contessa agisce come un vero e proprio agente segreto: incontra tutti gli uomini più influenti, manda notizie in Italia, ne riceve delle altre (traffica anche con i Rothschild, speculando e guadagnando), tiene desto l'interesse sulla causa, fa pressioni su Napoleone III. Le cose sembrano andare secondo i piani. La seconda guerra d'Indipendenza vede la Francia scendere in campo a fianco dell'Italia, anche se poi le sue conclusioni non saranno quelle sperate e verrà recuperata la sola Lombardia.
Tornata in Italia, Virginia allaccia una liaison anche con Vittorio Emanuele II, poi rientra in Francia, dove ottiene una grande rivincita. Ma sono gli ultimi fuochi; l'Impero sta per crollare sotto i colpi della Prussia (con singolare intuizione, Nicchia ha detto in anticipo a Nigra che Napoleone III doveva guardarsi da Bismarck) e per la Castiglione si avvicina l'ora del tramonto. Tra il 1856 e il 1895, Virgina fa da modella al fotografo Pierre-Louis Pierson, che la immortala in oltre 450 scatti, nei quali la versatile signora interpreta più di cento personaggi diversi. Un modo per eternizzare la propria beltà.
Gli ultimi anni della contessa trascorrono in solitudine e tristi reminiscenze. Chiusa in un ammezzato di place Vendome, preda dei suoi fantasmi e delle sue fissazioni, non riceve quasi più nessuno, ma conserva vesti sontuose, toilette, gioielli, nonché i suoi diari e le sue carte. Moltissime, però verranno fatte sparire, trafugate o bruciate dopo la sua morte, avvenuta il 28 novembre 1899. Si dice che, per non vedersi invecchiata, avesse velato tutti gli specchi, ma pare sia una leggenda. È giunta sino a noi, invece, la splendida chemise de nuit acqua marina che aveva incantato l'imperatore in una lontana sera a Compiègne e con cui Virginia avrebbe voluto farsi seppellire. Gli eredi, però, non l'hanno accontentata.