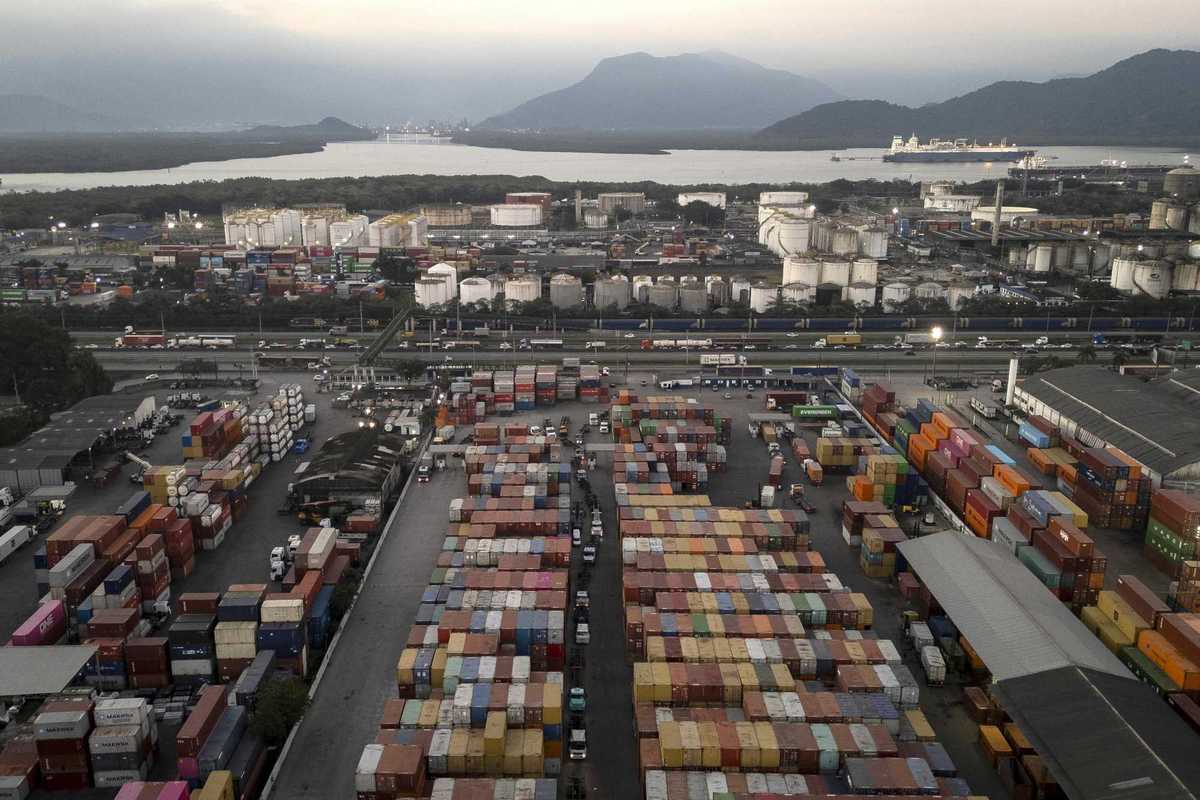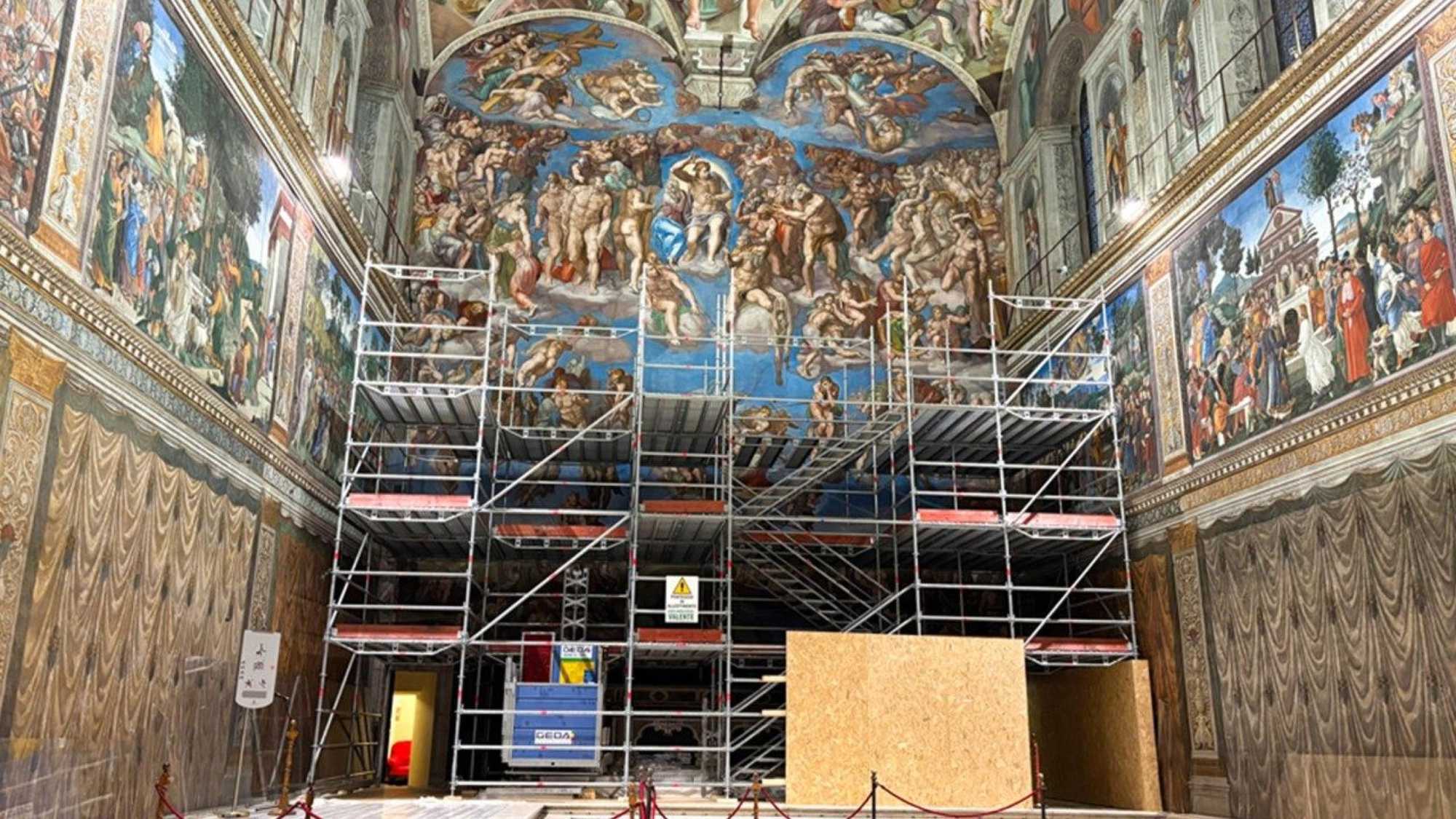Ci volevano i giapponesi per demolire la narrazione molto in voga tra tanti studiosi e che spesso abbiamo sentito risuonare anche in Confindustria, che il problema dell’economia italiana sono le piccole e medie imprese e la mancanza di grandi gruppi imprenditoriali.
Ora invece scopriamo, anzi ce lo dice a chiare lettere un articolo del Nikkei Asia, che proprio il sistema delle pmi ha rappresentato uno scudo efficace ai dazi di Trump consentendo all’export di continuare a crescere anche più di concorrenti temibili e finora imbattibili come il Giappone.
Nell’articolo si sottolinea che l’impatto dirompente dei dazi statunitensi ha aiutato l’Italia a superare il Giappone nelle esportazioni mondiali in termini di valore nella seconda metà del 2025, con l'aumento delle spedizioni di marchi di lusso e prodotti alimentari.
Secondo i dati pubblicati dall’Ocse, l’export del made in Italy ha raggiunto i 376 miliardi di dollari nel periodo luglio-dicembre mentre quello giapponese si è fermato a quota 370 miliardi di dollari. È la prima volta nell’arco di 50 anni, che l’Italia supera il Giappone su base semestrale. Il Nikkei Asia fa notare che l’Italia si è classificata al quinto posto tra i maggiori esportatori mondiali nel periodo considerato, dietro Cina, Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi. Il Giappone è sceso al settimo posto, a ridosso della Corea del Sud. Se si considera l’intero 2025, però le esportazioni giapponesi hanno comunque superato di poco quelle italiane.
Sui mercati valutari globali, il dollaro ha registrato un andamento positivo nei confronti dello yen, ma si è indebolito nei confronti dell’euro. Di conseguenza, le esportazioni giapponesi sono diminuite in dollari, mentre il valore di quelle italiane è aumentato.
Un ruolo importante in questa accelerazione l’hanno avuto le pmi, ovvero la diversificazione dei settori di punta fortemente concorrenziali. Il Giappone che ha sempre puntato molto sull’automotive (rappresenta il 17% del totale), ha risentito di più delle tariffe di Trump, trascinando quindi al ribasso il valore complessivo delle esportazioni. In Italia invece, sebbene ci siano marchi come Ferrari, Lamborghini e Stellantis, l’industria automobilistica rappresenta solo il 3% delle esportazioni che hanno altri settori trainanti con alti standard qualitativi come la farmaceutica, l’alimentare, i mobili e l’abbigliamento.
Il Nikkei Asia ricorda anche che siccome gran parte del made in Italy è destinato ad una clientela benestante, anche se i prezzi aumentano per effetto dei dazi, è poco probabile che la domanda diminuisca. Per l’unicità dei prodotti italiani, la clientela internazionale non bada a spese e non è certo il ritocco dei listini di qualche punto che rappresenta un disincentivo. Ecco alcune conferme: nei tre trimestri fino a settembre, le vendite del marchio di alta moda Prada sono aumentate del 9% su base annua, raggiungendo i 4,07 miliardi di euro (4,8 miliardi di dollari). Le esportazioni di prodotti alimentari italiani, come la pasta, hanno avuto un incremento del 4% su base annua nel periodo gennaio-novembre.
Il Nikkei Asia riconosce il carattere strategico delle piccole e medie imprese, che hanno attutito il colpo dei dazi dell'amministrazione Trump. Il magazine nipponico poi sottolinea che il solido sostegno del governo alle esportazioni delle piccole e medie imprese ha dato i suoi frutti.
Nell’ultimo decennio, le esportazioni italiane sono aumentate del 60%, superando la crescita del 18% del Giappone e del 34% della Germania. Nel passato uno yen più debole ha portato a una migliore competitività dei prezzi per le esportazioni giapponesi e all’espansione della quota di mercato all’estero, ma questa dinamica si è attenuata negli ultimi anni.
La valuta giapponese ora si scambia a circa 156 yen per dollaro, circa la metà del valore di 15 anni fa. Un altro elemento di debolezza è la delocalizzazione della produzione di numerose imprese nipponiche, per cui la debolezza dello yen ha contribuito meno all’incremento delle esportazioni.