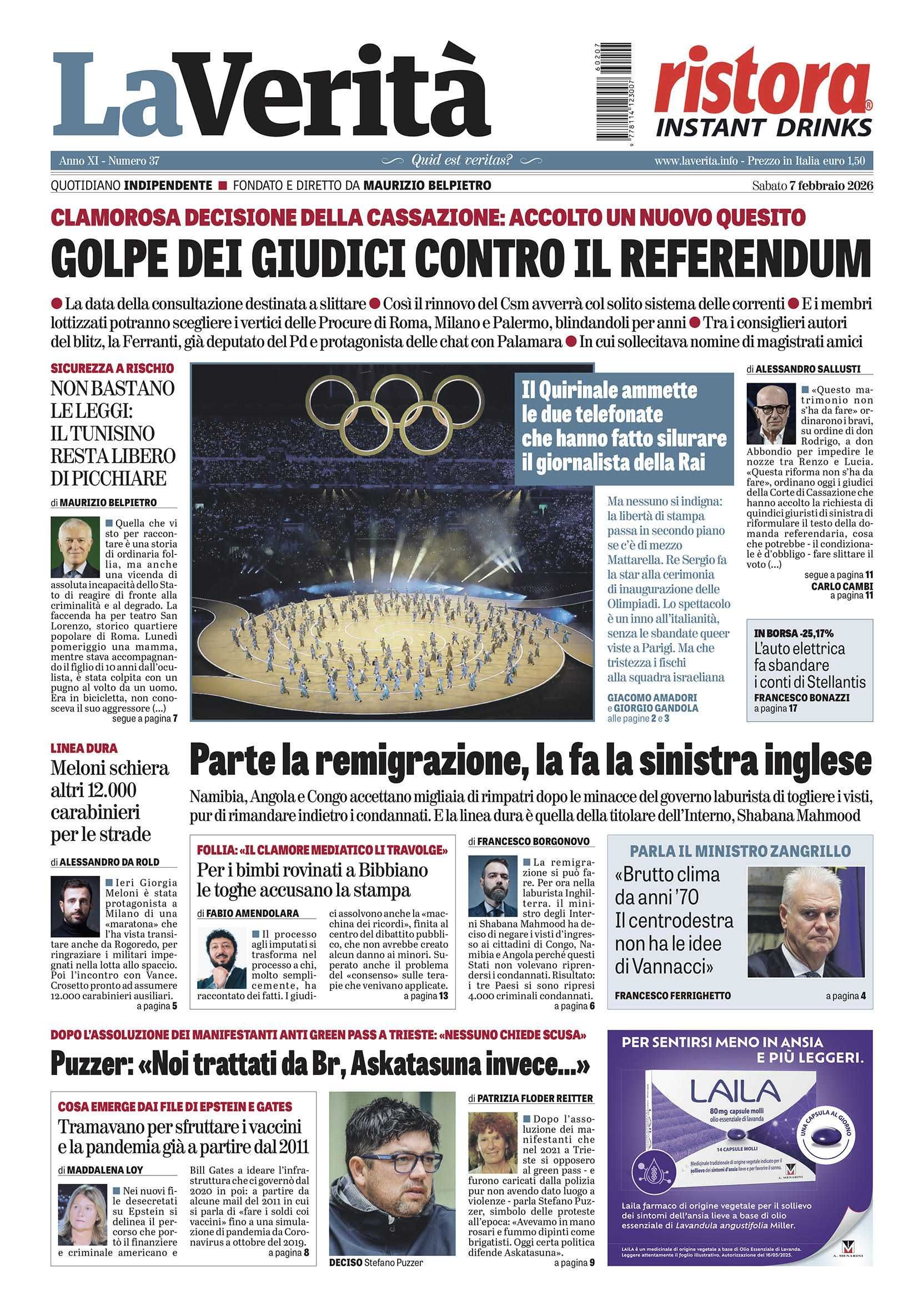Il Brasile di Lula è stretto tra i dazi punitivi di Trump e gli aiuti interessati di Xi
Mentre il Sudamerica abbraccia il libero mercato con le vittorie elettorali di Javier Milei in Argentina, Rodrigo Paz in Bolivia e José Antonio Kast in Cile, tra i grandi Paesi del subcontinente il Brasile resta l’ultimo fortino di una sinistra asfittica. Tra un debito pubblico fuori controllo, un apparato giudiziario sotto sanzioni Usa e il pesante processo all’ex presidente Bolsonaro, l'amministrazione di Luiz Inácio Lula da Silva tenta di sopravvivere agitando lo spauracchio dell’interferenza esterna.
Il panorama politico dell’America Latina sta vivendo un cambiamento generazionale senza precedenti. Il «pendolo» si è spostato drasticamente verso destra: dall’Argentina di Javier Milei, che ha ridotto l’inflazione dal 200% al 30%, alla Bolivia che ha chiuso vent’anni di socialismo, fino al Cile che ha decretato il «più chiaro ripudio della sinistra in quasi un secolo». In questo scenario, il Brasile di Luiz Inácio Lula da Silva appare come una vistosa anomalia ideologica, un’isola rossa che tenta di resistere a un’ondata conservatrice che invoca sicurezza, disciplina fiscale, mercato e sovranità.
Lula, giunto al suo terzo mandato da presidente, ha impostato una politica estera nel segno di un attivismo multilaterale, rafforzando la presenza del Brasile nei Brics e rilanciando i rapporti con Cina e Russia.
Tuttavia, la tenuta di Lula è tutt’altro che solida. All'età di 80 anni, il leader del Partito dei lavoratori (Pt) governa un Paese profondamente polarizzato, dove il consenso è fragile e i segnali di insofferenza crescono. Sebbene Lula guidi ancora i sondaggi per il 2026, la sua popolarità ha subito duri colpi, specialmente dopo aver definito i narcotrafficanti come «vittime» del sistema, una dichiarazione che ha scioccato una popolazione stremata dalla criminalità organizzata.
Il cuore della crisi brasiliana risiede nello scontro frontale tra i poteri dello Stato e l’opposizione bolsonarista. La condanna di Jair Bolsonaro a 27 anni di carcere per un complotto golpista ha spaccato il Paese in due. L’ex presidente è diventato un martire per milioni di brasiliani che vedono nella magistratura, in particolare nel giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, un braccio politico dedito alla persecuzione dell’opposizione.
L’arresto di Bolsonaro, avvenuto dopo che l’ex leader ha ammesso di aver manomesso il suo braccialetto elettronico con un saldatore (con la bizzarra giustificazione di aver avuto allucinazioni causate da farmaci per il singhiozzo) ha ulteriormente radicalizzato le posizioni. Per i suoi sostenitori, si tratta di una caccia alle streghe orchestrata da un regime che usa il diritto come arma. Questa tensione ha paralizzato il dibattito pubblico, spostandolo dai temi economici alla sopravvivenza delle istituzioni democratiche.
In questo clima incendiario, l’amministrazione di Donald Trump ha deciso di intervenire con una forza d’urto che non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda. Washington ha adottato quella che qualcuno, come abbiamo già visto, ha ribattezzato la «Dottrina Donroe», considerando il Sudamerica come il proprio dominio strategico e punendo severamente chi non si allinea.
L’attacco è stato duplice, giudiziario ed economico. Il Dipartimento del Tesoro Usa ha imposto sanzioni al giudice De Moraes e revocato i visti a otto degli undici membri della Corte Suprema brasiliana, accusandoli di gravi violazioni dei diritti umani. Ma il colpo più duro è arrivato sul fronte commerciale, allorquando Trump ha imposto dazi del 50% sulle esportazioni brasiliane, una tariffa punitiva senza precedenti motivata ufficialmente dalla «persecuzione politica» contro Bolsonaro. Nonostante il Brasile non abbia un surplus commerciale con gli Usa, Washington sta usando il commercio come leva esplicita per influenzare la politica interna e favorire un cambio di rotta nel 2026.
Schiacciato dalla pressione americana, Lula ha reagito rispolverando la retorica del nazionalismo populista. Il presidente ha dichiarato che «la democrazia e la sovranità del Brasile non sono negoziabili», cercando di trasformare l’aggressione di Trump in un «regalo» politico per rinsaldare le proprie file. Questa mossa ha effettivamente generato un effetto «rally around the flag» (raccolta attorno alla bandiera, tipica reazione nei momenti di difficoltà di un Paese), portando i sondaggi di gradimento del presidente brasiliano dal 24% al 33% in pochi mesi.
Tuttavia, questo scudo patriottico non può nascondere le difficoltà economiche che gravano sul Paese. Il settore dell’agrobusiness, storicamente vicino a Bolsonaro e vitale per il Pil, prevede perdite per un miliardo di dollari solo nella seconda metà dell’anno a causa dei dazi statunitensi. Anche i settori conservatori, inizialmente favorevoli a Trump, iniziano a vedere con sospetto un’interferenza che danneggia la competitività delle esportazioni nazionali.
Mentre i vicini argentini attuano cure da cavallo libertarie, il Brasile resta profondamente statalista. Il debito pubblico è previsto all’81,8% del Pil per il 2026, ma gli investitori temono che supererà l’83,8%. Il bilancio approvato per l’anno elettorale è un colabrodo di eccezioni: miliardi destinati alle poste statali, ai militari e ai sussidi sociali che trasformano il surplus primario promesso in un deficit reale. La spesa obbligatoria per pensioni e sussidi cresce al 10% annuo, ben oltre i limiti legali che il governo stesso si era imposto.
Per compensare l’ostilità di Washington, Lula sta accelerando l’allineamento con la Cina. Pur non avendo formalmente aderito alla Nuova Via della Seta cinese, per il Brasile Pechino è già il primo partner commerciale e sta occupando ogni spazio strategico, dai minerali critici (il Brasile ha le seconde riserve mondiali di terre rare) alla costruzione di una ferrovia transcontinentale per collegare l’Atlantico al Pacifico. Il Brasile punta sull’alleanza Brics per ridurre la dipendenza dal dollaro, ma rischia di scambiare una dipendenza con un’altra, diventando un satellite economico di Pechino in cambio di ossigeno finanziario immediato.
Mentre il ministro delle Finanze Fernando Haddad annuncia le dimissioni per preparare la campagna elettorale a sostegno di Lula, il centrodestra brasiliano cerca un erede credibile dopo Bolsonaro. Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, è visto dal mondo finanziario come l’unica alternativa pragmatica capace di battere Lula. Tuttavia, il clan Bolsonaro oppone resistenza, con il senatore Flávio Bolsonaro che rivendica per sé il testimone del padre. Il giovane candidato si presenta come un «Bolsonaro moderato e vaccinato» (sic) per attirare i moderati. La spaccatura interna alla destra può essere l’unica vera ancora di salvezza per l’anziano Lula nelle elezioni che si terranno nell’ottobre 2026, tra meno di un anno. A quella data Lula avrà 81 anni, e chissà che da qui ad allora, per evitare un effetto Biden, il suo partito non decida di proporre un candidato alternativo, più giovane, in grado di dare maggiore slancio futuro. Al momento però tale candidato non si vede.
Il Brasile, dunque, si trova a un bivio carico di significati. Schiacciato tra un’amministrazione Trump che non fa sconti e una Cina che attende di incassare i suoi crediti, il Paese rischia di implodere sotto il peso del proprio debito e della polarizzazione sociale. Il governo Lula sta cercando di sopravvivere trasformando ogni dazio americano in una medaglia al valore nazionale, ma i fondamentali economici non mentono.