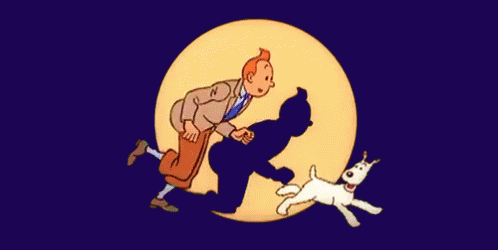Dieci gennaio 1929: su Le petit Vingtième, supplemento settimanale per ragazzi del quotidiano belga cattolico-conservatore Le Vingtième Siècle, appare per la prima volta un fumetto destinato ad avere un enorme successo: Tintin. Tra i personaggi del mondo dei fumetti, Tintin, uscito novant'anni fa dalla matita geniale del disegnatore belga Georges Prosper Remi, in arte Hergé , è indubbiamente uno dei più solari e simpatici. Coraggioso, leale, sorridente, magari a volte buffo, a volte fragile, fallibile. Umano, molto umano. Un umano però sempre limpido, integerrimo moralmente, privo di ambiguità o lati oscuri.
Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di avventure in ogni parte del globo insieme all'inseparabile cagnolino Milù. A partire dal 9° albo della serie, Il granchio d'oro, è affiancato dal collerico capitano Haddock, e a partire dal 12° albo, Il tesoro di Rackam il Rosso, dallo scienziato Trifone Girasole. Di Tintin non si conosce nulla, né la famiglia, né l'età, né la nazionalità, anche se non è difficile intuire che sia belga (presumibilmente vallone) e molto giovane. Tintin non è sposato, né ha fidanzate, né sembra essere coinvolto in vicende affettive. Per molti versi questa sorta di «asessualità» lo avvicina a un celebre personaggio della letteratura fantasy, l'hobbit Frodo Baggins, che critici malevoli dell'opera di J.R.R. Tolkien attaccarono in quanto «ignaro del sesso». Sarà, ma Frodo, così come Tintin, sono personaggi niente affatto ignari di altri fondamentali aspetti della vita: sono saggi, coraggiosi, intelligenti, determinati, e sono capaci di affrontare le prove più ardue senza tirarsi indietro.
A differenza di Frodo, Tintin è un eroe contemporaneo: vive nel suo tempo, con una professione — il giornalista — che lo coinvolge direttamente nelle vicende del suo tempo. Percorrendo le storie di Tintin si ottiene una panoramica della realtà del secolo scorso: la prima delle sue avventure lo vede nell'Unione Sovietica del 1929, quindi successivamente passerà in Germania, nella repubblica di Weimar, per poi recarsi nel 1930 in Congo, allora colonia belga. L'anno dopo lo ritroviamo in America, in difesa dei nativi americani. Le sue avventure lo porteranno in seguito in tutti i continenti, in Cina come in Tibet, in Egitto come in Australia, per tornare nella vecchia Europa, e nell'albo del 1937 L'isola nera, uno sicuramente dei più belli, arrivare in Scozia, dove sostituisce i celebri pantaloni alla zuava (o da golf) con il kilt. Nella geografia di Tintin troviamo anche uno Stato immaginario, che compare in un'avventura del 1940, mentre era scoppiata la seconda guerra mondiale. Si trattava della Syldavia, una piccola monarchia collocata in modo abbastanza riconoscibile nell'area mitteleuropea, probabilmente balcanica. Tintin prende le parti della monarchia e della sua libertà. In questa, come in tutte le sue avventure, Tintin appare un autentico paladino della giustizia, della libertà, e i personaggi cattivi di turno con cui il giovane reporter si deve confrontare sono in genere spie, falsari, trafficanti di droga e schiavisti. Se ufficialmente la sua professione è quella del giornalista, e ciò rappresenta spesso il punto di partenza delle avventure, di fatto il ruolo che Tintin assume nelle storie è invariabilmente quello di chi deve affrontare delle situazioni di male e di ingiustizia.
Tintin è un eroe, e la sua missione, la sua stessa ragion d'essere, è combattere il male, riportare ordine nel caos, restaurare una giustizia violata, soccorrere, difendere, rialzare coloro che hanno subito torti. Un eroe solare, dicevamo, a tutto tondo, descritto anche con una grafica adeguata. Il tratto pulito, inconfondibile di Hergé è quello di uno stile grafico chiamato «linea chiara», uno stile ispirato al movimento Liberty di inizio Novecento e agli autori giapponesi di inizio Novecento. Un disegno luminoso, privo di sfumature, di chiaro-scuri e di tratteggi, con figure dai contorni netti e precisi. Un'ulteriore ispirazione a Hergé era giunta dall'America, da un autore di nome George McManus, figlio di emigranti irlandesi, che proprio ispirandosi ai personaggi venuti in America dall'isola di Smeraldo aveva creato le prime strisce di fumetto con il protagonista Jigs e sua moglie Maggie, che in Italia diventarono Arcibaldo & Petronilla, uno dei fumetti più popolari tra le due guerre, prima dell'esplosione dell'universo-Disney.
La storia di Tintin si intreccia profondamente con quella del suo creatore, Hergé. A poco più di 20 anni, giovanissimo, aveva cominciato a lavorare come illustratore grazie ad un religioso, l'abate Norbert Wallez, che vede in lui un ragazzo dotato, in grado di coinvolgere i più giovani col suo segno. Padre Wallez era fortemente impegnato a rendere il cristianesimo cultura, senza trascurare affatto la cultura giovanile e popolare. Aveva fondato un giornale, Le Vingtième Siècle, che rappresentava la voce più importante del cattolicesimo belga, un cattolicesimo robusto, appassionato, impegnato a difendere le ragioni della fede contro gli assalti delle ideologie atee e materialistiche, nonché da quel «nemico interno» della Chiesa che era il modernismo, l'ideologia che era stata combattuta con forza da papa Pio X ma che sarebbe sopravvissuta nel corso del Novecento ai provvedimenti disciplinari e sarebbe diventata il progressismo cattolico.
Hergé era un cattolico convinto, solidamente formato, che aveva frequentato il movimento scoutistico, e sicuramente questa esperienza si travasò nel suo Tintin, che ha indubbiamente uno spirito da esploratore, intrepido e determinato, tipico dello scoutismo delle origini. Accettò quindi molto volentieri l'invito di padre Wallez a combattere la buona battaglia in campo culturale, e fu quindi sulle pagine del Petit Vingtième, supplemento del quotidiano cattolico, che partì la grande avventura di Tintin, che non fu l'unico personaggio di Hergé ma sicuramente il più noto. Padre Wallez aveva chiesto a Hergé che attraverso Tintin si proponesse ai ragazzi un modello di eroe positivo, virtuoso, che incarnasse i valori cristiani. Hergé eseguì, interpretando tuttavia questa indicazione in un modo originale, assolutamente priva di clericalismo o di moralismo. Curiosamente, non ci sono mai ostentazioni di fede da parte di Tintin. Così come nel già citato Tolkien, i valori cattolici sono impliciti nel modo di essere, di comportarsi, di agire del suo eroe. Non serve un'apologetica teorica, non serve fare filosofie: Tintin è virtù in azione. Con il suo comportamento sempre limpido e coerente mostra nei fatti cosa voglia dire vivere secondo certi principi. Wallez fu assolutamente soddisfatto dell'esito, e Hergé poté continuare per anni a dare vita alle avventure del suo personaggio.
Alla fine della guerra, Hergè conobbe il momento più difficile: il fatto di essere un cattolico conservatore, di aver conosciuto e frequentato un personaggio come Leon Degrelle, fondatore del rexismo, un movimento cattolico di destra, portò ad accuse di collaborazionismo, nonostante avesse solo pubblicato avventure a fumetti per bambini, e conseguentemente rischiò il carcere, se non la vita. Ma in suo aiuto arrivò inaspettatamente Raymond Leblanc, un ben noto partigiano che voleva fondare un settimanale per ragazzi dandogli proprio il nome di Tintin, che testimoniò in suo favore. Hergé potè così continuare a lavorare, e a creare le storie del suo eroe solare, il ragazzo dall'inconfondibile ciuffo all'indietro.
La rivista Tintin diventò una fucina di talenti, da cui uscirono i migliori fumetti di produzione europea degli anni Cinquanta e Sessanta: l'asso dell'aviazione Dan Cooper, il detective Ric Roland, il campione automobilistico Michel Vaillant, Blake e Mortimer e tanti altri, sempre sotto la supervisione artistica di Hergé. Alla sua morte- avvenuta nel 1983- Tintin non ebbe più un seguito, pur continuando a vendere ininterrottamente le ristampe delle sue avventure, che devono ormai essere considerate un autentico classico.
L'11 novembre di dieci anni fa si spegneva una delle figure più significative del mondo cattolico italiano degli ultimi trent'anni: monsignor Alessandro Maggiolini, teologo, giornalista, vescovo. Un vescovo decisamente «fuori dagli schemi», come recita il sottotitolo della biografia che gli ha dedicato il giovane studioso Daniele Premoli, Alessandro Maggiolini, edita da Ancora.
Un vescovo che fu un vero segno di contraddizione: fu tra i primi (e pochi) prelati della Conferenza episcopale italiana a vedere il lato oscuro dell'emigrazione di massa, a porsi il problema del confronto con l'Islam, a denunciare la secolarizzazione dilagante e la crescente insignificanza dei cattolici nella società e nella politica. Era stato definito «il vescovo della Lega» negli anni Novanta, quando con una delle sue proverbiali, acute battute aveva detto che l'unità d'Italia non era un dogma di fede. Era stato etichettato come integralista, conservatore, ma fu soltanto (e scusate se è poco) un uomo di Dio, innamorato di Gesù Cristo, pronto a testimoniarlo sempre, dal pulpito come dai tanti libri che scrisse, o dalle frequenze della radio, dove per anni condusse una seguitissima trasmissione, Ascolta si fa sera, che ogni sera dopo il giornale radio delle 19 scaldava i cuori degli ascoltatori.
Monsignor Maggiolini, milanese di Bareggio, godette della fiducia e della stima di due grandi pontefici, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il primo lo volle vescovo, prima a Carpi e poi a Como. Lo chiamò anche - unico italiano - a far parte della commissione di esperti che scrisse il catechismo della Chiesa cattolica, uscito nel 1992, un testo che nella Chiesa attuale sembra purtroppo dimenticato, se non volutamente ignorato. Il gruppo di esperti- teologi e vescovi - di cui Maggiolini faceva parte - era coordinato dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, l'allora cardinale Joseph Ratzinger. Con lui Maggiolini mantenne un rapporto di collaborazione e di rispettosa amicizia anche quando questi divenne papa Benedetto XVI.
Un altro grande amico del prelato lombardo fu il cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo di Bologna. Erano quasi coetanei (Biffi del 1928 e Maggiolini del 1931) cresciuti entrambi nell'alveo della grande tradizione ambrosiana, uomini di grande fede e grande cultura, allievi di quell'eccezionale maestro che era stato il cardinale Giovanni Colombo. Biffi e Maggiolini condividevano uno stile intelligente e umoristico: un umorismo tagliente anche se sempre rispettoso dell'interlocutore, ma prima di tutto rispettosi della verità. Uno stile che potremmo definire chestertoniano. Erano anche maestri di autoironia: «Senza un po' di umorismo anche un vescovo diventa pericoloso», disse un giorno Maggiolini, dopo essere stato «ridotto allo stato episcopale», come ebbe a dire rincarando ulteriormente la dose di humour.
Quando il monsignore-giornalista aveva ricevuto l'ordinazione episcopale nel bel Duomo di Carpi, si era sentito dire dal cardinale Baggio: «Tu agirai e parlerai in persona Christi, e ti impegnerai solennemente a custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione della Chiesa, responsabilità che assumerai in prima persona». Monsignor Maggiolini prese queste parole estremamente sul serio, e diventò un apologeta appassionato, documentato, tanto più credibile in quanto assolutamente credente in quella fede che predicava. Era una personalità forte che non passava inosservata e che lasciava sempre il segno. Amava dibattere, confrontarsi, e non si sottraeva allo scontro, se necessario. Non solo con quelli che potevano essere considerati degli avversari, ma anche con gli amici. Non le mandò a dire nemmeno a don Giussani, il fondatore del potente (e a volte imbarazzante) movimento di Comunione e liberazione.
Fin dagli anni Ottanta disse e scrisse in un linguaggio ecclesialmente scorretto. Quali sono le priorità di un pastore, si chiese in un articolo del 1985. «Dovrei parlare in primo luogo di droga e delinquenza. Poi di Terzo Mondo. Poi di disuguaglianza e ingiustizia. Poi di disarmo eccetera. Questioni sacrosante. Non so se percepite in collegamento con Gesù Cristo. Di questo passo la fede finisce per incidere sempre meno sulla vita». Per il vescovo, che da Carpi era poi passato nel 1989 a Como, la fede non deve rinunciare a dare un proprio giudizio sugli avvenimenti e non si deve ritrarre dall'impegno di rendere sempre più umana la società, con la certezza che «Cristo non ha bisogno di mendicare nulla dalle ideologie per redimere e promuovere l'uomo in tutte le sue dimensioni». Disse chiaramente che i cattolici non devono essere ossessionati dal rincorrere il nuovo e il facile, ma devono offrire una proposta di vita limpida e risoluta, offerta con cordialità. Parole che ancora oggi - in particolare nell'odierna crisi della Chiesa disorientata e confusa - appaiono come straordinariamente lucide e vere.
Per monsignor Maggiolini la fede non doveva restare un fatto intimo, magari anche un po' folkloristico, ma doveva farsi cultura. Le prese di posizione di questo grande e schietto comunicatore non potevano piacere a tutti, tantomeno ai cristiani impegnati nell'autodissoluzione della propria identità. Alla fine degli anni Novanta il vescovo affrontò profeticamente, tra i primi a farlo, il tema dell'immigrazione. «Il dovere di ospitalità», scrisse nel Discorso alla città» del 1999 , «non va confuso con un presunto dovere di lasciar invadere la nostra terra». E ancora: «I clandestini non sono tutti e per principio esuli perché perseguitati politici. Non vale né ignorare il fenomeno, né reagire a esso in modo risentito, globale e irrealistico, né idealizzarlo quasi una situazione multietnica fosse positiva e migliore e anzi ottima per principio». Riflessioni che sono state dimenticate se non addirittura ribaltate dai più recenti indirizzi episcopali, appiattiti sulla vulgata globalista, o teorizzanti le opportunità del «meticciato» .
Monsignor Maggiolini difese sempre il diritto-dovere dei cattolici di annunciare Cristo, di testimoniarlo nella società come Colui che porta la salvezza, cioè la risposta alle domande che sono nel cuore di ogni persona. Per questo vedeva il maggior pericolo per la fede cattolica non tanto nell'islam, quanto nella secolarizzazione, Nell'avanzare di una cultura laicista sempre più intollerante. Due anni prima di morire, in un'intervista, parlò della gravità della situazione italiana, che descriveva «di un'incoscienza tale per cui siamo di fronte a una sorta di suicidio nazionale». Un'Italia in preda ad un'ansia di suicidio, sul baratro e preoccupata solo di divertirsi. «Sazia e disperata», avrebbe detto il suo amico Giacomo Biffi. «Quando sento che per descrivere un laico si dice: è uno che vuole l'aborto, l'eutanasia…Uno così si presenta come paladino del futuro, ma in realtà è un becchino. Lo vuole distruggere, il futuro. È il pensiero debole, il dubbio su tutto, il rifiuto di qualsiasi norma morale che l'uomo contiene in sé e gli indica gli orientamenti di fondo. Io dico che una civiltà così ha soltanto il dovere di morire. Anche il diritto, ma soprattutto il dovere. Perché non si capisce cosa stia facendo di utile».
Un messaggio che può sembrare pessimistico, ma che in realtà, a dieci anni dalla morte di questo grande uomo di Chiesa, ci appare semplicemente come realistico. E se è vero che già dieci anni fa monsignor Maggiolini scriveva che stiamo vivendo il «tempo dell'agonia della Chiesa», egli fino all'ultimo invitò ad avere coraggio e a sforzarci di tenere viva la fiamma della fede.
Il 5 novembre l'Inghilterra festeggia una ricorrenza tutta sua, con fuochi e maschere che sembrano un prolungamento di Halloween. Ciò che si festeggia è la definitiva sconfitta delle speranze dei cattolici inglesi di fermare le spaventose persecuzioni avviate sotto il regno di Elisabetta: il Guy Fawkes day.
Questa storia ebbe luogo 400 anni fa, nel 1605. Guy Fawkes era un soldato inglese, nativo dello Yorkshire. Apparteneva alla piccola minoranza di inglesi rimasti cattolici, nonostante le durissime persecuzioni che per questo dovevano subire. Vivevano la loro fede nella clandestinità, oppure erano costretti ad andare in esilio. Fawkes fu uno di questi: decise di infatti di lasciare l'Inghilterra e offrire la propria spada di ufficiale a un sovrano cattolico, esattamente l'imperatore d'Austria, sotto il quale servì per diversi anni in vari conflitti, maturando una notevole esperienza nell'uso della polvere da sparo.
Nel 1603 alla regina Elisabetta succedette l'imbelle Giacomo Stuart, che era stato posto sul trono dagli oligarchi inglesi, primo fra tutti il luciferino lord Salisbury, Robert Cecil, figlio di quel William Cecil che era stato l'anima nera del tirannico regime elisabettiano, il fondatore dei famigerati servizi segreti della regina, il feroce persecutore dei cattolici. Le leggi penali avevano disintegrato la Chiesa in Inghilterra, e chi le era rimasto fedele era costretto alla clandestinità.
I cattolici avevano riposto molte speranze in Giacomo, che era figlio di Maria Stuarda, la regina martire di Scozia, ma presto le loro attese furono frustrate. Un gruppo di cospiratori decise che bisognava rovesciare la tirannia con un attentato. Si progettò così di uccidere con un'esplosione il re e tutti i membri del Parlamento, mentre erano riuniti nella Camera dei Lord per l'apertura delle sessioni parlamentari dell'anno 1605. Fawkes, che aveva considerevoli esperienze militari e una buona conoscenza degli esplosivi, era entrato a far parte del piccolo gruppo di congiurati. Sembra che egli non avesse alcun ruolo di guida, ma fosse solo quello di esecutore materiale dell'attentato.
I cospiratori presero in affitto una cantina sottostante al Parlamento; Fawkes aiutò a riempire la stanza con polvere da sparo, che fu nascosta sotto suppellettili varie. I 36 barili si stima contenessero 2.500 chili di polvere. Si pensa che il piano originale prevedesse lo scavo di una galleria che partisse dalla cantina, per posizionare gli esplosivi esattamente sotto la sala delle riunioni della Camera dei lord. L'esplosione avrebbe potuto ridurre in macerie molti degli edifici del complesso di Westminster.
La notte tra il 4 e il 5 novembre 1605 il complotto venne sventato: Fawkes fu arrestato nella cantina da un drappello di uomini armati. In suo possesso furono trovati un orologio, fiammiferi e carta per l'accensione. Prima dell'arresto alcuni cospiratori erano preoccupati per i cattolici che sarebbero stati presenti in Parlamento il giorno dell'attentato, così che cercarono di avvisarli di tenersi lontani da Westminster. Le autorità si insospettirono e diedero inizio alle indagini che portarono alla scoperta, nei sotterranei, delle polveri pronte per esplodere.
Fawkes fu fatto confessare dopo giorni di torture, rivelando i nomi degli altri cospiratori, e raccontando dettagliatamente del complotto. Il processo fu, per così dire, puramente simbolico, poiché le sentenze erano già state predeterminate.
Il 31 gennaio 1606 Fawkes e le altre persone implicate nella cospirazione furono portate al Old Palace Yard a Westminster, dove furono impiccati, decapitati e squartati. Da allora ogni 5 novembre in Gran Bretagna viene festeggiato il fallimento dell'attentato nella cosiddetta Notte di Guy Fawkes, nella quale viene bruciato su un falò un pupazzo che simboleggia l'attentatore.
Inoltre ogni 5 novembre, secondo la tradizione, dei soldati vestiti con le divise del tempo percorrono in lungo e in largo i corridoi di Westminster facendosi lume con vecchie lanterne, come se fossero alla ricerca dell'attentatore. In Inghilterra non si celebrano molte feste, ma guarda caso nel giorno di Guy Fawkes ragazzi e ragazze, con la faccia dipinta di nero, nasi rossi, vestiti troppo larghi e troppo lunghi e cappelli ammaccati sulla testa vanno in giro in gruppetti di due, sei o otto chiedendo denaro per acquistare razzi e mortaretti con i quali festeggiare e bruciare l'effigie di Guy Fawkes.
Ma le cose andarono proprio così, come racconta la narrazione ufficiale? La studiosa Elisabetta Sala, nel suo romanzo L'esecuzione della giustizia, D'Ettoris editore, ci fornisce una versione molto diversa. La Sala, docente di storia e letteratura inglese e autrice di diversi preziosi saggi sull'epoca di Enrico VIII, di Elisabetta I e di William Shakespeare, in questo romanzo riscrive la tragica vicenda di questa sedicente congiura papista. La storia — si sa — è scritta dai vincitori, ma per il suo romanzo Elisabetta Sala ha utilizzato non solo la sua fantasia, ma anche alcune antiche e rimosse fonti, che dicono che le cose andarono molto diversamente.
Il mancato attentato del 5 novembre 1605 non sarebbe stato altro che una terribile trappola ordita dai vertici dello Stato: l'arresto di tutti i membri del «complotto», l'individuazione del mostro principale in Guy Fawkes e l'ombra delle trame gesuitiche, diede l'occasione al governo di Sua maestà di mettere in atto una sorta di «soluzione finale» della presenza papista in Gran Bretagna.
La narrazione della Sala è immediatamente avvincente, come un giallo o un thriller. Ci conduce nella Londra del tempo con una ricostruzione ambientale perfetta, frutto delle sue profonde conoscenze storiche, ci fa respirare il clima terribile che si viveva sotto uno dei peggiori regimi totalitari della storia. Ma oltre l'angoscia per la persecuzione, la paura della delazione, la minaccia costante dell'arresto, della tortura, della morte, o della rovina economica, i procedimenti di «rieducazione» dei figli dei congiurati, la speranza non muore. A tenerla accesa ci pensano i coraggiosi recusants, coloro che resistono nella clandestinità. E tra questi c'è William Shakespeare, la cui figura giganteggia discreta nel romanzo. Will è un maestro, un artista ispirato e adorato dal popolo, ma è anche un vero e proprio punto di riferimento per la dissidenza, per coloro che non vogliono arrendersi al regime. Le sue opere lanciano messaggi in codice, contengono scomode verità criptate nelle tragedie, da Romeo e Giulietta a Macbeth fino alla Tempesta. Il potere lo sa, e cerca disperatamente di incastrarlo, di trovare le prove della sua clandestina cattolicità per poterlo finalmente trascinare sul patibolo. Ma Will continuerà a farsi beffe di loro.
Un romanzo commovente, intrigante, appassionante, che alla fine raggiunge lo stesso scopo che si era prefisso Shakespeare: tener desta la coscienza del lettore, far sì che si ponga domande e cerchi la risposta.